Religione
Il cattolicesimo queer di Michela Murgia
Femminista e cattolica, Michela Murgia ha cercato di rovesciare il patriarcato attraverso una reinterpretazione radicale del dogma centrale del cristianesimo: la Trinità. Non “due uomini e un uccello”, come nella tradizione occidentale, ma tre figure asessuate, in una posizione aperta, orizzontale, non gerarchica, come nell’icona di Andrej Rublev. Il cui significato profondo è che l’amore autentico è quello che include il terzo. Una reinterpretazione nella quale tuttavia permane la tendenza cattolica, e violenta, di dire cos’è il vero amore, e dunque come bisogna amare.
Una diversa interpretazione
Otto marzo del 2009. In un piccolo paese della Barbagia la sindaca chiama alcune donne a ragionare di Donne e Chiesa: un risarcimento possibile? Al tavolo c’è anche il giovane parroco del paese, che alla fine prende la parola per dire che sì, ha apprezzato l’intervento delle relatrici, ma quanto detto non riguarda la sua parrocchia, nella quale – lo rivendica con orgoglio – c’è ben altro clima, come dimostra il fatto che molte donne collaborano nell’attività parrocchiale. Ma una voce – una voce di donna – si leva dalla platea: “Per pulire, don Marco!”
È la scena, esilarante, con cui comincia Ave Mary. E la Chiesa inventò la donna (Einaudi, 2011) di Michela Murgia, che è un brillante e, per una donna cattolica, coraggioso atto di accusa nei confronti di una Chiesa che non riesce a pensare le donne se non come addette alle pulizie delle parrocchie o madri amorevoli e spose sottomesse. Si tratta di una analisi dura, senza sconti. E leggendo ci si chiede quando arriverà il momento in cui l’autrice spiegherà perché essere cattolici, appartenere a quella istituzione così violentemente maschilista, sia comunque sensato per una donna, anzi per un essere umano. Il momento arriva, ma non convince, per ragioni che proverò a spiegare. Vediamo intanto l’analisi critica di Murgia.
Il cristianesimo eredita dall’ebraismo una visione radicalmente negativa del femminile: Eva è la vera responsabile del peccato e della caduta del genere umano; su di lei pesa una colpa tale da schiacciarla, un debito che non può essere saldato e che pertanto, osserva Murgia, pone la donna nella stessa condizione in cui si sono trovati per secoli coloro che non potevano restituire i debiti: la schiavitù.
Nel cristianesimo tuttavia la negatività di Eva è compensata dalla positività di Maria, la donna che ha detto di sì a Dio e in questo modo ha consentito la nascita di Gesù, ossia la salvezza. Ma chi è Maria? Nell’economia della salvezza il suo ruolo è quello di colei che ha partorito: ed è solo in quanto partoriente che può riscattare il suo genere. Alle donne la cristianità chiederà questo, dunque, e null’altro: di partorire (con sofferenza), essere madri, adeguando il modello di purezza (e si sottomissione) di una donna peraltro troppo distante nella sua perfezione (enfatizzata dal dogma dell’Immacolata concezione) per poter costituire un modello reale di femminilità.
La riduzione della donna al suo ruolo di madre e moglie più o meno sottomessa sarà confermata nel 1988 dall’enciclica Mulieris Dignitatem di Giovanni Paolo II, con l’affermazione di una “naturale disposizione sponsale della personalità femminile”, una vocazione che si può manifestare in senso stretto o anche in modo simbolico e spirituale, come servizio nell’ambito di un cammino di consacrazione.
Ma perché una donna non dovrebbe ribellarsi a tutto ciò? Murgia sembra rispondere che la vera ribellione non è nel rifiuto del cattolicesimo, ma in una diversa interpretazione, mossa dalla fiducia che la violenza culturale verso le donne non appartenga per essenza al messaggio di Cristo, ma sia l’esito di una interpretazione maschile.
In Ave Mary uno spiraglio Murgia lo trova nella parabola della dramma smarrita (Luca, 15, 8-10). Una donna ha dieci dramme. Ne perde una. La cerca, accende la lucerna e spazza il pavimento. Quando la trova chiama le amiche e le invita a rallegrarsi con lei. Una donna sola che chiama altre donne per rallegrarsi. “Donna, sola e padrona di mezzi: questa è la protagonista della storia della dramma raccontata da Gesù”, scrive Murgia. E poiché questa, come altre parabole, indica l’operare di Dio, non abbiamo qui una parabola che parla di Dio al femminile?
Può essere. Ma la parabola precedente è quella del buon pastore, che abbandona il gregge per cercare la pecora smarrita. E per quanto la tradizione iconografica cristiana abbia fin dall’antichità raffigurazioni di Cristo come pastore, nessuno ha mai pensato che davvero Gesù si pensasse come un pastore; né il proliferare in ambito cristiano di pastori ha avuto mai molto a che fare con la pastorizia effettiva. Non so quanto successo avrebbe un movimento di rivendicazione della pastorizia che si appellasse a quella parabola.
E del resto che fosse poco Murgia lo aveva compreso bene. In God save the queer. Catechismo femminista (Einaudi, Torino 2022) va al cuore stesso della teologia cristiana: la Trinità.
Oltre Dio Padre
Il sottotitolo del libro, Catechismo femminista, non va inteso nel senso che Murgia faccia un catechismo, ossia una esposizione per domande e risposte, del femminismo, ma nel senso che tenta una lettura femminista e queer del Catechismo della Chiesa cattolica.
Il Dio del cristianesimo è un Padre. Con un’affermazione che avrà fatto e farà sobbalzare più di qualche lettore sulla sedia, Murgia afferma che il Padre nostro è la preghiera, tra quelle cristiane, di cui farebbe volentieri a meno. “Per il femminismo e per chi pratica una prospettiva queer, la definizione di Dio come solo, padre e onnipotente è il punto più problematico del Credo.” Ed è comprensibile; ma quella preghiera è stata istituita da Cristo stesso, con le parole: “Voi dunque pregate così” (Matteo 6,9).
C’è per Murgia un fraintendimento al centro della dottrina cattolica. Dio viene fatto coincidere con un “anziano patriarca”, il vecchio dalla lunga barba della Creazione di Adamo di Michelangelo e di tante opere, capolavori o statue di gesso abbandonate in qualche malandata chiesetta barocca, della tradizione cattolica.
Ma Dio, incalza Murgia, è altro e altrove. Il Dio cristiano non è un Padre, perché non è uno, e nemmeno due. È trino. Ed anche qui, si tratta di interpretare. Cos’è la Trinità? Con squisita ironia Murgia scrive: “Non è necessario essere femminista per intuire che c’è qualcosa che non va in una rappresentazione del divino espressa attraverso due maschi e un uccello”. Se la Trinità fosse davvero quella, scrive, bisognerebbe “abbandonare il cristianesimo senza ripensamenti”, o perfino girare con una bomboletta spray per “dissacrare con furia iconoclasta” quella rappresentazione – patrioska, la chiama – di Dio, evidentemente contigua al patriarcato, specchio celeste del potere maschile sulla terra.
Ora, non si tratta di cancellare qualsiasi rappresentazione di Dio, perché Islam e ebraismo, che non si rappresentano Dio, non sono meno maschilisti del cristianesimo. Si tratta di interpretare diversamente la Trinità. E la risposta per Murgia è nella nota icona della Trinità di Andrej Rublëv.
La Trinità queer
Nell’icona abbiamo tre figure, tre esseri angelici molto simili tra loro, di cui è impossibile dire se siano maschi o femmine. Sono seduti intorno a un tavolo, con una postura circolare priva di gerarchie. E al tavolo c’è un posto libero. Quello nel quale sembra essere invitato a collocarsi chi guarda l’opera.
Nessuna identità di genere, dunque; nessuna gerarchia. E nemmeno una divisione netta tra il piano divino e quello umano. In quell’icona Murgia trova una sorta di Trinità queer, aperta e accogliente. La leva per una nuova interpretazione. Si tratta di una lettura della Trinità per la quale Murgia è ampiamente debitrice – e lo riconosce – nei confronti di Teresa Forcades, monaca benedettina femminista e sostenitrice di una teologia queer (di cui si veda, sul tema specifico della Trinità, La Trinità, oggi, Castelvecchi, 2021).
Ed è una interpretazione di cui non si può dire granché. La Trinità è come le nuvole: qualcuno vi vedrà un carro, qualche altro una donna, qualche altro ancora un uomo con la barba. O, per dir meglio, è un po’ un test di Rorschach: ciò che vi si vede è la proiezione della propria personalità. Di fatto è difficile negare che si tratti di una concezione tanto centrale e fondante nella teologia quanto lontana dall’esperienza religiosa effettiva dei credenti, per i quali sono ben più significative figure come la Madonna o perfino i santi, che hanno un aspetto identificabile e una storia.
Per Murgia invece questa Trinità reinterpretata in ottica queer è cosa concretissima. Ha a che fare con l’aspetto più importante della nostra vita: chi e come amiamo.
La dinamica intrinseca dell’amore
Per secoli, in Occidente, abbiamo fondato metafisicamente l’etica. Abbiamo, cioè, legato le nostre scelte all’essenza stessa della realtà. La domanda angosciosa sul perché del bene – perché dobbiamo essere giusti, in un mondo in cui spesso il giusto è perseguitato e il malvagio prevale? – trovava una risposta semplice: perché Dio è giusto. L’azione etica si inserisce nel piano della realtà e ci pone in accordo con la sua origine. Chi fa il bene è a posto nell’essere.
Questa visione rassicurante è entrata in crisi a partire dalla fine dell’Ottocento. La filosofia di Hegel è l’ultimo grande tentativo di inserire la nostra piccola vita in un piano razionale dell’universo. Noi viviamo invece nell’ombra della morte di Dio annunciata da Nietzsche, siamo condannati a cercare un senso alla nostra vita e un perché alle nostre azioni in un universo che è indifferente al bene e al male.
Questo evidentemente non vale per un cattolico, che continua a credere che al fondo dell’essere vi sia un Dio e che le nostre scelte debbano avere a che fare con questo Dio. Se queste sono in contrasto con quelle che la tradizione ha sempre considerato volute da Dio, bisognerà reinterpretare Dio. Ed è quello che fa Murgia.
Se Dio è Trinità, e una Trinità queer, non sessuata, accogliente, come dobbiamo vivere per accordarci con una simile origine? Per Murgia la Trinità queer ci indica la via del vero amore. Che non è quello del singolo, perché “Il numero uno rende sol3”, e nemmeno quello della coppia, ma quello della triade. Se il singolo è solo, la coppia rischia costantemente la chiusura al mondo esterno, “in un gioco di rimbalzi intimi”. E dunque:
Era il numero tre, il fulcro, perché introduceva la necessità dell’inclusione e imponeva lo spostamento costante dello sguardo: qualunque soggetto della Trinità di quell’opera [l’icona di Rublëv] deve avere sempre presente contemporaneamente anche gli altri due. Li ama entrambi, non uno per volta, e non lo fa in modo scalare, ma paritario.
Come ogni persona della Trinità ama l’altra nella raffigurazione circolare e orizzontale dell’icona di Rublev, così è possibile amare in una famiglia queer. La Trinità è il prologo in cielo di una scena che dovrà svolgersi qui sulla terra. La scena dell’amore vero. Che è sempre caratterizzato dalla presenza del terzo. E qui Murgia cita Teresa Forcades:
L’esperienza amorosa dell’io e del tu è diversa, non può essere condivisa. Soltanto quando amano una terza persona, l’io e il tu condividono completamente la stessa esperienza di amore e ciò reca loro la completa felicità e porta a compimento la dinamica intrinseca dell’amore.
A fare difficoltà, in questo testo, è quel soltanto. Che riduce la complessità, la ricchezza e anche l’inevitabile, dolorosa contraddittorietà dell’amore umano a un unico modello, dal presunto fondamento metafisico. Un gesto teologico e politico che è violento, perché violente sono le conseguenze possibili sulla vita delle persone reali, cui si chiede di pensarsi avendo come modello le Persone divine.
L’indole naturale
Scrive ancora Murgia:
Intuite le miserabili conseguenze di un amore che si ferma al numero due, perché chi pratica la fede nella Trinità non ha aperto come una noce il concetto di coppia, ma lo ha anzi sacralizzato attraverso un sacramento, quello matrimoniale, inventato di sana pianta fuori tempo massimo?
Si potrebbe rispondere che, banalmente, l’esperienza cristiana ha abbastanza presto marginalizzato la Trinità, troppo astratta e difficile da comprendere, in favore di figure più concrete e personali. Ma soprattutto sembra – ed è davvero curioso – che a Murgia sfugga che per la Chiesa cattolica la coppia consacrata dal sacramento matrimoniale non è chiusa in sé, ma aperta a quel terzo che è il figlio. Si legge nel Catechismo della Chiesa cattolica (par. 1652)
Per sua indole naturale, l’istituto stesso del matrimonio e l’amore coniugale sono ordinati alla procreazione e all’educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento.
E poco dopo: “Il rifiuto della fecondità priva la vita coniugale del suo ‘preziosissimo dono’, il figlio” (par. 1664). Ed è chiaro che senza questo preziosissimo dono la coppia è manchevole di qualcosa.
Il terzo c’è già. È il preziosissimo dono del figlio, senza il quale l’amore dei coniugi è privo di coronamento e compimento. È bene anche ricordare che questo dono preziosissimo, nella dottrina cattolica, dev’essere ricevuto all’interno del matrimonio. Le coppie che fondano la loro unione solo sull’amore, senza il vincolo del matrimonio (le coppie di fatto), per il Catechismo della Chiesa cattolica (par. 277) costituiscono
un’offesa alla dignità del matrimonio; distruggono l’idea stessa della famiglia; indeboliscono il senso della fedeltà. Sono contrarie alla legge morale: l’atto sessuale deve avere posto esclusivamente nel matrimonio; al di fuori di esso costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla comunione sacramentale.
Si tratta di un vero e proprio odio sociale, che scaturisce da una delle tendenze più malsane dei cattolici: la pretesa di dire a chi cattolico non è come deve vivere la sua vita, amore compreso.
L’intento di Murgia era quello di dimostrare che il mistero centrale del cristianesimo, la natura trinitaria di Dio, può essere interpretato in un modo tale da mandare in crisi qualsiasi visione patriarcale e gerarchica della realtà sociale. L’esito è tutt’altro: finisce per fissare metafisicamente un modello normativo di amore. Appare chiaro, insomma, come il Catechismo femminista di Murgia non si allontani poi troppo dal Catechismo della Chiesa cattolica. Sia qui che lì c’è qualcuno che pretende di dire cosa vuol dire amare, cosa è amore vero e cosa no. Il singolo no. A questo uomo, a questa donna che non hanno trovato la persona giusta, o l’hanno persa, diremo che sono incapaci di amare, chiusi nel loro solipsismo; se non sono tristi ci occuperemo noi di renderli tristi.
Ho studiato a lungo il pensiero di Aldo Capitini. È il filosofo della nonviolenza italiana. Ha insegnato che esistiamo solo in quanto ci apriamo a un tu (“La mia nascita è quando dico un tu”, scrive in Colloquio corale); e che il tu, questo-altro-qui, è la via che conduce all’amore di tutti. Aveva ragione? Le sue idee sono più vere di quelle di Murgia? Non è importante stabilirlo qui. Ma Capitini è stato un uomo che ha vissuto in solitudine, senza moglie né figli. E dunque dovremmo dire, se è vero quello che affermano Murgia e Forcades, che è stato incapace di vero amore. E dire questo è violenza.
D’altra parte le persone sole, incapaci di amore vero, non potranno rivendicare il diritto alla genitorialità. Se manca il terzo, un uomo e una donna come potranno essere un buon padre o una buona madre? Saranno una coppia – genitore e figlio – ma le coppie, dice Murgia, sono chiuse e dunque incapaci di amore vero. Ci figureremo tristi, socialmente sospette anche le coppie che non hanno figli, evidentemente condannate a guardarsi in faccia reciprocamente per tutta la vita, senza mai attingere la capacità di guardare oltre; a meno che un figlio non lo adottino.
A monte di queste conclusioni discutibilissime c’è un difetto di analisi di ciò di cui si sta parlando: l’amore. Che è molte cose. C’è l’amore passionale, che caratterizza le relazioni al loro inizio, ed al quale subentra con gli anni un amore che assomiglia più all’amicizia, fatto di condivisione della quotidianità, delle idee e dei valori. E c’è l’amore inteso come volere il bene di qualcuno, quello che i buddhisti chiamano metta, e che è possibile quali che siano i propri rapporti sentimentali, e anche in assenza di qualsiasi rapporto sentimentale.
Aut aut
Anche qui, insomma, come nella quasi totalità della letteratura cattolica, c’è qualcuno che ci dice cosa è il vero amore, cosa sono le vere relazioni, eccetera. Nel caso di Murgia, però, c’è una aperta contraddizione con le premesse del suo discorso, che sono in una certa rappresentazione del cattolicesimo come grande casa accogliente. Echeggiando Mounier, scrive: “Decidere da che parte stare è un atto disumano, perché gli esseri umani sono sia da una parte sia dall’altra. Per la Chiesa il sigillo della fede si ritrova molto più riconoscibilmente nella pratica dell’et-et, che spesso tiene insieme verità in apparenza contraddittorie”.
Che sia disumano decidere da che parte stare è discutibilissimo (se da una parte ci sono i fascisti o i nazisti, posizionarsi dall’altra parte è umanissimo, e non c’è et et che tenga), ma soprattutto la pratica dell’et et, con buona pace di Mounier, è improbabile per un cristiano e segnatamente per un cattolico. Perché il cristianesimo è, in essenza, una religione diabolica. Al centro della fede cristiana c’è la separazione: di qua Dio, di là il Diavolo; di qua quelli che riconoscono che Gesù è il Cristo, e che saranno salvati, di là quelli che lo negano, e che saranno dannati (e lo sono, invero, fin d’ora). Tanto radicata è la logica diabolica in un cristiano, che non può sfuggirle nemmeno quando ci si propone di farlo. Ed è così che Murgia, qualche pagina dopo l’evocazione dell’et et, distingue la vita cristiana dalla vita cristianizzata: la prima, afferma, ha un credo, ossia una ortodossia, mentre la seconda ha un galateo, ossia un’ortoprassi. E riguardo a questa seconda scrive:
il cristianesimo come opzione solo culturale ha creato un esercito di spietati atei devoti che praticano la morale altrui più volentieri della propria.
C’è da darle ragione. Ma ragionare così non vuol dire operare un taglio netto nello stesso mondo cristiano? Murgia non sta decidendo di stare dalla parte della vita cristiana? Non sta mettendo da una parte gli spietati finti cristiani e dall’altra i veri credenti? E non è questa stessa azione disumana?
La critica serrata del cristianesimo maschilista e patriarcale – della interpretazione maschilista e patriarcale del cristianesimo, evidentemente – non si spinge fino a mettere in discussione il giudizio. Scrive:
Per questo motivo è Gesù Cristo, e non Dio Padre, il giudice apocalittico assiso sul trono alla fine del mondo, colui che separerà le pecore dalle capre, i giusti dai perduti, la gramigna dal grano buono.
Non interessa qui, ora, per quale ragione sia Gesù e non il Padre a giudicare. È notevole invece che a Murgia sfugga il carattere violento di questa separazione delle pecore dalla capre, della gramigna dal grano buono. C’è motivo di credere che sia questa convinzione, questo dispositivo diabolico di fondo, la causa di gran parte della violenza che caratterizza la storia della cristianità e che è ben lontana dall’essere superato. Se si vuole cogliere alla radice la violenza cristiana, è qui che bisogna mettere le mani. Più che riconsiderare la Trinità, considerare il rapporto che essa ha con il Quarto: il Diavolo. Che in Occidente è sempre stato il simbolo, lo shibboleth che ha identificato coloro che era possibile porre al di fuori della sfera dell’umano, e che dunque erano massacrabili. Una dinamica violentissima di cui le donne sono state tre le prime vittime. Ma a Murgia il Diavolo non interessa.
Un problema politico
Murgia e Forcades dimostrano che è possibile, in qualche misura e con qualche forzatura, dare una lettura femminista e queer di una parte della Bibbia. Allo stesso modo è possibile darne una lettura maschilista e patriarcale, fascista, nazista. O ancora: anarchica (Tolstoj ed Ellul). Nella Bibbia, come negli altri testi sacri, esistono molteplici semi, ed è sempre possibile scegliere quali far germogliare e quali no. Ma a condizione di essere liberi religiosi, alla maniera appunto di Tolstoj (o, in Italia, di Aldo Capitini, per il quale Gesù era un maestro di fare aperto). Murgia però non è una libera religiosa; è una cattolica. Questo vuol dire che non rivendica una libera interpretazione della Bibbia e del Vangelo e l’altrettanto libero rifiuto di ciò che si ritiene inaccettabile. Si colloca invece in una tradizione precisa e in un preciso contesto istituzionale: la tradizione della Chiesa cattolica. Vi si pone in modo critico, ma una critica che non può andare oltre certi confini ben precisi, pena l’eterodossia. Di cui Murgia ha orrore.
Sia chiaro, non si tratta di stabilire se il discorso sia Murgia sia cattolico o meno. Non spetta a me. Il problema è politico. Lo è, evidentemente, perché in Murgia tutto è politico. E allora le possibilità sono due. O il piano religioso è fondante della prassi politica oppure non lo è. Cioè: o per praticare quella forma di amore occorre davvero credere in un Dio come Murgia lo concepisce oppure si può anche farne a meno.
Nel primo caso si torna a quanto s’è detto. Il discorso di Murgia andrà inserito – molto a malincuore – nella ampia casistica dei discorsi religiosi che pretendono di stabilire cosa è vero amore e cosa no e che soprattutto escludono dal vero amore una parte significativa dell’umanità – tutti coloro che non credono, o che non credono in quel modo.
Nel secondo caso – se, cioè, il piano della prassi politica non ha bisogno di una base religiosa – sfugge il senso di rivendicare l’appartenenza a una istituzione che ancora oggi afferma, nel suo Catechismo, che l’omosessualità è un disordine morale e che le famiglie non sposate sono contrarie alla legge morale. Un simile richiamo al cattolicesimo, comprensibile sul piano personale, diventa ambiguo nel momento in cui si fa scelta politica. Associare una prassi di liberazione a una istituzione autoritaria e violenta può servire ad aprire quest’ultima, ma molto più probabilmente renderà meno credibile la prassi stessa. Perché la Chiesa cattolica ha superato da gran tempo la soglia entro la quale poteva essere ancora considerata una istituzione riformabile, con debolezze gravi ma comprensibili. Quanto è politicamente sensato cercare di far rientrare questo discorso nell’ambito del cattolicesimo? Quante possibilità ci sono che apra nuove strade per la Chiesa cattolica? Quanto perde invece, in termini di forza, il tentativo di far rientrare queste idee in una tradizione che è oggettivamente violenta – anzi, terribilmente violenta?
Una religione diversa?
Il cattolicesimo attuale è l’esito di una serie di liberissime interpretazioni, alcune risalenti ai primi secoli dell’era cristiana, altre – come il dogma dell’immacolata concezione – più recenti. Con altre interpretazioni, anche meno libere e fantasiose, è possibile costruire forme di cattolicesimo radicalmente altre; e il cattolicesimo femminista di Murgia (e Forcades, e altre) è tra questi. Ma si tratta di un conflitto di interpretazioni, e in ogni conflitto di interpretazioni è decisiva la forza. Mai una interpretazione prevale sull’altra in virtù di sé stessa, della sua verità, proprio perché le interpretazioni non sono che interpretazioni: nessuna può arrogarsi il possesso della verità. Una interpretazione prevale se ha dietro una forza politica, sociale o economica che la sostiene. D’altra parte, la stessa interpretazione può servire a coagulare una simile forza che poi la sostiene. Interpretazioni come quelle di Michela Murgia possono intercettare il malessere delle donne cattoliche e unirle in una forza in grado di sostenere quella interpretazione e farla diventare sempre meno minoritaria. È un esito improbabile, ma non impossibile. Al riguardo del quale tornano alla mente le parole di Ratzinger in una intervista (poi ripresa in Rapporto sulla fede, Paoline, 1985), in cui parlando di una interpretazione femminile di Dio affermava:
Ma ciò che il femminismo radicale – talvolta anche quello che dice di richiamarsi al cristianesimo – non è disposto ad accettare è proprio questo: il carattere esemplare, universale, immodificabile della relazione tra Cristo e il Padre. Sono infatti convinto che ciò cui porta il femminismo nella sua forma radicale non è più il cristianesimo che conosciamo, è una religione diversa.
Aveva probabilmente ragione, se si sostituisce cristianesimo con cattolicesimo. Perché la Chiesa è una istituzione in cui il potere maschile è strutturale, e contestare quel potere vuol dire andare al cuore stesso dell’istituzione. Rovesciare il patriarcato ecclesiale, quello che riduce le donne ad addette alla pulizia delle parrocchie, vuol dire rovesciare la Chiesa stessa, far sì che non resti pietra su pietra. È un rovesciamento che piace sognare, a noi non credenti non meno che alle femministe cattoliche. Purtroppo è una gioia che non sembra imminente. Ma intanto bisogna chiedersi se non permanga anche nelle alternative femministe più di qualche residuo della violenza cattolica.

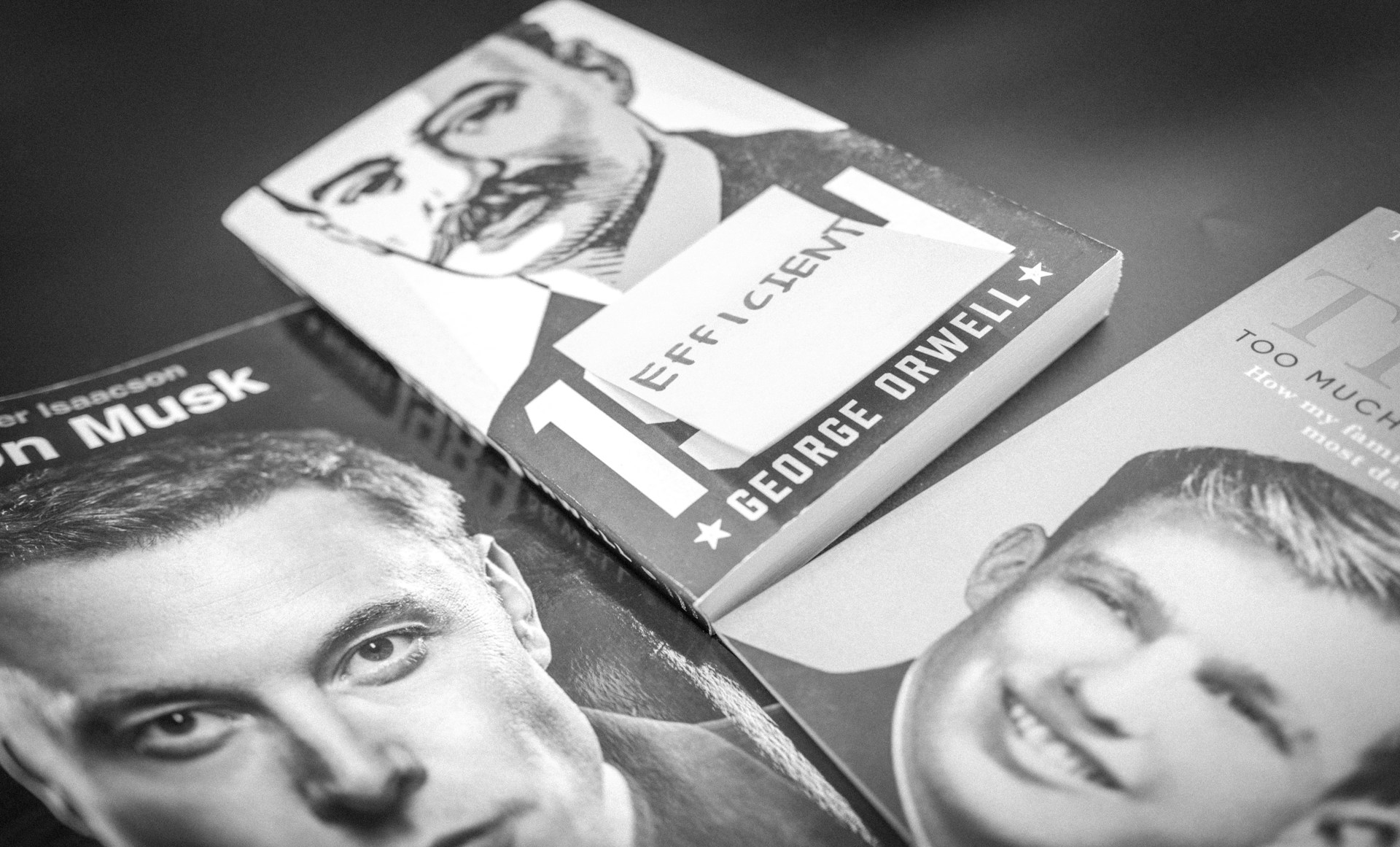

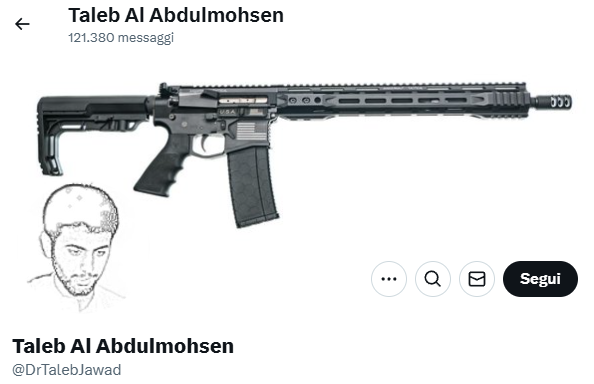

Perché asciugare sempre per terra con interpretazioni di interpretazioni di un testo “sacro” incivile, invece di aggiustare il tubo che perde, cioè ammettere che la superstizione religiosa è dannosa da sempre ed ovunque, in primi per le donne?
Se si vuole far del bene la superstizione religiosa non serve.
Se si vuole lenire un lutto, la superstizione lenisce poco e ti impone tante di quelle norme incivili e costrittive che i benefici diventano meno dei problemi che provoca.
Una donna credente, allo stesso modo di un gay credente, è come una mucca che venera la statua del proprio macellaio e, nel caso specifico lo fa provando semplicemente a cambiare il menù del giorno