Media
La gioia senza gioia
La parola è Schadenfreude ed è una bella parola. Tedesca (per quella grandissima abilità della lingua teutonica di neologizzare sintetizzando concetti in parole-grappolo su cui lessi un piccolo saggio anni fa di Vanna Vannuccini e Francesca Pedrazzi, “Piccolo viaggio nell’anima tedesca”) ma diventata anche inglese. Tanto è vero che il libro che Claudia Durastanti traduce dall’inglese è “Schadenfreude. The Joy of Another’s Misfortune”. L’autrice è Tiffany Watt Smith e in Italia, per la UTET, esce con il titolo “Schadenfreude. La gioia per le disgrazie altrui”.
Penso che ci sia poco da aggiungere o tradurre. La parola è dunque Schadenfreude. La diciamo ancora una volta e poi non la diremo più per non sciuparne la bellezza.
Diremo invece: che la vera parola di cui dovremmo parlare è “pericolosità del giudizio sugli altri” e se c’è un corrispettivo nella lingua della Merkel o di Grass vi pregherei di segnalarmelo.
In questi giorni mi è capitato di riflettere a bassa voce su una questione riguardante i social, scoppiata sui social e lì nutrita, attizzata come un fuoco. Fiamme su fiamme e nessuno capace di spegnerlo. C’è sempre da riflettere sui social e quasi mai la riflessione anche se autorevole, fateci caso, conduce a un miglioramento delle prassi. Persino inutile è attendersi risvegli, riprese, passi indietro anche davanti a marchiane svirgolate. Piuttosto l’asseveramento di una distanza, un’inimicizia, talvolta un’ottusità, un arroccamento tra persone o tra gruppi d’influencer (uso una parola di moda che ben chiarisce però il concetto). Mi sono chiesto come mai anche le migliori intenzioni non portino a migliori esiti specie in un “ambiente” aperto come internet. Il tema è infinitamente semplice e infinitamente sfuggente.
La più grande tenzone social, in fondo, può ridursi in una facile offesa tirata lì indistintamente con spregio dei minimi di netiquette o in una banda di sodali coalizzati contro qualcuno (alcuni) o qualcosa. Il fatto è che sia il bombarolo sotto mentite spoglie che il gruppo organizzato sono già un passo oltre la questione. Il passo prima è il “giudizio” che anima ognuno di loro. Che li spinge al commento, alla critica non necessarie e al compiacersi delle debolezze altrui avendole prima intercettate e ritagliate. Altrui sta per: di una classe o gruppo di cui non facciamo parte e di cui non vorremmo far parte. Di uno da cui vorremmo sentirci accolti.
“Il desiderio – avrebbe detto la Smith – di far parte di quei gruppi sociali che ci tengono al sicuro, e di proteggerli a nostra volta”.
E allora ecco il bullismo social. Facile (l’irrisione di uno scivolone alla paperissima o di uno strafalcione da sciocchezzario alla “io speriamo che me la cavo”) o molecolare (quella che isola un soggetto, un concetto, un aspetto). In un caso come nell’altro essere di più (o più visibili o più autorevoli) per schiacciare chi lo è di meno. La logica del bannare o della nomination prevale su quella del ragionamento in/out. Come se a confrontarsi fossero i numeri: dei like, degli amici, dei follower o – logica altrettanto spietata – dell’autorità degli stessi (cosa che ovviamente funziona in strutture più complesse del semplice gioire di una scivolata su superficie oleosa quale il caso di un professore che fotografa e twitta una parte del suo corpo in genere abbastanza ignota in vece di mandarla in privato alla sua stagista).
Questione di numeri. Scrive la Smith: “Le ted talk più popolari in assoluto – conferenze stimolanti su istruzione, leadership e creatività tenute da esperti internazionali e professori di Harvard – al momento in cui scrivo hanno circa trenta milioni di visualizzazioni. Il video di un padre che riceve un calcio nei testicoli dalla figlia piccola è stato visto da più di duecentocinquantasei milioni di persone nel mondo (finora)”.
Ma è evidente che l’effetto del gioire dell’altrui déifallance ha esiti diversi per casi diversi. In quelli di più largo interesse siamo tutti disposti ad indignarci. Ma ancora una volta sono effetti. Dolorosi e dannosi, talvolta scabrosamente pericolosi come nel caso per porn revenge ma effetti. Per essere un po’ più efficaci non dico scientificamente ma onesti dovremmo interrogarci su cosa causa questa gioia del disprezzo. Il piacere di sapere che qualcuno sta peggio di noi? O che non sta in tutto e per tutto meglio?
Ho sempre avuto una segreta costernazione davanti a chi monta delle telecamere per riprendere svarioni di amati cucciolotti (figlio o cani che siano). Tanta occhiutaggine merita un premio anche negativo. Ma chi premierà il silenzio di chi ride sotto baffi e barba? Chi impalmerà chi si affaccia guarda, irride mosso da sentimenti trascurabili?
L’autocompiacimento, l’amore e l’invidia sono tre capitoli in cui si succedono le analisi della Tiffany Watt Smith. I tre capitoli più interessanti a mio modesto avviso del libro.
Nel primo si parla dello scrittore danese Aksel Sandemose. Sua la “Legge di Jante” (o Janteloven), una buona preghiera laica da mandare a memoria prima di scrivere sui social o sui social di altri che hanno scritto sui social (spesso, ma lo saprete, il peggio compare nei commenti dei commenti):
Non credere di essere tanto speciale, tu.
Non credere di valere più di noi.
Non credere di essere più intelligente di noi.
Non credere di essere migliore di noi.Non credere di saperne più di noi.
Non credere di essere più importante di noi.
Non credere di essere capace di alcunché, tu.
Non devi ridere di noi.
Non credere che a qualcuno importi chi sei tu.
Non credere di poter insegnare qualcosa a noi.
Internet e i social in genere sono (dovrebbero essere) un po’ il luogo libero delle intelligenze aperte. Una sorta di landa sterminata e perciò il posto ideale in cui esercitarsi in brillantezza. E invece spesso il balcone da cui affacciarsi per commentare/criticare il lavoro di altri forti dell’1 pesa 1 che non chiede lauree o competenze o titoli specifici anche se parliamo di vaccini o fecondazione assistita, idraulica, urbanistica, trasformazione casearia, finanza. Un luogo dove un commento arguto può portarti al trend topic sì ma uno brillantemente stupido o mal calibrato alla gogna mediatica. Con lo stesso slancio, uno stesso elastico, in universi paralleli. E non so cosa sia più grave, visto che non credo nella giustizia di popolo e tutto sommato penso che i tribunali abbiano ancora una loro utilità (anche se, alle volte, quanta attesa prima e dopo!!).
La scomoda verità – che è poi quella del libro della Smith – è che qualcosa dentro di noi (molti di noi, ok?) ci porta a provare un piacere sottile nel vedere gli scivoloni di altri. La caduta di uno che si credeva (o credevamo) più importante e realizzato. A un funerale anni fa mi capitò di sentire un addolorato intervenuto usare la locuzione latino-medievale “mors tua vita mea”, un buon incitamento alla competizione ma non nella gara con un morto.
Tutti concentrati sul nostro giudizio, ignari della sua pericolosità dello stesso, siamo naturali gaffeur, spesso manchiamo il punto delle questioni concentrandoci su un aspetto secondario che finisce per essere addirittura infimo se ci stiamo occupando di una cosa che ha implicazioni più grandi e serie del partito che vota o della religione che segue. Settimane fa in una trasmissione che si occupa di scomparsi, altro esempio, mi è accaduto di veder partire un servizio sulla religione della vittima di un tentato femminicidio.
Minuti che investigavano sul culto a cui aderiva la donna quasi uccisa dal marito e, quello che naturalmente viene stigmatizzato come l’atto più efferato concepibile, acquistava una sorta di “attenuazione” in quella caccia alle streghe. Siamo dunque anche naturalmente faziosi e se cade a terra un giocatore della squadra avversaria “deve morire” (come si canta allo stadio). Poi ci commuoviamo per i gattini in una cesta e, se cadono in maniera divertente, possiamo persino riniziare a sorridere. Allontanando la morte (nostra). Ignari se nel fotogramma successivi quei batuffoli rimanevano feriti. O peggio. Già, peggio.

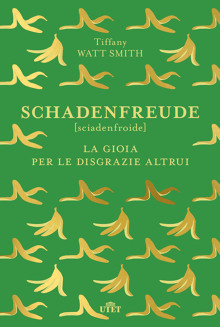
Devi fare login per commentare
Accedi