Media
Gaber, quando il personale è politico
In occasione dell’apertura del Festival Gaber, mi pare giusto rendere omaggio al grande artista, riproponendo un articolo che avevo scritto per Europa un paio d’anni fa.
Era uno degli slogan preferiti della generazione che, secondo lo stesso Gaber, alla fine “ha perso”: la sua generazione, quella degli anni Sessanta e Settanta, che voleva cambiare il mondo e, alla fine, ne è stata viceversa contaminata irrimediabilmente.
Il personale è politico. Il credo di tante battaglie di quel periodo, per l’emancipazione femminile, degli omosessuali, contro ogni autoritarismo, per la pace e la non-violenza. Il prodotto di tanti pensieri, da Marcuse a Cooper, da Adorno a Gandhi, da Marx a Gesù Cristo: per cambiare il mondo, occorre prima cambiare se stessi, la propria quotidianità, i rapporti privati.
Questa distanza tra corpo e mente (l’io diviso di Laing), tra fisicità ed idealità è stato il punto focale del pensiero di Gaber. “Se potessi mangiare un’idea, avrei fatto la mia rivoluzione”. La società, le istituzioni, l’interazione collettiva non possono modificarsi se ognuno di noi non si è modificato dentro, se non porta con sé i germi di un mondo nuovo, la volontà, il bisogno imprescindibile di mutare prima se stessi. E’ il grande apporto che il cantautore milanese ha dato alla elaborazione del pensiero politico: non basta avere buone idee o grandi ideali, non è sufficiente pensare che sia giusto vivere in una società più giusta; è solo lo stato di sofferenza individuale che può spingere al cambiamento, la percezione che così come viviamo, con i rapporti inter-individuali alienati dal potere (qualsiasi potere), non possiamo più vivere. Solo da questa percezione può nascere la rivoluzione. Una rivoluzione prima di tutto culturale.
Ciò che affermava Marx rispetto al proletariato (non abbiamo altro da perdere se non le nostre catene) è parallelo a quanto Gaber suggerisce per l’uomo contemporaneo: non si possono mutare i rapporti “produttivi” sociali se non si ha il “bisogno fisico” di farlo, se si ha invece solamente quello ideale, frutto di una qualsiasi Weltanschauung, di una specifica ideologia.
Sulla base di questa intuizione, il teatro di Giorgio Gaber, e del suo alleato Sandro Luporini, coniuga i tre elementi essenziali della sua filosofia: l’appartenenza (l’identità collettiva), l’individualità personale (l’individuazione, per dirla con Pizzorno), l’azione collettiva.
Il tema dell’appartenenza, innanzitutto. Nel corso degli anni Sessanta e Settanta, dal ’68 in poi, le contestazioni alla società occidentale nascono dalla domanda di un’identità collettiva nuova, definita in contrasto con il sistema di potere allora (e ancora oggi) presente. La finalità sottostante è la richiesta di riprendersi la vita, lo spazio sociale che una società ingessata regolamenta nelle interazioni tra i soggetti. Attraverso simboli e simulacri di una libertà che è soltanto “obbligatoria”, la massificazione di Pasolini. La partecipazione è ridotta dunque al solo momento elettorale (“come sono giuste le elezioni”, affermano beffardamente Gaber e Luporini).
L’individualità, poi. La sfera personale, la responsabilità e la coerenza dei propri gesti, delle proprie azioni diviene il nucleo fondamentale del processo di cambiamento sociale. “Chiedo scusa se parlo di Maria”, canterà Gaber nella manifestazione contro il colpo di stato di Pinochet in Cile, subissato ovviamente dai fischi. Perché il Cile, il Vietnam, la rivoluzione passano soltanto dalla capacità di rivoluzionare i rapporti interpersonali, altrimenti resta qualcosa di lontano, astratto, non così “urgente” da rimanere imprescindibile nella scala dei valori della propria esistenza presente. E futura (l’Io futuro, per citare di nuovo Pizzorno). Ma se la mente riesce a veleggiare, il corpo è pesante. Il retaggio del passato (dell’Io passato) non permette di spiccare il volo. Senza mamma, senza patria, senza famiglia, senza casa: “un uomo senza niente è più leggero”. Ma la leggerezza è difficile da conquistare, e dunque “anche per oggi non si vola”.
La partecipazione, infine. L’azione collettiva dovrebbe avere come obiettivo la sconfitta del potere, di ogni potere, non per erigerne un altro, ma per partecipare più coscientemente, in prima persona, alle scelte collettive (“Qualcuno era comunista” perché era un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Perché, con accanto questo slancio, ognuno era come essere due persone in una.) Non nel chiuso della propria casa, della propria famiglia, della propria prigione, ma sulla strada, perché solo la strada apre alla vita e al cambiamento. Si sentono riecheggiare le parole d’ordine degli ultimi anni: il partito leggero, i movimenti, la costruzione dal basso della democrazia, il rifiuto del potere, la politica come servizio, come completamento di sé, non come professione. Tutto questo lo troviamo riassunto nello slogan sicuramente più famoso di Gaber: la libertà è partecipazione.
Sono passati 40 anni da quelle ipotesi di trasformazione del rapporto tra cittadini e politica, ma tutto sembra essere rimasto come allora.


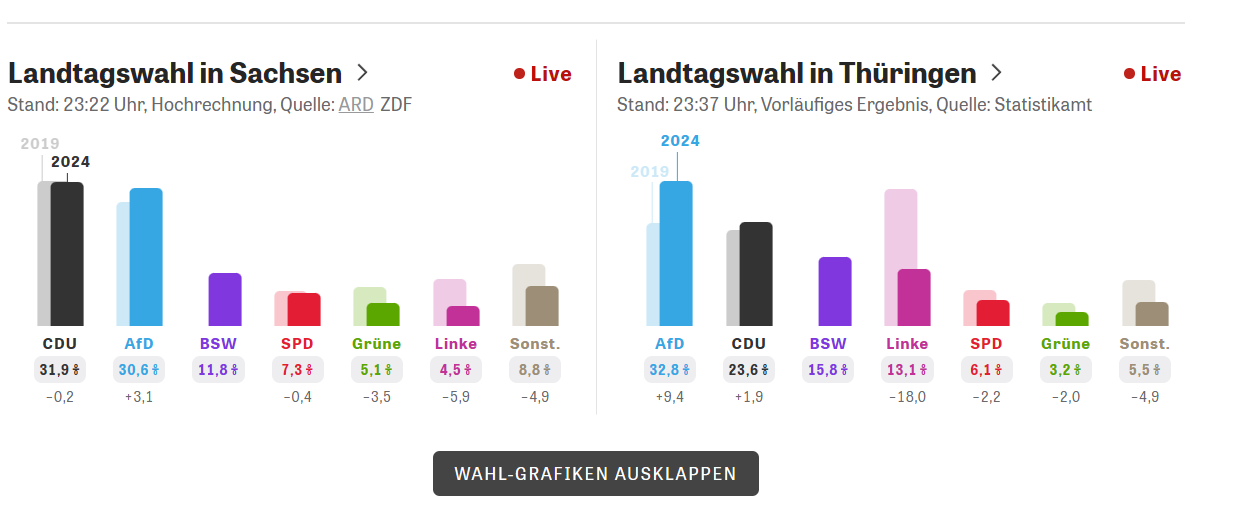


Devi fare login per commentare
Accedi