Clima
CLIMA. Lo scienziato: “Fare in fretta? Meglio fare bene”
Intervista a G. Giordano (Facoltà di Geologia, Università Roma 3)
Sulla teoria del cambiamento climatico in questi mesi, soprattutto dopo la crescita del fenomeno Greta Thunberg, si è sviluppata, anche in Italia, una discussione molto polarizzata. I critici e i complottisti sostengono che si tratta di fake news e che non è possibile dimostrare che stiamo assistendo a un cambiamento climatico, perché si tratta di fenomeni che si sviluppano nell’arco di millenni e la raccolta di dati in modo sistematico è iniziata troppo di recente per poter fare affermazioni eccessivamente drastiche. Secondo qualcuno addirittura la recente ondata di freddo che ha colpito l’Italia sarebbe la dimostrazione che il riscaldamento globale è una bufala… I sostenitori della teoria invece rivendicano il consenso praticamente unanime della comunità scientifica. Si tratta di una questione complessa, che rientra in una più generale discussione della comunità scientifica sugli effetti dell’attività umana e sulla loro capacità di produrre trasformazioni del pianeta analoghe a quelle prodotte delle forze naturali e che ha portato all’elaborazione del concetto di Antropocene. Per orientarci meglio in questo dibattito abbiamo chiesto un parere a Guido Giordano, docente presso la facoltà di geologia di Roma 3 e da sempre attento ai temi dell’ambiente.
Dal punto di vista di uno scienziato possiamo stabilire chi ha ragione e soprattutto se la questione ‘cambiamento sì o cambiamento no’ sia ben posta?
Ci sono alcuni fenomeni che mi sembra siano confermati in modo abbastanza chiaro dai dati. Potrei citare la cessione di energia all’atmosfera, ad esempio l’energia proveniente dagli oceani come effetto del loro riscaldamento, che a sua volta determina fenomeni atmosferici particolarmente violenti, come precipitazioni fuori dal comune e alluvioni. Ma credo che il problema vada posto in termini più generali. Da un punto di vista scientifico tutto ciò che riguarda il nostro pianeta e in generale la natura è soggetto al cambiamento, quindi il problema non è tanto se il clima cambia, ma se ci troviamo nelle vicinanze di una soglia critica oltre la quale il pianeta potrebbe non essere più in grado di assorbire la variazione di alcuni parametri, insomma la classica goccia che fa traboccare il vaso. Nel caso del riscaldamento terrestre l’aspetto più significativo non è tanto il fatto che le temperature salgano. E’ piuttosto che il ritmo di questo riscaldamento stia accelerando sensibilmente a partire dall’ondata di industrializzazione avvenuta nel secondo dopoguerra. E’ questa accelerazione che pone il problema della soglia critica.
Nel movimento contro il climate change si cita spesso il 2030 come la data indicata da un rapporto dell’IPCC entro cui bisogna intervenire per evitare eventi catastrofici.
Francamente si tratta di scadenze che in ambito scientifico è difficile definire, ma credo che il vero punto sia affrontare la questione del cambiamento climatico adottando un punto di vista sistemico, cioè considerandola come un problema complesso. L’oggetto del contendere sono le conseguenze dell’attività umana sul pianeta, che però rappresentano solo uno dei fattori in campo. Ad esempio proprio in questi giorni i climatologi discutono su una riduzione dell’attività solare che potrebbe provocare una diminuzione della radiazione solare che raggiunge la superficie della terra e quindi un raffreddamento dell’atmosfera. Quindi sono molti i fattori che possono mutare le condizioni del pianeta. Di questi una parte non dipende da noi e non è detto che sia il clima la sfera in cui si possono produrre in così breve tempo delle catastrofi. Pensa all’eruzione del vulcano Eyafiöl avvenuta nel 2010 in Islanda. Se quel fenomeno, nella sua fase più acuta, invece che una decina di giorni si fosse prolungato per sei mesi, vista la collocazione del vulcano rispetto alle correnti d’aria, l’impatto sulla vita dell’intero umanità avrebbe potuto essere devastante. Si tratta di capire se il fatto che gli effetti dell’attività umana siano solo una parte del problema ci basti a disinteressarcene. E’ un po’ come smettere di fumare: magari muori lo stesso, ma non per questo fumare fa bene… Da questo punto di vista la teoria del cambiamento climatico ha un aspetto interessante.
Quale?
Il fatto che in qualche modo ci obbliga a considerare gli effetti dell’attività umana in modo sistemico, cioè a capire che qualunque tipo di intervento umano ha degli effetti che vanno giudicati per le sue ricadute complessive sull’ambiente. Da questo punto di vista possiamo dire che negli anni passati l’umanità ha completamente sottovalutato questo aspetto e ciò ha portato al proliferare di modalità di intervento sul territorio disastrose, penso ad esempio all’abitudine di cementificare i corsi d’acqua senza pensare che ciò comporta un aumento della velocità di scorrimento dei rivi sottostanti, con tutte le conseguenze del caso, lungo i rivi e a valle, sulle spiagge ecc. Insomma ci siamo comportati con la maturitàdi un bambino di tre anni.
Quindi la complessità è l’aspetto preponderante?
Sì, penso che la questione centrale da porsi in questo momento non sia tanto quella di fare in fretta, quanto piuttosto quella di fare bene. Nel movimento ambientalista, a cui sono sempre stato vicino, c’è una tendenza storica ad adottare un’impostazione catastrofista. Ricordo che agli inizi della mia carriera passai un paio d’anni in Australia. E’ un continente in cui le grandi compagnie minerarie detengono un potere enorme e creano grossi problemi all’ambiente. All’epoca collaborai con una ONG che mi chiese di realizzare uno studio sull’impatto ambientale di un nuovo impianto di estrazione e ricordo che ciò che mi colpì positivamente è che non mi chiesero di drammatizzare le possibili conseguenze della costruzione di quell’impianto, ma mi chiesero di fare uno studio scientifico, per quanto possibile oggettivo, dei suoi effetti sull’ambiente. Il catastrofismo può essere una comprensibile tattica per attirare l’attenzione della gente e spingerla ad agire, ma rischia di fare appello a quelle stesse paure su cui oggi la politica fa leva per cercare consensi, magari su temi come l’immigrazione, e allo stesso tempo di ottenere l’effetto contrario a quello desiderato, cioè di deprimere e di paralizzare le persone invece di spingerle a mobilitarsi.
Cioè in un certo senso è più facile chiedere alle persone di mobilitarsi se si evoca una sorta di Apocalisse?
Più facile per un verso e più difficile per un altro, come dicevo, ma credo che si debba rovesciare la questione e cioè che a prescindere dal fatto che ci sia un pericolo imminente dobbiamo porci il problema che ci sono dei limiti oggettivi nel rapporto tra uomo e natura di cui tenere conto se vogliamo vivere in un mondo e in una società dove l’intera umanità possa vivere bene. Già oggi il tema del cambiamento climatico ha effetti diversi a seconda di dove vivi. Se vivi in Europa lo senti meno che se vivi in quella parte dell’Africa in cui il deserto sta avanzando, mangiandosi ettari di terre un tempo coltivabili. Se dovessi fare una previsione penso che noi tra 11 anni vivremo più o meno come viviamo adesso, ma in altre regioni del mondo il peggioramento legato al riscaldamento terrestre sara molto più percepibile.
Quindi non si tratta solo di questioni ambientali?
Dal mio punto di vista no, si tratta soprattutto di avere una visione del mondo e della società che vogliamo costruire, in cui bisognerà fare una riflessione complessiva appunto sull’impatto dell’attività umana sul pianeta, su ciò che vogliamo produrre e sulle condizioni dei lavoratori che producono e su chi gestisce l’economia. Se per risolvere un problema tu cambi la produzione ma la lasci nelle stesse mani che l’hanno governata finora, con le conseguenze sociali e ambientali che sappiamo, magari ottieni qualche piccolo miglioramento temporaneo, ma alla fine non hai risolto il problema.
Puoi fare un esempio?
Certo. Prendiamo il fenomeno del cosiddetto land grabbing. Di per sé il fatto che si producano biocombustibili per cercare un’alternativa al petrolio e agli idrocarburi in generale può essere un fatto positivo. Ma se a gestire il processo sono le multinazionali del settore cosa succede? Il land grabbing appunto, cioè che quelle multinazionali vanno in Brasile o in alcuni paesi africani, si accaparrano enormi distese di terre, sottraendole a comunità che ne traevano di che vivere e le sfruttano per produrre un nuovo tipo di carburante. Quel carburante magari bruciando nei motori delle nostre auto inquina meno, ma nel complesso ha un impatto ambientale, sociale, geopolitico analogo a quello del petrolio. Il problema quindi non è solo ciò che si produce e quali risorse concretamente usiamo, ma in che contesto, con quale logica e in quale prospettiva.
Intervista tratta dalla newsletter di PuntoCritico.info del 26 aprile 2019


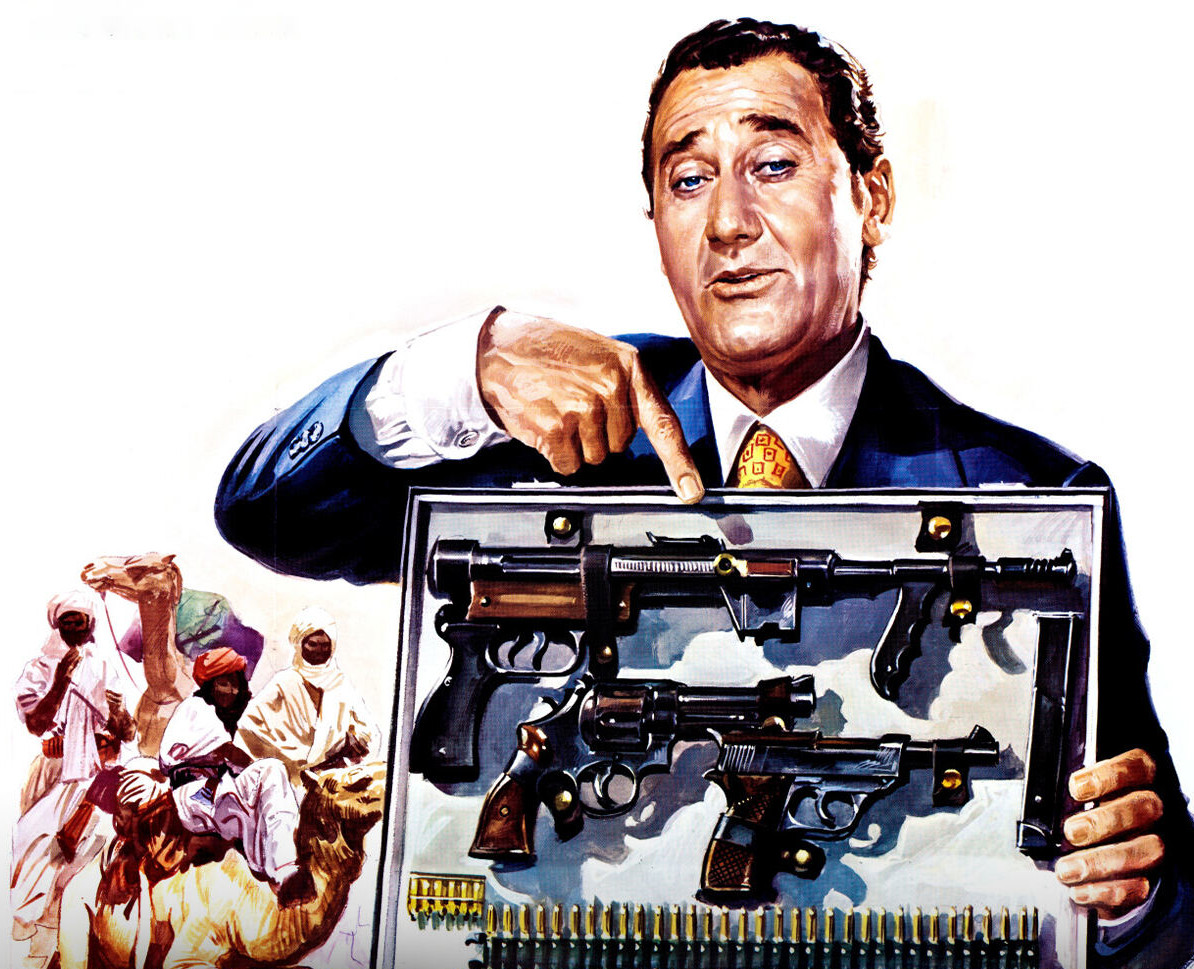
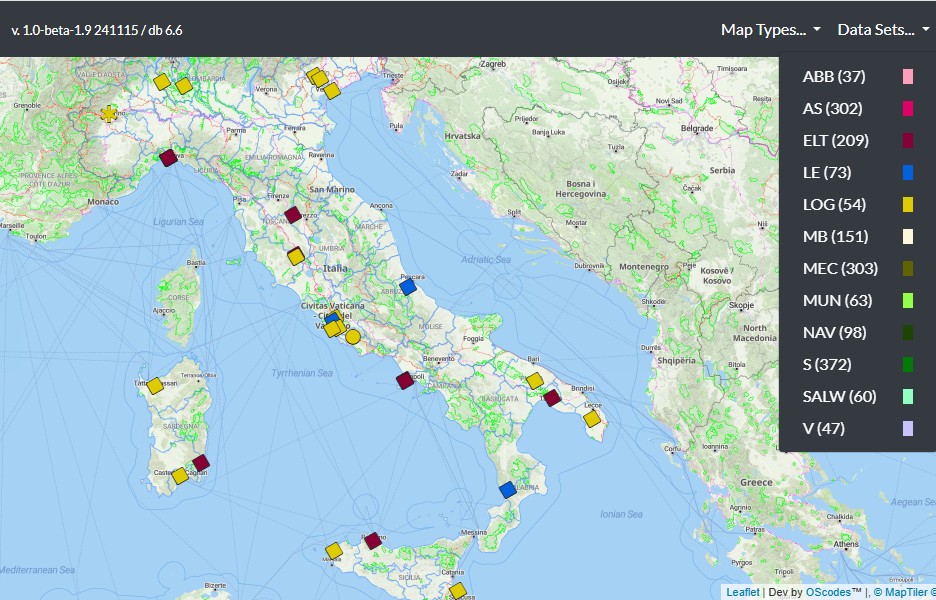

Devi fare login per commentare
Accedi