Scuola
L’insegnante come intellettuale trasformativo
“Un po’ per gioco, un po’ per curiosità ricognitiva”, Piero Bevilacqua ha buttato giù sul manifesto di ieri, 28 gennaio, una lista di intellettuali italiani uniti dal comune denominatore della “critica alla cultura neoliberistica, alle sue strategie e alle sue pratiche”. E’ una lista che, come tutte le liste, fa discutere, sia per le presenze che, soprattutto, per le assenze. Io, ad esempio, vi trovo – e ne sono felice – Marco Maurizi, che considero uno dei più interessanti filosofi italiani, ma non vi trovo Marco Rovelli, uno dei punti di riferimento nel nostro paese per una cultura alternativa al neoliberismo. Ma non è di questo che voglio parlare. Voglio soffermarmi, invece, sui territori che Bevilacqua ha segnato sulla sua provvisoria cartografia. Gli studiosi mappati appartengono a sette categorie: economisti; filosofi; giuristi; sociologi, politologi, antropologi; architetti, geografi, urbanisti; letterati; scienziati; storici. Bevilacqua premette che l’elenco è incompleto, perché ” mancano artisti, editori, giornalisti, uomini di cinema e di teatro, personalità di spicco fuori dall’accademia”. Solo? Non manca qualcos’altro?
Una volta si pensava – a sinistra – che il cambiamento sociale passasse anche, se non principalmente, attraverso la scuola e l’educazione. O, magari, attraverso la critica della scuola e dell’educazione, considerati strumenti in mano alle classi dominanti per riprodurre sé stesse e la loro cultura e giustificare, di fatto, le disuguaglianze sociali. C’è una scena di Centochiodi, di Ermanno Olmi, in cui il protagonista, un professore di filosofia della religione che ha dato di matto, crocifiggendo degli incunaboli della biblioteca universitaria, viene interrogato in Questura. “Fa parte di qualche organizzazione sovversiva o terroristica?”, gli chiedono. E lui risponde: “Ho fatto parte del corpo insegnanti”. A questo punto, nella piccola sala d’essai in cui vidi il film alla sua uscita, nel 2007, partì una risata irrefrenabile. Che la scuola sia una organizzazione terroristica, che gli insegnanti siano dei sovversivi, fa ridere. Fa ridere tanto. E fa ridere gli stessi docenti: perché quel piccolo cinema era frequentato soprattutto da docenti.
Non c’è figura che appaia più lontana dal rivoluzionario, o anche soltanto dal dissenziente, del professore seduto alla sua cattedra. O anche del professore universitario di pedagogia. Non è dunque per protestare per l’assenza di educatori, pedagogisti, docenti nella mappa di Bevilacqua, che scrivo questo articolo. Lo scrivo per riflettere sul fatto che una tale assenza è, oggi, giustificata.
Negli ultimi anni la scuola italiana è stata investita da interventi che sono andati tutti nelle direzione di renderla sempre più funzionale al sistema economico ed alle sue logiche. La legge 107 è solo l’ultimo atto. La classe docente non è riuscita ad opporsi a questa azione dall’alto, e non vi è riuscita anche perché, nella mia analisi, è mancata e manca una visione della scuola realmente alternativa a quella imposta dall’alto, che non sia la sola difesa di quello che c’era prima. E’ mancata e manca una chiara visione del senso politico del lavoro scolastico. Non mancano le parole d’ordine, ma si fa fatica ad individuare pratiche che corrispondano ad esse. Si vuole smantellare la scuola pubblica perché essa forma il pensiero critico, si dice. Ma in che modo, esattamente, si educa al pensiero critico nella scuola italiana? Con quali metodi? L’impressione è che per i più il pensiero critico sia una cosa che scaturisce magicamente dal contatto con alcune discipline, segnatamente quelle umanistiche. Si studia il greco, si studia la filosofia, e si sviluppa il pensiero critico. Una sciocchezza, naturalmente. Si sviluppa il pensiero critico dialogando, argomentando, appassionandosi, confrontandosi con gli altri, sporgendosi sulla scena pubblica: tutte cose che appaiono improbabili nella scuola cattedra-banco-lezione.
Sto leggendo in questi giorni due libri, non proprio recentissimi. Il primo è Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom di bell hooks (Routledge, 1994). L’autrice è una nota femminista nera americana, che ha vissuto la segregazione razziale in una scuola pubblica del Kentucky. La sua tesi è che l’insegnamento può e deve essere una pratica di liberazione, un’azione politica contro i limiti razziali, culturali, sessisti della società. Ma può esserlo solo se si ripensa a fondo la stessa relazione educativa, che è la base del lavoro scolastico. La classe può diventare un luogo interessante, perfino eccitante, se ognuno in essa ascolta la voce dell’altro e ne riconosce la presenza. Ordinariamente a scuola si chiede al solo studente di parlare di sé, della sua vita, della sua famiglia, mentre il docente resta umanamente inarrivabile, celato dalla maschera del suo ruolo. In una relazione educativa ispirata ad una pedagogia impegnata i professori smettono di essere “all-knowing, silent interrogators”, per assumere in prima persona il rischio che chiedono agli studenti: il rischio della narrazione di sé.
L’altro libro è Teachers as Intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of Learning di Henry Giroux (Praeger, 1988). Ancora quasi sconosciuto in Italia (sono a conoscenza di un suo solo libro tradotto in Italiano), Giroux è forse il maggior pedagogista statunitense, e le sue idee hanno suscitato e suscitano un ampio dibattito nel suo ed in altri paesi (il suo nome non potrebbe mancare, in una ipotetica cartografia americana della resistenza intellettuale al neoliberalismo). Reagendo alla teoria di Bourdieu e Passeron, secondo la quale la scuola è funzionale alla conservazione dello status quo ed alla riproduzione della cultura delle classi dominanti e della disuguaglianza sociale, Giroux presenta l’idea della scuola come “sfera pubblica democratica” nella quale si prepara una democrazia autentica. Cosa che non si può fare se non ripensando a fondo la scuola, a partire dallo stesso setting dell’aula, che ostacola l’autentico senso di comunità e favorisce l’ethos capitalistico della competizione. Gli insegnanti, sostiene Giroux, devono diventare intellettuali trasformativi, nel senso che lavorano politicamente per trasformare una società diseguale in una democrazia effettiva, attraverso l’empowerment degli studenti.
Non amo molto il termine intellettuale, che implica quella contrapposizione tra intellettualità e manualità che considero uno degli impliciti culturali della nostra società che occorre combattere; ma non mi dispiace questa idea dell’insegnante come intellettuale – perché di fatto il lavoro dell’insegnante non ha nulla di manuale, benché spesso sia molto artigianale – che lavora per la trasformazione: e non solo la trasformazione dell’individuo, ma anche quella della società e della cultura.
Tanto bell hooks quanto Henry Giroux risentono profondamente dell’insegnamento di Paulo Freire, il pedagogista brasiliano che, con un metodo profondamente innovativo, riuscì ad alfabetizzare in poco tempo i proletari di Angicos. In Freire l’alfabetizzazione andava di pari passo con la coscientizzazione, con la consapevolezza dell’oppressione e dell’ingiustizia sociale, che precede e fonda il cambiamento rivoluzionario. Ma risentono anche, in misura non minore, del nostro Gramsci e della sua teoria dell’egemonia, evocata dall’articolo di Bevilacqua. Esiste in America, sia al nord che al sud, una corrente di pedagogia critica ancora estremamente vivace, che anima il dibattito pubblico e la lotta politica. Qualche giorno fa ho parlato con un amico – Paolo Vittoria, napoletano che insegna filosofia dell’educazione all’università di Rio de Janeiro – del suo lavoro politico-educativo degli ultimi tempi: assemblee e riunioni nelle università e nei centri sociali con studenti, contadini, gruppi di indigeni. Un fermento straordinario, appena pensabile per chi osserva dall’Italia, pur in un periodo di grande difficoltà e di confusione politica per un paese che non ha meno contraddizioni del nostro.
In Italia c’è stato un fermento simile nel secolo scorso, tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta. Più di un ventennio di analisi, di critiche appassionate, di denunce, di sperimentazioni, di tentativi, anche di errori, ispirati da un unico slancio: quello di attuare una democrazia reale, qualcosa di più alto della partitocrazia democristiana, con i suoi inquietanti risvolti criminali (mafia, stragi di stato, corruzione). Di tutto quel fermento, di quelle sperimentazioni, di quel lavoro del pensiero sembra essere rimasta solo la pallida e patetica evocazione di un don Milani sempre meno compreso, sempre più ridotto a figurina buona per tutte le stagioni.
Ho parlato di lavoro politico-educativo. L’obiezione che mi sento spesso fare, quando parlo della mia idea di educazione e di insegnamento, è che io voglio far politica, e questo non va bene. Una simile obiezione fecero a bell hooks i docenti dell’Oberlin College (il primo college americano che ha accettato studenti neri), quando parlò loro della sua formazione freiriana. E la sua risposta fu che “no education is politically neutral“. E’ naturale. Educare ed insegnare vuol dire lavorare per un certo tipo di società, ossia fare un lavoro politico. Chi non si è mai posto il problema di quale società favorisce con il suo modo di insegnare, è semplicemente un docente non pienamente consapevole del suo ruolo. O meglio, uno che lascia che il senso politico del suo lavoro sia stabilito da altri.
Ma nell’accusa di fare politica c’è dell’altro. C’è il sospetto che io voglia fare una politica che può piacere ad alcuni e dispiacere ad altri: una politica di parte. Lo è, in effetti: fare politica vuol dire sempre stare da una parte. Ma è una parte che è legittimata dalla stessa Costituzione. E’ una parte che vuole realizzare in modo pieno, e non retorico, i valori costituzionali: la democrazia, la partecipazione politica, l’uguaglianza, le opportunità per tutti, il superamento di ogni discriminazione. E’ una parte che consiste nel prendere semplicemente sul serio la democrazia. E prenderla sul serio non vuol dire lavorare, in modo spesso retorico, per una educazione alla democrazia, ma fare in modo che la democrazia sia presente già qui ed ora, nel presente del lavoro scolastico: educare nella democrazia. Che vuol dire costituire la classe come quella “sfera pubblica democratica” di cui parla Giroux. In che modo – con quali pratiche, metodi, strumenti concettuali – ciò si possa fare, dovrebbe essere il principale problema di cui discutere per pensare la scuola.
E’ diffusa la convinzione che l’innovazione della scuola possa e debba passare attraverso l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Per quanto sia tutt’altro che contrario alla tecnologia, la mia impressione è che sia un modo relativamente semplice per eludere il problema del cambiamento. Riempire le aule di lavagne interattive e di tablet non comporta alcun reale progresso, se non diventano strumenti per il confronto, la ricerca e la discussione comune. La democrazia esige la presa di parola: si entra in una comunità democratica nel momento in cui si esprime una propria idea, si discute l’idea di un altro, si cerca insieme una terza idea. Se la tecnologia favorisce questa presa di parola, allora la tecnologia è una buona cosa; se la ostacola, è una cosa non buona. La tecnologizzazione della scuola e dell’insegnamento sta costringendo molti docenti a sforzi notevoli per acquisite le competenze informatiche di base – che molti ancora non hanno – e per applicare quelle competenze alla didattica. Il rischio è che tutto questo sforzo per così dire tecnico faccia passare in secondo piano o occulti la questione politica decisiva: insegnare perché? per cosa?
Nell’immagine: Henry Giroux.

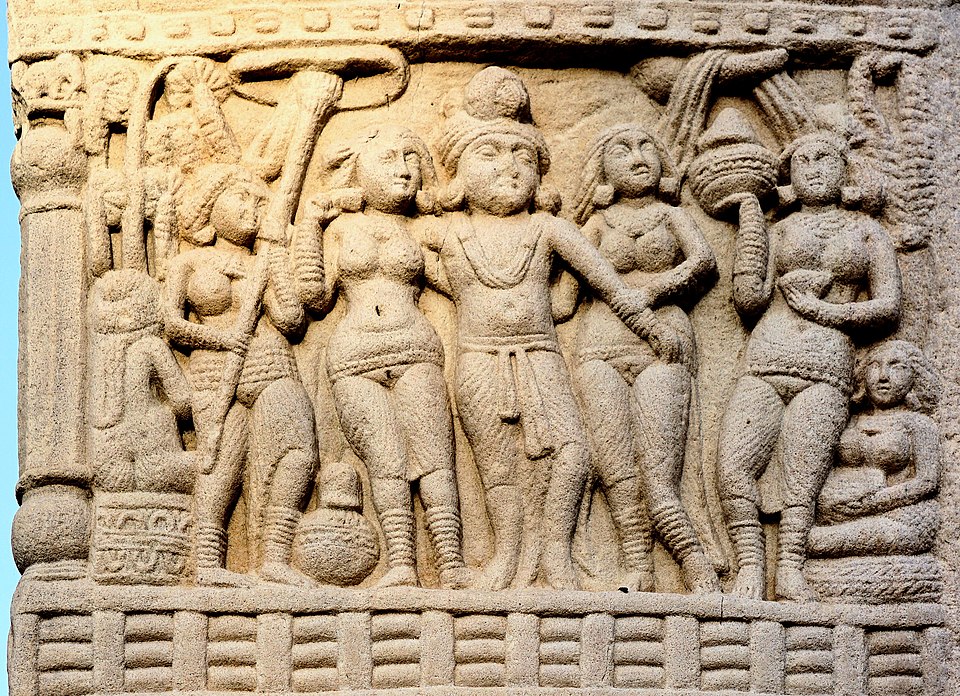


Devi fare login per commentare
Accedi