Medicina
Politica, scienza, pandemia: ‘La scienza? È complessa, plurale e va compresa”
Intervista a Maria Pia Donato, storica della medicina, direttrice di ricerca CNRS, Parigi
Uno dei problemi dell’attuale dibattito pubblico è l’assenza di profondità temporale. L’economia e, di riflesso, la politica hanno mutuato dalla finanza la logica delle transazioni a breve termine: ci si ricorda al massimo di ciò che è successo ieri e ci si preoccupa al più di ciò che succederà domani. Per questo per inquadrare la crisi sanitaria in atto, oltre al contributo dei virologi, sarebbe utile rivolgersi agli storici della medicina, ma in Italia, a differenza di altri paesi, nessuno li interpella. L’assenza di un giornalismo scientifico all’altezza è uno dei temi che abbiamo affrontato nella nostra intervista a Maria Pia Donato, storica della medicina e direttrice di ricerca presso il Centre National de la Recherche Scientifique a Parigi. In un articolo pubblicato a fine marzo in ‘Storie Virali’ sul sito Treccani, ‘Il COVID-19, la storia della medicina e la politica’, la ricercatrice sottolineava come qualunque crisi, epidemie incluse, colpisca in modo differenziato i diversi settori della nostra società. Ciò implica inevitabilmente che anche la ‘narrazione’ delle epidemie sia influenzata dal punto di vista sociale che si assume. Il New York Times recentemente ha pubblicato un articolo imperniato sulla domanda: ‘quando finisce un’epidemia? Dalle dichiarazioni degli storici emerge che anche a questo interrogativo rispondono due diverse ‘narrazioni’, una medica e una sociale. Del resto è quello che abbiamo osservato anche in queste settimane e nel passaggio tra fase 1 e fase 2. Partiamo da qui.
Gli scienziati hanno contribuito in misura significativa alla narrazione della pandemia, spesso chiamati in causa da una politica debole. Cosa pensi di questo intreccio?
L’intreccio è necessario ed è un bene che chi ha delle competenze le metta a disposizione. La scienza è lì per quello. Non deve prendere decisioni, ma è un tratto caratteristico della storia della società occidentale, in particolare delle democrazie, che la politica prenda alcune decisioni anche basandosi su competenze esterne. Ciò che invece è meno positivo è l’intreccio tra consulenza ufficiale e visibilità mediatica. Il problema è che bisognerebbe partire da una comprensione di che cos’è la scienza e di cosa sono gli scienziati. In una società complessa come la nostra non può esistere l’idea di una tecnocrazia scientifica, in cui per di più la scienza è incarnata da alcune figure apicali. Il mondo della scienza è per sua natura complesso, plurale, molto esteso e anche con forti divergenze al proprio interno.
Invece tende a dominare l’idea della Scienza con la S maiuscola, intesa come portatrice di verità assolute e quindi, inevitabilmente, monolitica.
E’ un tema vasto e complicato. Parlare della Scienza con la s maiuscola non ha molto senso e la scienza non è il dominio delle certezze assolute, è un processo collettivo che si svolge nel tempo e in cui la comunità scientifica arriva a dei risultati e a delle certezze attraverso un processo di ricerca e di validazione interna, ma in un contesto in cui esiste una pluralità di vedute. Per questo dico che è importante cercare di capire. Una delle cose che in questi mesi, ad esempio, non si è capito o voluto capire è la natura dell’epidemiologia. Gli epidemiologi provano a creare dei modelli predittivi, che sono cruciali per decidere le politiche sanitarie, ma dal punto di vista epistemologico la loro è una disciplina essenzialmente retrospettiva. Un altro aspetto è che non esiste ‘la’ scienza, esistono ‘le’ scienze. I punti di vista di un virologo, di un epidemiologo e di un infettivologo non coincidono. Le loro discipline devono parlarsi e integrarsi, certo, ma esprimono punti di vista diversi. Analogamente bisogna tenere conto che una cosa è la salute del paziente e un’altra la salute pubblica. Insomma ci sono distinzioni di piano che è fondamentale aver chiare. Ti faccio un esempio. Chi, come me, fa ricerca storica e consulta gli archivi oggi deve fare i conti con una regola del Mibact, secondo cui un libro, una volta consultato, non può essere dato ad altri per 9 giorni. Ma il fatto che un microbiologo abbia constatato che il virus nel suo laboratorio è sopravvissuto per 9 giorni non significa che i libri vadano messi in quarantena per 9 giorni, per il semplice fatto che una biblioteca non è un laboratorio e che quel dato empirico va letto in termini probabilistici. Infine su questi problemi di incomprensione si innestano anche questioni di ego, posizioni politiche, interessi economici e sono interferenze che bisogna mettere in conto per un principio di realtà. D’altra parte però da qui a mettere sistematicamente in dubbio che i ricercatori lavorino per cercare di comprendere il mondo circostante il passo è lungo e soprattutto non giustificato.
La medicina ha anche uno statuto epistemologico particolare, perché non è una scienza sociale, ma, diciamo così, è una scienza empirica in cui soggetto e oggetto in qualche misura coincidono, perché l’oggetto è l’uomo. Ciò crea anche altre potenziali interferenze tra soggetto conoscente e oggetto di conoscenza, un po’ il fenomeno che Heisenberg osservò nella fisica delle particelle. Cosa ne pensi?
E’ una riflessione che articolerei meglio. Diciamo che nella medicina, oltre alla comprensione della salute e della malattia e alla terapeutica, coesistono almeno altri tre piani, cioè un livello etico, un livello economico e uno organizzativo-sociale. Le logiche proprie di ciascuno di questi livelli possono entrare in tensione tra loro. Sin dalle origini poi c’è stata una dicotomia tra il piano generale e quello individuale. La medicina è una scienza pratica o una ‘prassi scienziale’ come dicevano i medici del Medioevo.
Parlavi di un livello organizzativo-sociale. Nella storia della medicina come si è manifestato l’intreccio tra scienza e potere politico?
La medicina nasce come una disciplina rivolta fondamentalmente all’individuo. Il medico antico non si occupa della salute della popolazione, magari la osserva, ma non se ne occupa. Per lui l’orizzonte è delimitato da tre elementi: è la relazione tra chi cura, la natura e il malato. La medicina come disciplina che entra in relazione con l’organizzazione sociale si manifesta a partire dal Medioevo, con la creazione delle prime università e, in seguito, con la nascita dello Stato moderno, diventa inerentemente una disciplina sociale e allarga il suo sguardo alla salute della popolazione, che, anche in termini teorici, non è la stessa cosa della salute dell’individuo. A partire dalla fine del ‘700 e in alleanza con lo Stato la medicina interviene o pretende di intervenire sempre di più sul corpo astratto della popolazione occupandosi di salute pubblica. Quella concezione si tramanda da allora fino a oggi, anzi in realtà fino agli anni ’60-’70, perché la concezione di salute pubblica di oggi è molto diversa.
In che senso? Ti riferisci all’intervento del mercato?
Certo, ma non è il solo aspetto. Ovviamente anche oggi lo Stato si occupa della salute pubblica, ma lo fa molto meno, in parte anche perché le condizioni sanitarie della popolazione sono tali che non c’è n’è più bisogno come un tempo. Pensa ad esempio alle grandi campagne di vaccinazione che gli Stati realizzarono in alcuni momenti della storia. Questo è un aspetto che spiega tante cose dell’attuale epidemia.
Cioè oggi, di fronte al COVID-19 lo Stato torna indispensabile?
Sì, ma avendo spuntato le armi teoriche e pratiche per realizzare un intervento capillare come sarebbe necessario ora. Pensa solo alla polemica sui vaccini. In una società più ricca, più attenta alle libertà individuali, ma anche più individualista, l’intromissione dello Stato nella sfera dei comportamenti dei singoli viene vissuta come un’intrusione violenta, mentre in società meno alfabetizzate, meno ricche, come era ancora la nostra negli anni ’70, l’autorità dello Stato, dei medici e degli scienziati viene seguita con meno sospetto. Non mi interessa qui esprimere un giudizio di valore, ma evidenziare un cambiamento storico.
Aldilà della reazione soggettiva della popolazione che cosa comporta quest’evoluzione in termini strutturali e che conseguenze ha in una situazione come quella che attraversiamo?
Comporta che, come in Lombardia, arrivi alla crisi avendo smantellato quelle istituzioni che erano nate per garantire agli Stati il controllo territoriale sulla salute pubblica. Tutti quei presidi, pensati appunto come strumenti di sorveglianza dello stato di salute della popolazione, non vengono più ritenuti necessari. A questo poi si aggiungono anche altri fattori, il modello a dominanza ospedaliera e gli interessi economici connessi. Sulla medicina del territorio, infatti, non c’è possibilità di lucrare. Il modello centrato sugli ospedali invece si presta all’intreccio tra politica, affari e dirigenza e lì, soprattutto, ci sono i soldi. In regioni come Veneto ed Emilia-Romagna, dove c’è una tradizione storica di controllo sociale più forte, sono stati in grado di riattivare funzioni legate al territorio che la Lombardia invece aveva estirpato per ragioni ideologiche, politiche ed economiche. E dalle regioni che ho citato si capisce che parlo di tradizioni storiche e aspetti strutturali più profondi della distinzione tra schieramenti politici.
Chi è più arretrato è più forte?
Non direi chi è più arretrato, ma chi è più orientato alla comunità locale. Che il sud sia stato risparmiato dall’epidemia è stato anche una questione di fortuna, ma spesso nelle regioni meno sviluppate hai meno abitanti, una densità della popolazione inferiore e quindi sei anche più protetto. Sono fattori che per altro pesano anche nelle società ricche. Anche in Germania, aldilà delle loro capacità in termini di presidio sanitario del territorio, del numero di posti letto ecc., ha pesato il fatto che le loro città sono diverse dalle nostre, ad esempio che la densità della popolazione è inferiore. Tornando all’Italia in Trentino, a parte alcuni paesi di montagna, dove la propagazione del virus è stata accelerata dai turisti lombardi arrivati nel weekend di carnevale, hanno gestito la crisi relativamente meglio e una delle ragioni è che lì hanno mantenuto una sanità con forti presidi territoriali.
Certo da una parte ci sono i fattori oggettivi, ad esempio la struttura della sanità e anche una conformazione sociale che varia nelle diverse regioni. Poi però ci sono anche aspetti soggettivi. In Italia, ad esempio, ha brillato l’assenza di strategia.
In Italia questo è un problema drammatico. All’inizio diciamo che i problemi in qualche misura erano inevitabili e c’è stato anche un elemento di casualità, perché, non dimentichiamolo, fortuna e sfortuna nelle epidemie hanno un peso rilevante. Ma il fatto che gli ospedali siano diventati il principale focolaio di contagio te la dice lunga. Ti fa capire che non erano pronti dei protocolli di emergenza. I medici di base non hanno avuto indicazioni tempestive. I tamponi sono stati fatti sostanzialmente a caso. Una débacle. In Francia ci sono stati due casi accertati molto prima dell’Italia, una coppia di origine cinese e un anziano nell’Alta Savoia. Qui i servizi di medicina del territorio hanno individuato i contatti e hanno immediatamente spento il focolaio e in questo modo la Francia ha guadagnato alcune settimane rispetto all’Italia. Poi ci sono state comunque scelte improvvide come quella di non rinviare il primo turno delle elezioni e in generale mi sembra che se l’Italia ha commesso degli errori altri paesi non abbiano fatto molto meglio, ma, tornando al discorso di prima, il caso francese dimostra l’importanza della medicina del territorio e quanto pesa il fatto che i medici siano pronti a reagire tempestivamente e in modo appropriato. Sul dilagare del virus poi, ovviamente, ha influito anche la reticenza cinese. Non sapremo mai la verità sui primi casi e ormai si accumulano le prove che il virus circolasse molto prima degli annunci ufficiali. Anche qui però dobbiamo distinguere tra il senno di poi e l’occultamento della realtà. Fino a un certo punto dobbiamo pensare che anche per i medici cinesi sia stato difficile capire che cosa stesse succedendo esattamente.
Nei giorni scorsi i media hanno riferito che alcune grandi case farmaceutiche negli anni passati hanno deciso di non investire sulla ricerca di vaccini per i coronavirus, anzi avrebbero fatto pressione per ostacolare questo tipo di ricerca. Francesco Sylos Labini, che abbiamo intervistato a marzo, sottolineava che uno dei problemi che affligge la ricerca scientifica riguarda i finanziamenti: ci sono filoni che ‘tirano’ e ricevono fondi ingenti e se decidi di studiare altri argomenti non fai carriera.
Dalla rivoluzione scientifica in poi, cioè da quando si è capito che la scienza può produrre ricchezza, non c’è mai stata una scienza pura e disinteressata. La scienza pura è un valore a cui tendere, non un valore realizzato. E’ vero che i finanziamenti indirizzano la ricerca e le stesse carriere accademiche e che fanno anche la fortuna di molti indirizzi scientifici e di ricerca, soprattutto nei contesti in cui fare ricerca costa miliardi. Esiste indubbiamente un mix tra liberalismo e burocratismo, come nel sistema di finanziamento europeo, in cui c’è una selezione dei progetti molto rigida, burocratica e mainstream. Credo però che sarebbe riduttivo attribuire alla politica tutte le responsabilità. Non è il ministro, sono gli accademici che decidono a chi dare i finanziamenti e che tendono sempre più a privilegiare la ricerca applicata, quella che si spera possa tradursi in brevetti, start-up e iniziative con un ritorno economico. E’ un pattern tipico del liberalismo applicato alla ricerca, sintetizzato nell’idea che un euro di denaro pubblico deve produrne uno di denaro privato. In questo modo alcuni settori meno orientati alla ricerca applicata e meno mainstream entrano in sofferenza.
Come si riverbera questa situazione in campo medico?
Un esempio caratteristico sono i vaccini. La ricerca ha cercato in maniera strenua di trovare un vaccino per l’HIV, sono stati spesi miliardi, ma non se ne è venuti a capo. Ora l’AIDS è una malattia cronica, si sono trovate delle cure soddisfacenti, l’HIV non è più il flagello che appariva all’inizio e l’interesse per il vaccino è scemato. Del resto anche le case farmaceutiche guadagnano di più producendo e vendendo i farmaci usati per trattare la malattia. Nel caso di malattie come il COVID-19 si poteva intuire che prima o poi sarebbe arrivata una pandemia, ci sono stati tentativi di produrre vaccini per i coronavirus, ma i finanziamenti non sono stati sufficienti, anche perché c’erano buone probabilità di insuccesso o, in caso di successo, di un ritorno economico relativamente basso. La scienza, come dicevo prima, è un processo collettivo che è soggetto a tutte queste interferenze: è il modo in cui la scienza funziona. C’è una lunga tradizione di critica storiografica e anche militante all’interno delle comunità scientifiche, che ha messo in allerta da questi meccanismi in qualche misura fisiologici, che si devono conoscere e mitigare. Da questo punto di vista la scienza è un po’ come la democrazia, non è perfetta ma finora non si è trovato di meglio.
Quanto conta secondo te il modo in cui viene insegnata la scienza? Cioè quanto l’insegnamento delle materie scientifiche, in particolare nella scuola dell’obbligo e nelle superiori, fa sì che quest’idea della scienza assoluta che vive in una sfera separata dalla società faccia breccia nell’opinione pubblica?
Conta tantissimo. Nel dibattito di questi mesi davvero tocchi con mano l’analfabetismo scientifico che c’è nel nostro paese. Del resto è un paese cui la classe politica viene dalle facoltà di legge, scienze politiche, lettere e la selezione delle élite passa attraverso i licei dei quartieri bene e poi le facoltà umanistiche. Nota che io sono una storica, quindi un’umanista, ma il fatto che la formazione scientifica per un politico quasi non faccia curriculum è un bel problema. Sarebbe meno grave se almeno avessimo un giornalismo in grado di fare comunicazione scientifica come si deve. Il confronto con gli Stati Uniti e con l’Inghilterra da questo punto di vista è illuminante. Lo vedi nell’incapacità di capire la differenza tra concetti come ipotesi, probabilità, certezza, di porre le domande adatte, così come nella tendenza a ricondurre tutto alla dinamica della personalità. Questo induce un elemento di torpore intellettuale. Torno all’esempio dei libri in quarantena: con un minimo di consapevolezza in più su come funziona il contagio e sui risultati acquisiti fino ad oggi dai vari campi di ricerca sul COVID-19 non si accetterebbero regole così.
Tu ti sei fatta un’idea di come bisognerebbe intervenire?
Bisognerebbe riprendere il progetto di riforma dei cicli, cioè portare la scuola secondaria inferiore a 5 anni, con un liceo specialistico di tre anni, sfoltire le materie, tenendo quelle fondamentali, potenziando matematica e scienze e bisognerebbe avere la capacità di formare insegnanti migliori. In realtà non penso che verrà mai fatto, ma mi accontenterei che radio e tv pubbliche dessero più spazio ai temi scientifici e che avessimo dei giornalisti con una formazione scientifica nelle redazioni dei maggiori giornali. Del resto anche in Francia, dove c’è ancora grande attenzione per la scienza e l’École polytechnique è ancora una fucina della classe dirigente, se ascolti France Culture anche lì dominano i conduttori di formazione filosofica, letteraria o storica. Tanto che dopo l’arrivo della pandemia hanno dovuto richiamare un bravissimo commentatore scientifico che ogni mattina fa 5 minuti di divulgazione scientifica sul coronavirus. In Inghilterra invece c’è una tradizione di divulgazione scientifica che va avanti: se leggi gli articoli scientifici di giornali come il Guardian sono articolati ed efficaci. In Italia da questo punto di vista una delle poche cose interessanti per il grande pubblico è il blog dell’Accademia dei Lincei sull’Huffington Post. Anche questa dovrebbe essere una priorità.
L’intervista è tratta dalla newsletter di PuntoCritico.info del 29 maggio.


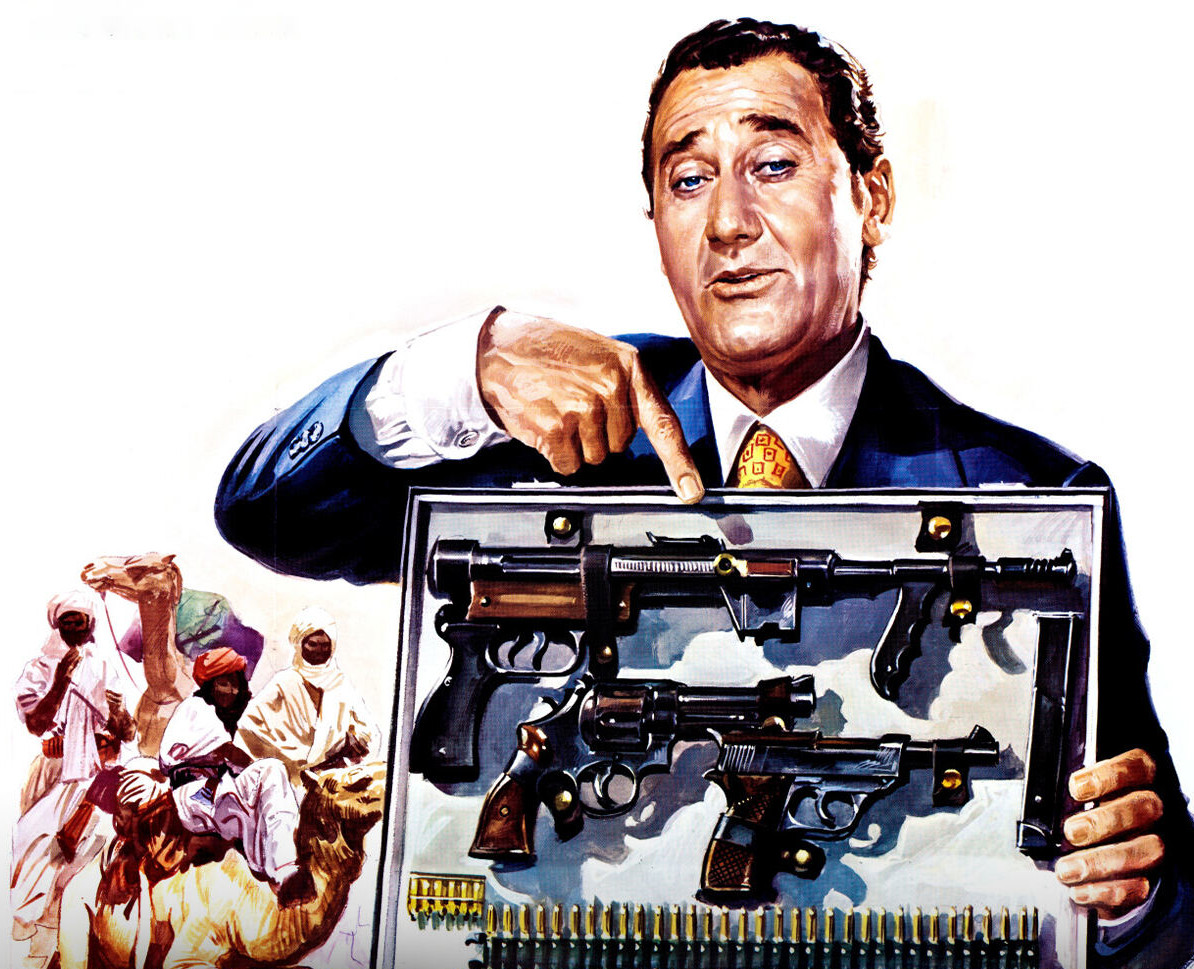
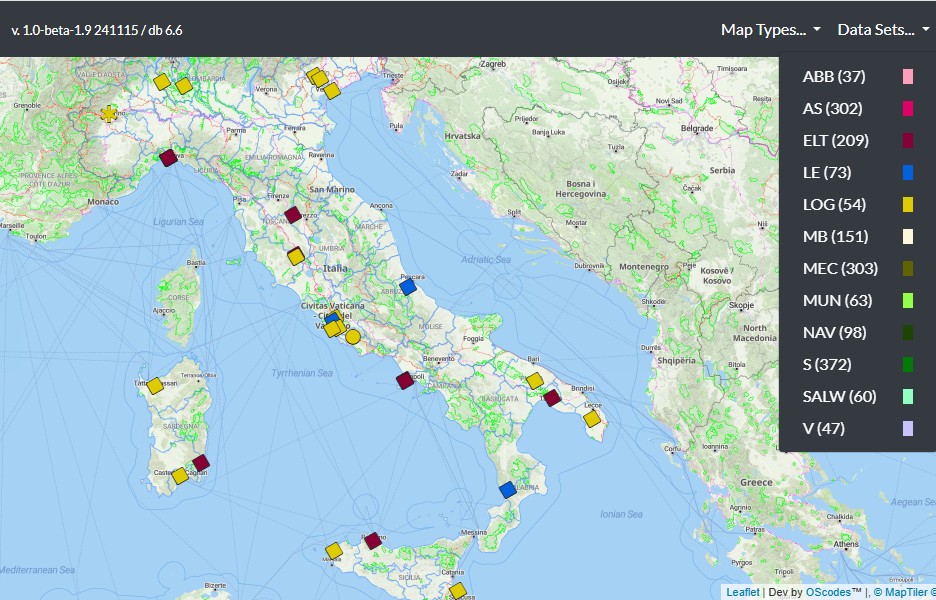

Devi fare login per commentare
Accedi