Costume
Diritto alla vita, diritto alla morte: il caso mediatico di Marieke Vervoort
Il dramma. Così la Gazzetta dello sport chiosa la notizia della morte di Marieke Vervoort, atleta paralimpica che, all’età di 40 anni ha deciso di porre fine alla sua vita ricorrendo all’eutanasia. La Vervoot, due volte campionessa del mondo di paratriathlon, era affetta, dall’età di 14 anni, da una grave patologia degenerativa muscolare e aveva preso la decisione di ricorrere all’eutanasia – legale in Belgio – già nel 2008. Nelle numerose interviste rilasciate alla stampa la campionessa aveva motivato la sua scelta con la volontà di non dover affrontare, quando il dolore fosse diventato insopportabile, un percorso nel quale, per lei, la qualità della vita non sarebbe più stata accettabile e la dignità personale rispettata. Una scelta meditata che non le ha impedito di partecipare – e ottenere grandi risultati – alle Paralimpiadi di Londra e di Rio. La consapevolezza di avere un “piano” per affrontare lo stadio finale del suo male anzi, sembra averla stimolata, sempre stando alle sue dichiarazioni. “Da una sensazione di riposo” aveva dichiarato in merito all’autorizzazione delle procedure qualora lei ne avesse fatto richiesta “Se non avessi ottenuto quei documenti penso che mi sarei già suicidata, perché è molto difficile vivere con così tanto dolore e sofferenza e questa insicurezza. So che quando sarà abbastanza per me, ho quei documenti”. Un percorso quindi, per quanto possibile, sereno, che viene però etichettato come dramma.
Premesso che ogni morte merita rispetto e rappresenta, a prescindere dalle modalità con cui avviene, un dramma per le persone care, per chi resta, viene da chiedersi come mai, a fronte di un percorso così dichiaratamente voluto (e annunciato) da parte della Vervoot, venga utilizzato un termine che richiama contesti ben differenti. La campionessa non è improvvisamente morta per un incidente o una tragica fatalità. Non ha deciso inspiegabilmente di togliersi la vita con un gesto inaspettato oppure è rimasta vittima di una catastrofe. È morta, come desiderava, secondo le condizioni che aveva scelto e nel rispetto della sua idea di vita. Il titolo però è abbastanza indicativo di una modalità di approccio al tema vita/morte considerato in Italia ancora un tabù. La mancanza di una legislazione in merito al fine vita solleva ogni giorno gravi questioni etiche per chi si trova a vivere, da italiano, a contatto con patologie terminali.
Ad oggi la situazione è abbastanza lineare nella sua iniquità: da una parte chi può permettersi un ultimo viaggio all’estero (sia dal punto di vista economico, che per il sostegno di amici o familiari disposti a sobbarcarsi, “ex post”, il carico di problematiche connesse a questa scelta), dall’altra chi non può.
Se puoi permetterti la scelta scegli, altrimenti ti vedi costretto ad andare avanti, sperando di trovare sul tuo percorso chi possa almeno accompagnarti con un’adeguata terapia del dolore. L’idea di vita, di dignità della vita, varia però molto da persona a persona. Ciò che per qualcuno è considerato intollerabile (vivere a letto attaccato ad una macchina ad esempio, non poter più parlare, relazionarsi), per altri è accettabile in nome di una lecita e più che rispettabile convinzione personale. Ogni posizione in questo senso deve essere sacra. Chi desidera protrarre le cure fino all’ultimo istante deve essere messo in condizione di farlo al meglio, indipendentemente da costi economici e sociali. Lo stesso dovrebbe essere garantito a chi decide che, invece, quella non è la sua strada. In Italia al momento questo non è garantito, né in un caso, né nell’altro. Spesso le famiglie sono lasciate sole nel percorso di cura, spesso le persone che non hanno una rete in grado di supportarle, devono trovare soluzioni “tampone”, non sempre corrispondenti a quelle desiderate. Ci sono famiglie che si indebitano, familiari che rinunciano al lavoro per poter garantire un’assistenza che lo Stato solo parzialmente copre. Questo per chi decide di vivere, comunque e fino alla fine. Dall’altra parte della barricata ci sono quelli che vorrebbero invece porre fine ad una vita che, per loro, non è più tale e non trovano risposte nel loro paese. Qualcuno ritiene sia un problema relativo a pochi casi, quindi di scarso interesse per il dibattito politico e pubblico.
Eppure alla base delle regole di vivere civile di uno Stato dovrebbe esserci la garanzia, per tutti, anche si trattasse di un singolo caso su un intera nazione, di esercitare la propria libertà, in coscienza e pieno rispetto per la libertà altrui.
Il tema è complesso, ma volendo semplificarlo, quali problemi presenta, per i diritti e la sicurezza degli “altri”, il fatto che una persona decida di ricorrere alla morte assistita? L’Ordine dei medici, lo scorso settembre, ha chiesto al futuro legislatore di sollevare i medici dall’atto finale, delegando ad un pubblico ufficiale la consegna del farmaco. Una delle tante possibilità, che si somma a quella, già prevista e garantita per legge, dell’obiezione di coscienza. E qui le analogie si sprecano. Buonsenso indica infatti che la presenza di una legge che garantisca la possibilità, per chi lo desidera, di fare ricorso ad una pratica (si tratti di eutanasia, aborto, divorzio, ma anche matrimonio, congedo parentale, congedo per assistenza) non implica che il cittadino debba farvi ricorso. Se non desidero prendere un congedo più lungo di quello obbligatorio nel momento in cui ho un figlio è mio diritto non farlo, ma ciò non implica che lo stato debba negare questo diritto a chi, invece, desidera prenderlo. Senza che questo mi tolga nulla. Allo stesso modo il fatto che esista una legge sull’aborto non obbliga nessuno a ricorrervi, anzi – stando alle statistiche – pare riduca il ricorso alla pratica. Come mai? Perché una legge ben fatta impone, a fianco di nuovi diritti, nuove responsabilità, per il singolo e per la comunità. Di assistenza, informazione, supporto in primis. Così, se la legge sull’aborto ha portato con sé una maggior consapevolezza in termini di contraccezione, diritti per le future madri, sostengo sanitario attraverso la diffusione dei consultori (trascurando per un momento la drammatica crisi che vivono oggi), allo stesso modo parlare di una legge sul fine vita potrebbe portare ad acquisire maggior consapevolezza delle “alternative” possibili e ad una loro capillare diffusione. Ad oggi le terapie del dolore sono ancora diffuse in modo disomogeneo nel nostro paese e, per quanto riguarda il sostegno e l’assistenza alle famiglie di malati cronici, con patologie degenerative o terminali, spesso è demandato ad associazioni di volontariato – più che meritevoli – e alla buona volontà della rete familiare.
E allora perché non ne possiamo parlare? Perché l’eutanasia, liberamente, consapevolmente scelta è oggi ancora un tabù che ci porta a parlare di dramma?
Forse il problema è che una scelta così netta e radicale ci mette in discussione. Mette in discussione il senso ultimo della vita, un sistema di valori sui quali, in molti altri casi (penso ad esempio alla pena di morte, così spesso invocata nei discorsi di tutti i giorni contro chi commette un crimine) non ci fermiamo mai a riflettere. Forse perché ci sembra più semplice imporre: la morte quando qualcuno si macchia di un reato per noi imperdonabile, la vita quando qualcuno ritiene che, a certe condizioni, non valga più la pena di essere vissuta. Nemmeno quando si è stati campioni sul tetto del mondo.

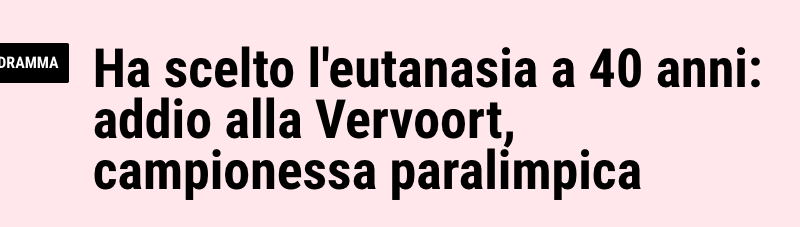





Devi fare login per commentare
Accedi