Partiti e politici
E se il più grande nemico di Matteo Renzi fosse proprio Matteo Renzi?
Da ieri Matteo Renzi non è più il Presidente del Consiglio. Dopo la direzione nazionale del Partito Democratico dove ha parlato in solitudine, rimandando ad altra data la discussione, è salito al Colle per rassegnare le sue dimissioni. Si apre dunque una nuova fase, dove l’ormai ex premier dovrà giocarsi le sue migliori carte per cercare di ritornare in sella dopo la rovinosa caduta del 4 dicembre, il giorno del “plebiscito mancato”.
Renzi in direzione sorride, attacca, prova a dettare la sua linea a un partito diviso e sconfitto, con i militanti a litigare all’ingresso del Nazareno durante il suo intervento. Un partito che di fatto non ha mai voluto guidare, perché poco dopo il suo trionfo alle primarie dell’8 dicembre 2013 scelse di andare a sostituire Enrico Letta a Palazzo Chigi. Lui, spesso paragonato a un giocatore di poker, sa che ora a dare le carte sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – che, da tetragono costituzionalista quale è, non sembra disposto ad anteporre la voglia di rivincita dell’ex sindaco di Firenze agli interessi del Paese – e soprattutto sa che in questo momento il vero leader silenzioso del Pd è Dario Franceschini, che controlla la larga maggioranza degli eletti e dei membri della direzione del partito. Una partita silenziosa quella dell’ormai ex Ministro della Cultura, al riparo dalle urla sguaiate dei fan più sfegatati di Leopolda s.p.a., così impegnati a travasare bile sui “traditori” della minoranza da non accorgersi che forse i pericoli per il loro beniamino sono ben altri. Ma oggi sarebbe totalmente inutile cercare di coinvolgere i più invasati supporter del renzismo in ragionamenti un po’ più evoluti rispetto al “fuori, fuori!”: le loro già non eccelse capacità sinaptiche sono state ulteriormente limitate da mesi di campagna elettorale giocata all’inseguimento del più becero populismo grillino, grazie alle trovate originali del gran guru americano Jim Messina, lo stratega che in meno di un anno è riuscito a far vincere nell’ordine la Brexit, Donald Trump e il No al referendum costituzionale del 4 dicembre. Jim saluta mestamente l’Italia consolandosi con un assegno a cinque zeri, staccatogli da un partito che nei territori fatica a pagare gli affitti delle sedi ed è spesso è costretto a chiuderle, come è avvenuto recentemente a Roma alla storica sezione di via dei Giubbonari.
Matteo Renzi, chiuso nel fortino insieme ai suoi fedelissimi (a molti di loro dovrebbe chiedere i danni per i folli consigli delle ultime due campagne elettorali), teme il logoramento e per questo ha posto come condizione alla formazione di un nuovo governo la partecipazione attiva delle forze che hanno sostenuto il No al referendum che ha bocciato la riforma costituzionale da lui proposta. Poca l’autocritica, a parte le solite parole di rito sul non essere stato in grado di convincere il popolo della bontà delle modifiche alla carta. Troppo poco di fronte a una sonora batosta elettorale subita per aver politicizzato il voto, trasformandolo in un vero proprio giudizio sull’operato del suo governo, se non addirittura in un sondaggio sul suo personale indice di gradimento. Renzi ha personalizzato il voto del 4 dicembre; la critica gli viene rivolta persino da alcuni renziani della sedicesima ora, che però lo giustificano con un assolutorio “sarebbe accaduto comunque, perché lo avrebbero fatto gli altri”. Ma è proprio così? In parte sì, ma lo stesso premier avrebbe potuto disinnescare sul nascere la polarizzazione del voto, se solo fosse stato in grado di battere il suo più grande nemico: Matteo Renzi.
L’ex sindaco di Firenze è spesso vittima del suo carattere, un carattere non facile al dire di molti che hanno lavorato al suo fianco in questi anni. Un carattere che non gli ha permesso di fare quel salto di qualità che trasforma un abile arrampicatore in un vero politico e magari un giorno in uno statista. Renzi eccelle in alcune cose, difetta terribilmente in altre. Ottima la sua capacità di creare empatia su di lui, una caratteristica in cui – limitando il campo visivo all’ultimo ventennio – è secondo solo a Silvio Berlusconi. A proposito dell’ex cavaliere: si dice che abbia scelto di ri-scendere in campo a meno di sue settimane dal voto su consiglio della fidatissima sondaggista Alessandra Ghisleri, che lo ha avvertito della probabile valanga di No. Pare che con qualche apparizione televisiva sia riuscito a spostare oltre il 4% di indecisi. Un impatto a dir poco mostruoso.
Ma torniamo a Matteo Renzi, o “Matteo” come lo chiamano i parenti e gli amici più cari. Un’altra delle sue innate qualità è quella di sapersi posizionare, colmando quei “vuoti” che periodicamente si formano in politica. E nell’Italia post “via Olgettina” il grande vuoto si è creato nel campo moderato, orfano di un vero leader conservatore e “tappato” da quel signore di ottant’anni di cui ho parlato poche righe più su. Un campo a cui il segretario del Pd ha puntato con estrema convinzione, scaricando lo storico zoccolo duro dell’elettorato di sinistra che pur con tanti distinguo aveva come riferimento il Pd, dai docenti ai lavoratori della p.a., dal sindacato al mondo della cooperazione. Si dice che con lui il Partito Democratico abbia subito una sorta di “mutazione genetica”, ma nell’era post ideologica è errato pensarlo, basti vedere il Labour Party di Jeremy Corbyn in Inghilterra. Renzi avrebbe dovuto provare a tenere insieme i vecchi e i nuovi mondi, ma non è stato in grado perché per farlo avrebbe dovuto immolare una parte del suo ego alla causa. Lui, che rende così tanto quando deve andare allo scontro, avrebbe dovuto mediare. Ma mediare non è nelle sue corde e non sappiamo se mai sarà in grado di farlo.
E qui veniamo alle dolenti note, i veri grandi limiti di Matteo Renzi: diplomazia e gestione del potere. La prima è una delle basi della politica ed è una dote innata, difficilissima da imparare. Prendete dei bambini all’asilo: c’è chi ruba le merendine dai cestini degli altri, chi addenta con foga la sua merendina guardando in cagnesco chi gli si avvicina e chi distribuisce pezzetti di merendina ai compagni, soprattutto a quelli in cui percepisce una punta di invidia negli sguardi, sapendo che il favore sarà restituito alla prima occasione. Il primo bambino potrebbe avere un ridente futuro nel vasto campo dell’economia o in quello della criminalità organizzata, il secondo aspira a far parte della massa, che va da chi fatica ad arrivare alla terza settimana a chi eccelle e si sente realizzato dal suo lavoro, il terzo potreste ritrovarvelo ministro del lavoro trent’anni dopo. Ora provate a immaginare cosa sarebbe accaduto se l’ex premier avesse mandato uno stimatissimo Massimo D’Alema a far bella figura a Bruxelles al posto della volenterosa Federica Mogherini. Senza aprire gli occhi, immaginate ora un Mario Segni qualsiasi a mettere la faccia sul Sì al referendum costituzionale, con il premier a continuare a fare il suo lavoro e un po’ in disparte a lanciare messaggi distensivi, contrari a quelli da “sfida capitale” che gli hanno suggerito i “grandi strateghi” di cui si circonda. I pezzetti di merendina regalati tornano sempre indietro, specialmente quando si ha più fame.
I “grandi strateghi”, appunto. Sono la conseguenza della più grande pecca di Matteo Renzi: la sua incapacità di gestire il potere. L’ex premier si fida di pochi, pochissimi fedelissimi. La sua cerchia ristretta è formata da molti di quelli che lo accompagnano già dalla prima Leopolda e da qualche “adorante” raccolto durante la scalata. Ma per gestire il potere serve anche l’apporto di menti critiche, persino degli oppositori più distanti, che in molte situazioni possono rivelarsi assai preziosi, proprio perché guardano la realtà da prospettive diverse, allargando il campo visivo degli stessi leader. Renzi ha pensato di poter trionfare in solitudine; quelli che voleva “rottamare” (concetto alla base dei suoi fallimenti) hanno aspettato che si “rottamasse” da solo. Riuscirà a riprendersi già da subito, magari accettando un reincarico o appoggiando un governo istituzionale? Lo vedremo. L’ex sindaco di Firenze ha ancora molte carte da giocare, prima fra tutte l’essere ancora l’unica vera novità in campo a capo di un partito, se pur disastrato. Ma la prima cosa che dovrà fare è smettere di ascoltare gli invasati che in queste ore gli raccontano che quel 40% è tutto suo. Sarebbe un buon inizio per cominciare a imparare dagli errori e provare a vincere le elezioni politiche. Quelle vere, non quelle che lui ed altri hanno voluto anticipare mettendo in mezzo la Costituzione.

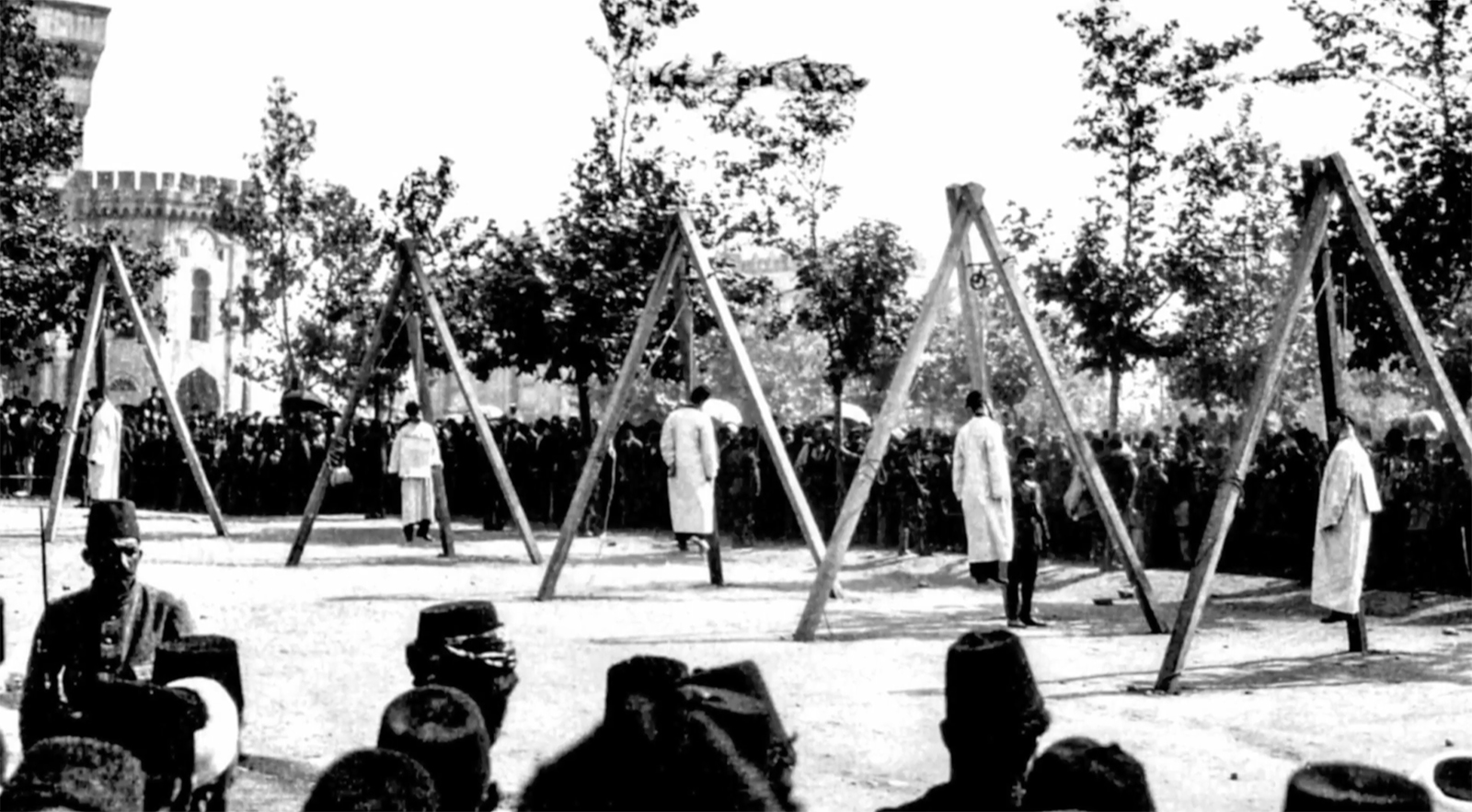



Devi fare login per commentare
Accedi