
Governo
Ocse: la flessibilità non crea occupazione. Con il Jobs Act sarà diverso?
Uno degli obiettivi “ufficiali” del Jobs Act è quello di frenare il fenomeno dei contratti a termine. Il Quinto Stato dei Precari è diventato ufficialmente un soggetto politico. Nel 2013, infatti, solo il 16% dei nuovi assunti aveva un contratto a tempo indeterminato, secondo lo stesso Ministero del Lavoro.
I dati nel 2014 non sono cambiati: i “precari”, intesi come lavoratori con un contratto (di vario tipo) a tempo definito (e cioè a scadenza), rappresentano circa l’85% dei nuovi assunti. Nel secondo semestre 2014, sono stati avviati 2.651.648 rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato. Di questi, solo 403.036 a tempo indeterminato – il 15%- mentre il resto – l’85% – sono contratti temporanei.
I dati del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico parlano chiaro: negli ultimi tre anni i dipendenti assunti con un contratto a tempo indeterminato sono sempre di meno: le assunzioni a tempo indeterminato sono diminuite dello 0,6% nel 2011, del 3% nel 2012 e dell’11,5% nel 2013.
Sono diminuiti percentualmente anche i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, di apprendistato e di collaborazione, fatto che lascia supporre che in un momento di contrazione della forza lavoro occupata, la soluzione scelta dai datori di lavori sia quella di non rinnovare i contratti a termine, che non hanno “costi di dismissione”, come si potrebbe dire in burocratichese.
Nel nostro paese, infatti, come scrive il professor Patrizio Di Nicola dell’Università La Sapienza di Roma, sono attive ben 50 forme contrattuali e paracontrattuali (stage, tirocini, dottorandi, eccetera) per i precari, tutte nate nel corso degli ultimi anni, principalmente grazie alle leggi Treu e Biagi.
Negli ultimi anni, le tipologie di contratti a termine sono aumentate non solo in Italia, ma anche in Europa. La tesi ufficiale che giustificava, per lo meno in Italia, la nuova produzione legislativa in merito a forme contrattuali più “elastiche” era quella enunciata da Treu: “Ho cambiato il lavoro ed è più facile trovare posto!”.
Una maggiore elasticità della forza lavoro avrebbe consentito agli imprenditori italiani di assumere di più, senza aver paura di ritrovarsi di fronte un lavoratore illicenziabile, protetto da una legislazione troppo rigida anche in una fase di down economico, in cui le imprese non potevano sopportare il costo di mano d’opera in eccesso.
Data la semplicità dell’assunto: “più contratti di lavoro a termine = più assunzioni”, abbiamo usato due indicatori per verificare se effettivamente il mercato del lavoro, non solo in Italia, ma anche in Europa, ha risposto positivamente ai nuovi impulsi arrivati dai nostri politici-economisti. L’analisi è stata svolta su un campione significativo di paesi europei*.
Il tasso di “precarietà” dell’OCSE
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) studia il mercato del lavoro ed elabora degli indici per valutare quali siano i gradi di protezione legislativa dei contratti di lavoro “regolari” e “temporanei”.
Nella prima categoria rientrano le tipologie di contratti dove il lavoratore viene assunto senza che venga definita la “data di scadenza” del rapporto di lavoro, mentre nel secondo tipo di contratti, quelli “temporanei”, i lavoratori vengono impiegati per un periodo definito in anticipo. Entrambe le categorie di contratti seguono dettami legislativi stabiliti a livello nazionale, che mutano quindi da nazione a nazione.
L’indicatore dell’OCSE che abbiamo analizzato si chiama EPV_1, e varia da 1 a 6.
Misura quanto sono “protetti” i contratti a tempo determinato. Più l’indice è basso, e meno sono tutelati i lavoratori che hanno un contratto di questo tipo. Per costruire l’indicatore, l’OCSE ha utilizzato una serie di item che riguardano, tra l’altro:
1. le tipologie di lavori per i quali è possibile utilizzare lavoratori a temine;
2. quanti sono i rinnovi permessi per le diverse tipologie di contratti a termine;
3. quando l’azienda è obbligata a dichiarare la presenza di lavoratori precari;
4. quali sono le disparità di trattamento tra lavoratori regolari e precari presso la medesima impresa utilizzatrice.
Per capire cosa misura realmente l’indicatore, basta ricordare come una delle ultime polemiche relative ai contratti di collaborazione è proprio quella relativa ai mesi per i quali è possibile rinnovarli: 24 o 36. Più lungo è il periodo concesso al datore del lavoro per applicare una forma contrattuale “a termine”, e meno viene considerato tutelato il lavoratore. E più basso sarà quindi l’indice.
Si nota subito come in molti dei paesi europei esaminati, il tasso di “precarizzazione” sia molto aumentato nel periodo in esame, in particolare in Spagna, Italia, Grecia, che sono le nazioni più toccate dalla crisi economica degli ultimi anni.
Ma, più in generale, si nota come la protezione delle forme di lavoro temporaneo sia diminuita anche in paesi come la Francia e la Germania. Non abbiamo svolto nessuna indagine sulla stampa straniera per verificare se le motivazioni politico-economiche delle nuove legislazioni in materia di lavoro fossero simili a quelle fornite dall’ex-ministro Treu, ma la ricetta economica neo-classica prevede proprio che all’aumento dell’elasticità del fattore lavoro, debba corrispondere una maggiore offerta (e cioè richiesta di forza lavoro da parte degli imprenditori).
Impossibile non farsi una domanda: in Europa, la presumibile ricetta neoclassica ha funzionato?
La disoccupazione è diminuita?
Abbiamo esaminato, per lo stesso periodo storico, dal 1985 al 2015, il tasso di disoccupazione nei paesi del campione europeo che abbiamo selezionato (i lavoratori assunti con un contratto a termine sono naturalmente considerati impiegati). Come si può vedere, la disoccupazione è aumentata, nonostante le nuove forme contrattuali adottate siano diventate decisamente più elastiche che in passato.
La disoccupazione è aumentata soprattutto in Italia, Spagna, Grecia, dove sono state adottate misure legislative drasticamente a favore dei contratti a tempo determinato. Il tasso di disoccupazione è naturalmente legato al PIL, che dal 2008 ha avuto un tasso decrescente nei tre paesi considerati.
Secondo la legge di Okun, per mantenere inalterato il tasso di disoccupazione, il PIL deve aumentare del 2,7% all’anno.
Non possiamo quindi escludere che senza la maggiore flessibilità della forza lavoro, la disoccupazione non sarebbe stata ancora più elevata.
Quello che però possiamo scartare è l’ipotesi che una maggiore flessibilità della forza lavoro abbia degli effetti visibili, positivi e immediati sull’occupazione.
Inspiegabile, altrimenti, la coincidenza secondo la quale i tre paesi dove il tasso di precarizzazione è aumentato, sono anche quelli in cui è aumentata di più la disoccupazione.
Basta il colpo d’occhio…
Nei due grafici seguenti abbiamo utilizzato una diversa disposizione grafica dei dati (di tipo cumulativo) che rende ancora più evidente le conclusioni alle quali si può giungere: “più contratti di lavoro a termine non portano a più assunzioni”.
L’analisi di due soli indicatori – “precarietà” dei contratti a termine e disoccupazione – sembra quindi far concludere che una maggiore elasticità del lavoro non porta automaticamente ad una maggiore occupazione: anzi, non sembra esservi nessuna correlazione tra i due fattori.
L’unico risultato raggiunto, per lo meno in Italia, dalla produzione legislativa che ha moltiplicato – e agevolato – le forme contrattuali “atipiche”, è stato quello di aumentare il numero di lavoratori precari, che oggi rappresentano l’85% dei nuovi assunti.
Il nuovo contratto a “tempo indeterminato” del Jobs Act
Tra le intenzioni del Jobs Act vi è appunto quella di favorire il nuovo contratto a tempo indeterminato che offre le stesse garanzie – ferie, maternità, eccetera – di quello “vecchio”, ancora protetto dall’Articolo 18 e tuttora in vigore per i lavoratori che risultavano assunti al 1 gennaio 2015.
La differenza tra le due tipologie di contratto a tempo indeterminato – quella “nuova” e quella “vecchia” – riguarda fondamentalmente i licenziamenti.
Con il contratto a tutele crescenti, sarà possibile licenziare i lavoratori corrispondendo loro semplicemente un indennizzo: da un minimo di quattro mensilità, fino al massimo di ventiquattro. Il diritto al reintegro del posto di lavoro è previsto solo nel caso dei licenziamenti discriminatori, e solo in un particolare tipo di provvedimento disciplinare: quando non sussiste il fatto di cui è accusato il dipendente. Gli stessi licenziamenti collettivi, che fino ad oggi dovevano essere concordati con le parti sindacali, vengono di fatto “liberalizzati”: le aziende potranno licenziare i lavoratori utilizzando il metodo della semplice compensazione economica.
Il nuovo contratto è quindi, nella sostanza, un contratto a termine che garantisce più diritti ai lavoratori, ma costringe le imprese a versare gli stessi contributi previdenziali previsti per i contratti a tempo indeterminato di tipo “vecchio”.
Si tratta quindi di un contratto più costoso, per le imprese, dei contratti a tempo determinato.
Ma il governo ha previsto di dare un incentivo fiscale – fino a circa 8.000 euro per ogni lavoratore e per tre anni consecutivi – alle aziende che assumeranno con il nuovo contratto. L’obiettivo del governo sembrerebbe infatti proprio questo: incentivare le aziende perché assumano nuovi lavoratori con il nuovo contratto “a tempo indeterminato”.
Le aziende potranno comunque utilizzare ancora i vecchi contratti a termine, rinnovabili fino a 36 mesi. Sono stati eliminati dal Jobs Act solo i Co.Co.Co e i Co.Co.Pro. (che riguardano circa 200.000 lavoratori), il Job sharing e l’associazione in partecipazione, mentre rimangono attive altre tipologie di contratto come il lavoro intermittente, il part-time elasticizzato, i voucher (fino a 7.000 euro all’anno), il lavoro a somministrazione.
Si tratta quindi di aspettare qualche mese per capire se gli imprenditori adotteranno il nuovo contratto a tempo indeterminato invece di quelli a termine. E bisognerà aspettare altri tre anni per capire se le imprese che hanno adottato il “nuovo” contratto a tempo indeterminato, continueranno a usarlo anche una volta che saranno spariti gli incentivi fiscali (a carico dello stato, e quindi dei contributori).
Se vogliamo misurare gli effetti del Jobs Act, dovremo quindi tenere d’occhio le statistiche del Ministero del Lavoro sui nuovi assunti.
Nel caso in cui la percentuale di contratti attivati a tempo indeterminato – che saranno solo di tipo “nuovo” – resti stabile, allora il Jobs Act non avrà avuto nessun effetto, se non quello di eliminare la vecchia forma di contratto a tempo indeterminato, senza per questo eliminare o contenere il fenomeno del precariato.
* Paesi del campione: Italia, Francia, Belgio, Grecia, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia.


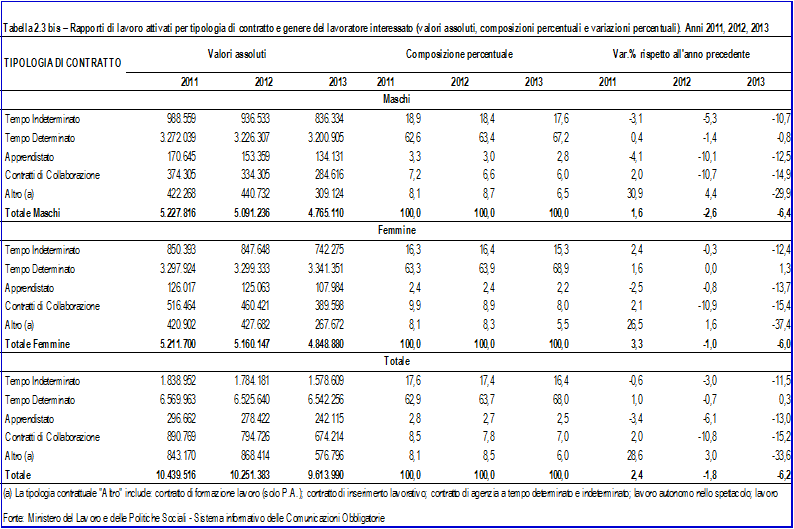








Devi fare login per commentare
Accedi