Letteratura
La ricognizione del dolore: Gesualdo Bufalino
“Che giorni, che serate. Forse i soli giorni ricchi di un’esistenza che non ha avuto altre iperboli, dopo, e s’è fatta inaspettatamente interminabile.”
Gesualdo Bufalino sembra rimpiangere, con queste parole, l’iperbole che è stata per lui ammalarsi e inaspettatamente guarire dalla Tisi poco più che ventenne. Esperienza esorcizzata nel suo romanzo Diceria dell’untore.
Un libro concepito in più di trent’anni che fa pensare alla vita di una stella, le cui parole sono atomi che decadono in elementi sempre più pesanti fino a collassare in un nucleo esplosivo che sarà la pubblicazione del testo, a lungo tenuto a freno.
Allenate per una guerra sempre rimandata, le parole sono state un esercito caricato e preparato dall’autore così a lungo che il risultato di questa gestazione è un libro che, in un certo senso, li contiene tutti.
Il dolore della sopravvivenza, lontano dai territori sacri dei sommersi e dei salvati, conosce, talvolta, sfumature meno edificanti e profetiche.
Nella registrazione della quotidianità, correggere le piccole grandi delusioni con la gratitudine dello scampato o con la maledizione del marchiato può diventare un esercizio di alienazione.
La malattia, ma soprattutto la diagnosi nefasta poi non rispettata, funzionano per Bufalino come la pillola rossa o blu in Matrix e come in uno sliding doors la realtà convenzionale cammina a fianco di quella particolare anti-realtà che sono le parole.
“Il fatto è che a me interessano più i colpi di scena delle parole che non i colpi di scena dei fatti e che non cerco di mimare in nessun modo il reale”
Ecco perché Bufalino diventa smisurato e quasi imbarazzante per la padronanza del linguaggio, ecco perché gli strati di senso si moltiplicano in modo caleidoscopico, ecco perché si tratta di un libro incantato.
Non nel senso della montagna, però.

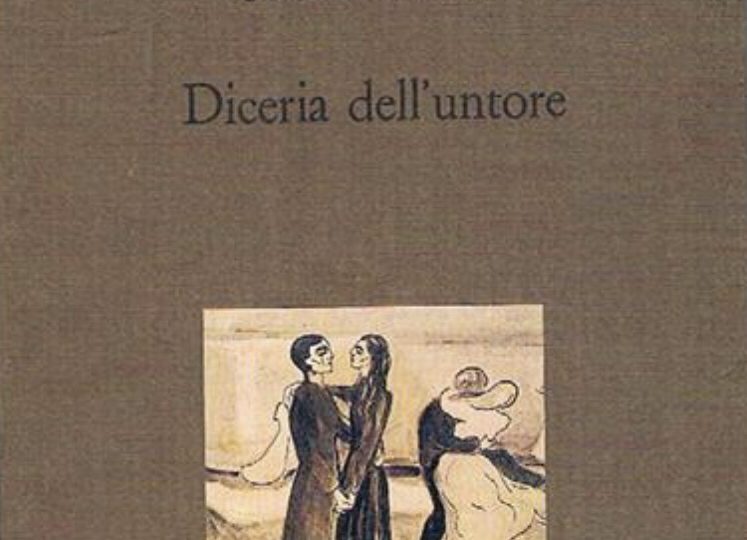
Devi fare login per commentare
Accedi