Letteratura
Alberto Moravia e il mare
Ho intercettato qualche mese fa un passaggio televisivo in cui Raffale La Capria – che è nato e vissuto a Palazzo Donn’Anna sul mare dove ha ambientato il romanzo tanto sperimentale quanto marino “Ferito a morte”-, diceva con un velo di tristezza che il mare, come lo avevano lasciato gli Dei, è morto intorno al 1960. Non ho faticato a crederci. Per me nato in località di mare, che nuotavo già da ragazzino nell’acqua alta degli scogli nel mare più mare del mondo di Aci Trezza, Aci Castello, Scogliera di Catania – un mare fresco, profumato, profondo, pieno di pesci, un mare scomparso – non c’è verità più amara. Goletta verde ha certificato questa estate 17 siti inquinati su 27 in Sicilia. Colibatteri fecali, fogne.
Nei tardi anni ’70 ho assistito all’assassinio del mare. Successe un giorno d’estate di un anno di quel decennio, forse il 1975. Mi trovavo nella baia di Santa Caterina di Acireale, sott’acqua, alla caccia dei miei amati polpi che pescavo in apnea senza fiocina, zampa di gallina, gancio o “pietra celeste” (solfato di rame, che molti usavano per bruciare gli occhi del polpo e farlo uscire dalla tana). La mia era una caccia ad armi pari: i tentacoli della mia bestia e le mie mani. Perlustravo con la maschera per ore a pelo d’acqua gli anfratti dei fondali e poi adocchiato l’octopus furbescamente mimetizzato – tenero l’animale quando faceva la tana con i sassolini disposti a cerchio all’imbocco, un segnale inequivocabile per me-, con decisi colpi di pinne lo raggiungevo anche a dieci quindici metri sott’acqua, e iniziavo la mia lotta. Spesso, ma non sempre, riemergevo con le mani sanguinanti, graffiate dai ricci o dai tagli di roccia e talora con il sangue dal naso per via della pressione, ma trionfante con la mia preda che si attorcigliava attorno al braccio.
Quel giorno un boato improvviso squarciò il silenzio del blu del mare. Riemersi spaventato; a una trentina di metri da me vidi una barca galleggiare sbilenca sotto il peso di alcuni ossuti pescatori in piedi, che inveirono contro di me in un cavernoso dialetto. Poi li vidi raccogliere lesti e furtivi con dei giganteschi acchiappafarfalle centinaia di pesci galleggianti a pelo d’acqua. Avevano buttato una bomba quei derelitti e adesso raccoglievano il bottino: pesci dalla schiena spezzata, polpi atterriti con gli otto tentacoli aperti a stella, ricci e “minchie di mare” totalmente sminchiate. Seppi che questa pratica sciagurata, tollerata o non repressa, invocando la sanatoria che il popolo ha fame e che deve mangiare, era invalsa da qualche lustro e praticamente aveva desertificato i fondali irrimediabilmente per i prossimi evi. Sciagurati loro, ferito a morte io.
Il ricordo del mare dell’infanzia mi ha tenuto in vita negli anni delle mie prime nebbie lombarde, negli inverni del mio scontento. E adesso appena posso, ormai sazio del verde intenso e sereno delle campagne lombarde che adoro – nei dintorni di Lodi ancora si estende a perdita d’occhio il verde multiplo e marezzato dei campi fin quando l’ultima TEEM o BREBEMI non lo profanerà per sempre – e sento che ho bisogno della mia azzurrità: quella quota che mi tocca ancora, finché dura.
***
Giornate di letture e di acqua salata, di scaglie di luce su tremolanti orizzonti marini, di smemoramenti volontari dalla vita attiva che fu, si sono succedute serene questa estate che si chiude. Non avendo più spazi in casa leggo solo saggi in verità e solo in ebook. (Qui ne ho fatto l’elogio) La narrativa ha perso attrattiva ai miei occhi. Non “me la bevo” più così facilmente come quando “Il rosso e il nero” mi aprì alla vita. Ai romanzi dei russi, dei francesi e dei siciliani devo il mio radicamento giovanile nel mondo, ai saggi chiedo oggi, nell’età declinante, gli ultimi, speriamo penultimi, rischiaramenti. In preda a vera e propria lussuria di lettore scomposto e disordinato, e con la scusa di recensore avventizio di “Stati Generali” dove riverso il mio minestrone, leggo disordinatamente di islam, di sinistra estrema (un saggio sull’idea di rivoluzione in Italia, dagli operaisti ai terroristi, un saggio freddo e puntuale di Angelo Ventrone); qualche libro (di Garelli e Rella) sul pensiero figurato di Hegel, mia vecchia passione, quello di Huntington sullo scontro di civiltà. E poi gli svelti trattatelli di intellettuali italiani geniali: Raffaele Alberto Ventura, pungente il suo saggio sulla classe disagiata, Claudio Giunta, scintillante e coraggioso l’assedio del presente, e Edoardo Lombardi Vallauri che morde il comune sentire cattolico dei Peninsulari. E poi l’ebook di Said sull’Orientalismo, ma anche vecchi Renan, Taine e Gobineau scaricati a niente dalla rete, autori rimandati ad anni meno ansimanti per un improbabile approfondimento dell’intellettualità del Secondo Impero in cui ho parecchie letture. Nella lingua tanto amata dell’Esagono leggo un irriverente e liberatorio François Cavanna “Les culs-béni”, il Barnavi delle religioni assassine e altri saggi sui temi che inquietano la Francia e l’Europa di oggi alle prese con in barbus islamici. La Francia, in genere detestata dai miei connazionali (ah la grandeur, dicono infastiditi) quanto amata da me (ah la grandeur, dico ammirato: cinque secoli ininterrotti e strabilianti di romanzieri e saggisti che non ha eguali nel mondo, da Rabelais a Houellebecq). Insomma giro e rigiro come un pesce nervoso attorno a quell’enigma che è l’illusione totale delle religioni, che nonostante i buoni e i volenterosi, temo ci porterà al crash definitivo. Grazie a Dio.
Nella casa del mare l’anno scorso ho piluccato un Ercole Patti delizioso, quest’anno, mollando la catena dei saggi in ebook, in questi ultimi giorni di mare, prima di abbandonare la costa ionica della mia infanzia, ho preso respiro con il cartaceo “1934” di Moravia che avevo letto appena uscito negli anni Ottanta. Evi sereni e lontani anni luce dalle angosce di oggi. Si leggevano libri à bout de souffle allora, e non rapsodici lembi di internet come oggi.
***
“1934” è come l’emozionante “Agostino” un romanzo marino. È ambientato a Capri nell’estate del 1934. Il protagonista, Lucio, intellettuale antifascista, ha 27 anni come Moravia e come Moravia è alle prese con un romanzo che non riesce a scrivere. Lo scrittore in “crisi”, ingrippato, in un romanziere fluviale come Moravia, è uno strano motivo ricorrente. Fa sospettare la posa se non fosse che Moravia fu un intellettuale sincero. Basta leggere i suoi saggi critici e i suoi interventi pubblici per accertarsene. Ricordo che “La vita interiore” – il romanzo che lessi lungo l’interminabile tragitto ferroviario verso Milano nel luglio del 1978, nell’estate in cui abbandonavo per sempre il mare, i polpi, la Sicilia, fu preceduto e accompagnato da interviste in cui Moravia dichiarava lo stato di prostrazione fino alla tentazione del suicidio che lo aveva tormentato nella redazione del romanzo, le continue riscritture, i sette anni faticosi spesi nella gestazione.
All’imbocco della narrazione di “1934” c’è un pensiero terribile « È possibile vivere nella disperazione e non desiderare la morte?» Eccoci già in ambiente moraviano, immersi in atmosfere “esistenzialiste”, ma non sono io a scegliere il termine, era lo stesso Moravia a reclamarne l’etichetta e la primazia in Europa per le sue opere. Indifferenza, noia. Termini/motivi moraviani. Adesso disperazione. In realà questo tema “filosofico” che potrebbe atterrire chiunque ha l’astuta funzione (non so quanto presente deliberatamente alla coscienza dell’autore) di costituire, in quanto “nodo”, “grumo” filosofico, il contraltare intenzionale alla fluidità della narrazione moraviana, che secondo le mie valutazioni di lettore è sempre superba. Infatti il tema filosofico terribile si “scioglie” seppur nella rappresentazione statica, quasi teatrale (non c’è avventura o azione nei libri di Moravia, ci sono “scene” in stanze chiuse, c’è il Kammerspiel, il teatro tragico da camera) ma svolta nei modi di una narrazione fluida e uncinante. Perché Moravia in mezzo alle sue quinte teatrali (mimesi) pone quell’esca penzolante che è il sesso che “innesca”, è proprio il caso di dirlo, la diegesi, il puro racconto. Del sesso si sente quasi l’odore in questo romanzo misto all’odore del mare.
Entrò Carla. Sono le prime due parole degli “Indifferenti”. Qui entra Beate Müller, giovanissima tedesca in vacanza, incontrata sul vaporetto. È una donna enigmatica, lettrice di Kleist, dall’identità sfuggente, sembra suggerire da sé scenari suicidi; è al seguito del marito nazista fotografo. Posa nuda tra i faraglioni e il marito sembra favorire il voyeurismo di Lucio. La tensione erotica è condotta allo spasimo, attendiamo da un momento all’altro la notte di sesso infuocato. Ma improvvisamente Beate e il marito partono. Arrivano al loro posto la sorella gemella di Beate, Trude, e la madre Paula. Trude è nazista fanatica. Sensuale e volgare. Si fa masturbare da Lucio con il piede, in barca. Si spinge a chiedergli la prova visibile della sua non circoncisione, del suo arianesimo. Viene introdotto il tema arciletterario del Doppelgänger: Lucio attraverso Trude spera di arrivare a Beate, poi accetta l’amore vicario di Trude, quindi il colpo di scena, la rivelazione che Beate e Trude sono la stessa persona. Ma resta l’incertezza: è Trude a inventarsi il personaggio di Beate, o Beate quello di Trude? L’enigma aleggia in tutta la storia fino al tragico epilogo della morte del marito nella “notte dei lunghi coltelli” avvenuta in quel 1934 e del suicidio di Beate-Trude insieme a Paula, che non è la madre, ma l’amica, come lei omosessuale. Ho osato lo spoiler del romanzo perché non è nel finale che risiede il fascino dei romanzi, ma nello svolgimento, e francamente come va a finire un romanzo a me non è mai interessato; so con Forster (“Aspetti del romanzo”) che nel finale tutti i romanzi diventano deboli. Il finale è una convenzione, uno vale l’altro, come una vita vale l’altra per Moravia (perché in fondo son tutte sbagliate, aggiungeva); solo nei gialli il finale trova la sua insulsa centrale necessità.
***
A me spiace molto l’oblio in cui è caduto Moravia, scrittore a cui sono molto legato, per le seguenti ragioni che provo di corsa a sintetizzare:
– ha scritto in un italiano standard, moderno e referenziale, lontano dai mandarinismi linguistici degli intellettuali italiani. Il suo italiano può sembrare falso, “da doppiatore” cinematografico, ma in verità resta un potente mezzo di comunicazione nell’epoca in cui le masse si affacciano al mondo della lettura. Moravia è un intellettuale colto che vuole uncinare l’inclita. Non si sente alcun accento dialettale nella sua opera, nonostante la sua iper-romanità (leggere la sua romanissima prefazione alle “Passeggiate romane” di Stendhal;
– ha aperto alla narrativa, senza ipocrisie, la camera da letto agli italiani (che incuriositi sono accorsi in massa all’inizio, non senza pruderie, e poi, ipocriti, non gliel’hanno perdonata). Ha colto il mondo sotto il segno delle urgenze sessuali, come Balzac sotto il segno del denaro;
– a dispetto delle apparenze è scrittore polimorfo e sperimentale. Esempi: ficcare il teatro con l’unità di luogo di tempo di azione nel romanzo (“Gli Indifferenti”); inventarsi un altro punto di vista narrativo tra la prima e la terza persona (ne “La vita interiore” appare la seconda persona, il “tu” narrativo!, il romanzo è infatti raccontato sotto forma di lunga intervista); scrivere racconti con voce femminile etc), ha scritto favole e racconti;
– oltre che narratore instancabile è anche “scrittore” in proprio (ossia ha una sua personale, riconoscibile, visione del mondo). Il suo è uno strepitoso esistenzialismo erotico, a mezza via tra Dostoevskij, lo scrittore a cui guardava da giovane e una sorta di Retif de la Bretonne, ma un poligrafo in cui sesso e idee si rubano la scena, perché premono sulla pagina con la stessa cogenza. Benché tarlato da choc puberali evidenti, da malattie invalidanti e da rimozioni psicoanalitiche, fu progressista, ossia ottimista e consentaneo ai tempi. Temeva giustamente la bomba atomica;
– non solo narratore esperto e scrittore con una propria visione del mondo, ma anche letterato saputo e critico pungente. Leggere i suoi interventi critici, raccolti ne “L’uomo come fine” o “L’intervista sullo scrittore scomodo” sempre acuti, intelligentissimi, tonifica la mente;
– ha avuto una vita artistica che gli ho sempre invidiato. La biografia di Elkan (bella) ne dà un mirabile resoconto. Era un dandy annoiato e un letterato “puro”. Il suo impegno è stato sempre controvoglia (come recita il titolo di una sua raccolta di saggi critici di attualità). Ma non ha perso mai il contatto con i problemi sociali della propria epoca.
Oggi, nei nostri tempi vorticosi e angoscianti è quasi dimenticato. Ma resta nel mio pantheon privato nelle primissime nicchie unitamente ad un autore che per certi versi è il suo opposto: Gadda. So che in giro è nato anche un antigaddismo dei critici, come quello dell’irresistibile critico Matteo Marchesini. Rileggere, per capire ciò che voglio dire, il capitolo “Che cos’è un generale” nel volume critico su Gadda “La disarmonia prestabilita” di Giancarlo Roscioni. Moravia dava di un generale la sua evidenza fenomenica, Gadda la sua intrinsichezza noumenica. Non si tratta solo di “esterno” o di “interno”, ma di punti di vista prospettici: quello di Moravia è frontale (ma con sbirciatine all’inconscio dei personaggi) quello di Gadda è prismatico, privo di un unico focus su cui far convergere le linee narrative/interpretative, ma con molti angoli visuali, come nella “Guernica” di Picasso. Inoltre per quel che riguarda il “trattamento” stilistico, ossia l’esposizione del discorso che regge la storia (la somma delle offerte retoriche di una pagina scritta) Moravia è un “attico” e Gadda un “asiano” con tentazioni di “satira menippea” (Bachtin). Entrambe le torniture stilistiche – che invero sono due precise visioni del mondo – perché lo stile è l’uomo – hanno grande tradizione nella nostra letteratura occidentale e pieno diritto di cittadinanza. Io stesso certe ore del mattino mi sento attico, chiaro, trasparente e solido come una colonna scanalata di un tempio greco, e a partire dalle ore pomeridiane asiano, torbido, dissestato o attorcigliato come una colonna del Bernini.
O – inattesa complicazione – anche viceversa.
^^^
Nella foto di copertina. Di Herbert List, “Capri 1936”.



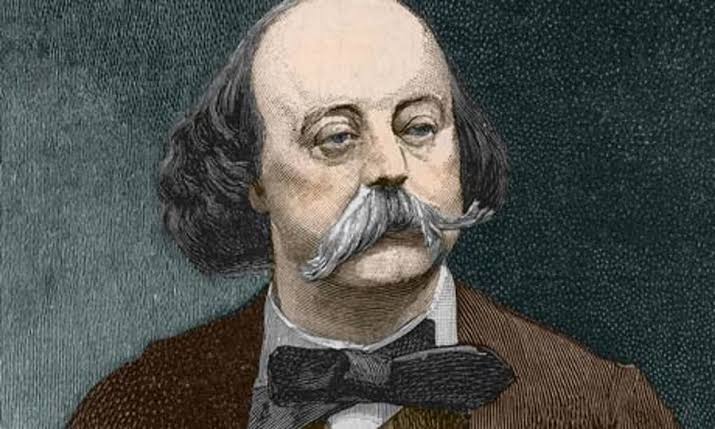

Devi fare login per commentare
Accedi