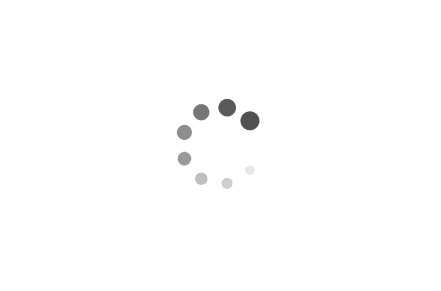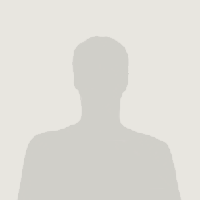«Over-focus on startups is a bad policy». Concentrarsi troppo sulle startup è sbagliato. A dirlo non è un nostalgico della “vecchia economia” ma il professore di Entrepreneurship Practice Daniel Isenberg sulle colonne della Harvard Business Review. La nuova tendenza è quella di puntare tutto sulle scaleup, secondo la definizione del World Economic Forum che divide in tre fasi la vita di un’impresa innovativa: stand-up, start-up, scale-up. La terza fase riguarda quelle poche, pochissime imprese (tra l’1 e il 6% del totale) in grado di affermarsi, generando crescita e occupazione. «Bisogna concentrarsi nel creare corsie per le macchine più veloci», sintetizza il docente statunitense.
Ma quali sono le “macchine veloci” In Italia? Poche, pochissime, e il più delle volte hanno bisogno di grandi investitori internazionali per arrivare all’agognata exit. In Italia infatti – al momento – non ci siamo ancora concentrati troppo neanche sulle startup stesse, benchè secondo Gabriele Ronchini, presidente di 4wMarketPlace, primo network pubblicitario italiano e scaleup dell’incubatore Digital Magics, «almeno dal punto di vista burocratico il sistema è migliorato dal 2012, quando è stato istituito il Registro delle imprese innovative». Manca però il contributo decisivo del venture capital, ovvero dei fondi d’investimento istituzionali, pubblici e privati, che nel 2014 hanno investito in Italia 63 milioni di euro in startup: la metà della Spagna e un decimo della Francia, dove ci sono una sessantina di fondi contro i nostri sei. La cifra per il 2015 è più o meno la stessa, arrivando a sfiorare – secondo alcune stime, tra cui quella del sito StartupItalia! – i 100 milioni complessivi considerando però anche il business angel, ovvero gli investimenti “informali” (spesso di carattere mecenatistico) da parte di privati; il crowdfunding, ossia il finanziamento collettivo tipo colletta online, che negli Usa con la sola piattaforma di Kickstarter ha quasi raddoppiato la raccolta a 133 milioni ma che da noi vale poco più di 50 milioni di euro in tutto, di cui solo un quinto destinato a innovazione imprenditoriale (e con una percentuale di successo in calo al 30%, a testimonianza di un sistema non del tutto maturo); e il contributo di acceleratori e/o incubatori.
Proprio da un incubatore, Digital Magics (quotato a Piazza Affari), è nata nel 2008 l’avventura di 4wMarketPlace, AD network da 12.000 publisher e 10 milioni di euro di fatturato: una lotta ancora impari col gigante Google, ma una crescita che vale la leadership sul mercato dell’advertising tra le aziende italiane e alcuni importanti accordi con realtà più grandi, che ne hanno fatto tecnicamente una scaleup. Pur navigando in un ecosistema povero di finanziamenti, 4wMarketPlace ha ottenuto nel 2015 dal gruppo italiano Dada un investimento di due milioni di euro attraverso il conferimento del ramo d’azienda Simply, società di adsense che ha ampliato in maniera esponenziale il business della startup lanciata da Digital Magics, che tramite un intenso lavoro di ricerca e innovazione, svolto principalmente in collaborazione con l’Università di Fisciano (Salerno), è stata in grado di formulare gli algoritmi che su 12.000 piattaforme disegnano ogni giorno la pubblicità su misura degli utenti.
Un caso, quello della scalata tramite un finanziamento tutto italiano, abbastanza raro, visto che la stessa Moneyfarm, startup della consulenza finanziaria, ha chiuso un round da 16 milioni, il più alto in Italia nel 2015, ottenendo il denaro in parte da un attore italiano (United Ventures) e in parte da uno inglese (Cabot). O visto che Restopolis e MyTable, confluite in The Fork, sono state rilevate un anno fa da Tripadvisor, colosso statunitense delle recensioni online, quotato al Nasdaq. O ancora che la startup bolognese Pizzabo ha realizzato una exit da 55 milioni di euro, investiti dal gruppo tedesco Rocket Internet. «Su di noi nel 2012 puntò Principia – racconta Ronchini –, ma il problema è che i fondi italiani sono sempre quelli, non ne vengono fuori altri». Di qui la difficoltà non solo a finanziare startup, ma soprattutto a creare quell’ecosistema che porti le migliori a dare un contributo rilevante alla crescita economica. A diventare appunto scaleup, che secondo il venture capitalist Brad Feld «hanno bisogno di grandi aziende a loro fianco che possano fornire loro occasioni di crescita e di exit».
L’esempio tipico è quello della Silicon Valley e ne sa qualcosa Cocontest, la più grande community internazionale di architetti e designer, che per fare il salto di qualità ha dovuto trasferirsi a San Francisco. «Lì – racconta Alessandro Rossi, CFO di quella che, numeri alla mano, è la prima e più grande piattaforma di crowdsourcing creativo del mondo – l’innovatività del nostro prodotto è stata subito riconosciuta: abbiamo raccolto 700.000 dollari dal fondo 500startups, che per la prima volta ha selezionato una srl italiana, da un altro fondo arabo e da business angels cinesi. In Italia nei primi due anni dalla fondazione, avvenuta nel 2013, abbiamo raccolto solo 170.000 euro in tutto da LVenture. Con quelle cifre non puoi scalare». Cocontest ha invece scalato eccome: l’idea di un grande concorso di architettura online tra privati, libero dalla nota burocratizzazione che rende tuttora impossibile l’estensione del progetto a livello pubblico («Non chiediamo neanche l’iscrizione all’Albo, i progetti vincono esclusivamente in base alla qualità e al merito»), ha raccolto l’adesione di oltre 36.000 progettisti provenienti da 90 Paesi del mondo (solo il 30% è italiano), con clienti da 33 Paesi, di cui l’85% da Italia e Usa, primo mercato di riferimento. La Uber degli architetti, come la definiscono alcuni. E che infatti come Uber ha spaccato il mercato, attirandosi più di un’azione legale contro.
«In Italia – denuncia Rossi – con i finanziamenti ci fermiamo alle fasi microseed e seed (quelle da migliaia o decine di migliaia di euro, ndr), perché i fondi sono sempre gli stessi e hanno una mentalità bancaria, da investimenti oculati e sicuri. Non c’è la cultura del capitale di rischio che è invece alla base del venture capitalism: si prediligono realtà italiane che di fatto praticano e-commerce, cioè che vendono qualcosa online, ma non presentano alcuna innovazione». Queste imprese possono garantire fatturati migliori a breve periodo rispetto a una scommessa – vinta – come quella di Cocontest, che dopo tre anni vale 7 milioni e vede il fatturato crescere del 150% ogni anno. «Ma queste startup non scaleranno, non faranno exit, non diventeranno billion, non creeranno ecosistema. Si crea ecosistema quando una startup diventa leader del proprio mercato, come siamo noi attualmente, ma per farlo abbiamo dovuto emigrare». E’ infatti la società controllante è, da qualche mese, la Cocontest Inc., con sede legale in California.
Ma non serve neanche arrivare alla Silicon Valley. «Basta guardare la Francia – spiega ancora Ronchini di 4wMarketPlace -, che non è poi un Paese così più forte di noi economicamente: lì un sistema di agevolazioni fiscali porta le grandi aziende a trovare convenienza nell’investire in capitale di rischio. In Italia viviamo la grande anomalia di avere più fondi pubblici che privati». Che oltretutto agiscono con la modalità – spesso ambigua e infruttuosa – dei finanziamenti a pioggia: «Il modello dovrebbe essere quello del matching, come fa Israele: pubblico e privato che collaborano negli investimenti, con il pubblico che co-investe la stessa cifra dopo che il privato ha fatto una valutazione di appropriatezza dell’investimento. Qualcosa del genere si inizia a vedere anche in Italia, con il Fondo della Regione Basilicata».
Avere grandi realtà a supporto è preferibile in realtà già nella fase iniziale, ne sa qualcosa sempre 4wMarketPlace: «L’endorsement di un grande gruppo come Digital Magics è stato decisivo sin dalla fase embrionale, non tanto per il capitale investito quanto per il rapporto con i grandi editori». Lo stesso incubatore ha da poco inviato una proposta in 8 punti al Governo per un salto di qualità dell’ecosistema startup: i principali sono proprio l’istituzione di un Fondo di matching per seed capital con Cassa Depositi e Prestiti, l’agevolazione fiscale che preveda un credito d’imposta che arrivi al 40% dall’attuale 19%, seguendo il modello anglosassone, e un potenziamento dell’equity crowdfunding, in particolare rimuovendo il vincolo di sottoscrizione da parte delle banche del 5%. Ossia il vincolo secondo il quale, da regolamento Consob, «ai fini del perfezionamento dell’offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di startup innovative».
La ratio di questa norma è quello di garantire all’investitore retail una valutazione positiva anche da parte di un investitore professionale, più qualificato per l’analisi di rischi e opportunità. Eppure, questa previsione si è dimostrata più un limite che un incentivo all’investimento, tanto da portare la Consob a rivedere il proprio regolamento (che non può del tutto modificare in quanto soggetto a legge primaria) aprendo la possibilità di far parte di questo “5%” non solo agli investitori professionali “di diritto” (banche, fondi, società che fatturano oltre 200 milioni) ma anche a quelli “su richiesta”, ossia a quei soggetti che rispondono a determinati requisiti di tipo patrimoniale e che si auto-dichiarano qualificati, in particolare i business angel.
Business angel che costituiscono parte del piano B proposto da Digital Magics: «Se gli industriali e le famiglie influenti italiane – ha detto Alberto Fioravanti, fondatore e presidente dell’incubatore quotato in Borsa – mettessero meno dell’uno per cento a testa dei loro investimenti su startup in fase iniziale ci avvicineremmo agli altri Paesi europei». In quanto a finanziamenti probabilmente, ma non necessariamente in quanto a innovazione. Non è infatti esclusivamente una questione di soldi, che comunque, secondo Ronchini di 4wMarketPlace, «girano molto di più di quanto risulti dalle statistiche ufficiali». «La realtà è che adesso in Italia c’è più disponibilità di denaro che di progetti da finanziare», rivela Alessandro Maria Lerro, avvocato e presidente dell’Associazione Italiana Equity Crowdfunding (Aiec). E gli fa eco Claudio Bedino, Ceo & Founder di Starteed, piattaforma specializzata proprio nella creazione di campagne di crowfunding personalizzate: «Gli imprenditori da noi non sanno progettare: non hanno capacità di marketing e storytelling come per esempio gli americani. Lo vediamo quotidianamente nelle attività quotidiane in Starteed, dove gestiamo le infrastrutture tecnologiche di alcune importanti piattaforme di crowdfunding italiane. Gli imprenditori italiani non sanno progettare “giocando” con le nuove regole di mercato e questo rende poco sexy anche i progetti imprenditoriali più interessanti. Ci vuole più qualità nei progetti».
Nessun commento
Devi fare per commentare, è semplice e veloce.