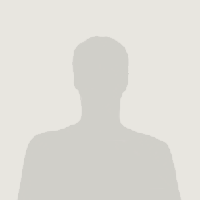Please scroll down for the English version.
Quando in molti sono andati alla stazione di Monaco di Baviera per ricevere i rifugiati, ci si è accorti che l´accoglienza non era solo una decisione di alcuni politici. E l´accoglienza è andata oltre gli applausi e le bottiglie d’acqua distribuite all’arrivo. Nel passare dei giorni mentre sempre più rifugiati arrivano in città come Monaco e Berlino, sempre più “normali” cittadini hanno offerto donazioni, soldi e tempo, per facilitare la vita di chi ha viaggiato da così lontano.
Adesso come adesso, la mia pagina di Facebook è piena di richieste di aiuto. I traduttori sono i più richiesti, per aiutare a compilare moduli, parlare con i funzionari pubblici e tradurre dall´arabo, dal farsi dall´hindi. Tra i molti gruppi, sono associata a quello che sta scrivendo un frasario per i rifugiati, traducendolo in più lingue possibili. C’è anche chi sta coordinando i pernottamenti di emergenza. C’è chi è volontario per la distribuzione di cibo e vestiti nei centri che stanno crescendo come funghi a Berlino, in vecchie scuole abbandonate o nelle tendopoli organizzate per l’occorrenza.
Tra questo diluvio di richieste di aiuto, mi sono sentita un po’ paralizzata. Essendo australiana, il mio tedesco non è un granché, a non parlo nessuna lingua tra quelle richieste. Dovrei andare alla stazione centrale a salutare chi scende dai treni, offrendo qualcosa come benvenuto? Posso ospitare qualcuno a casa nella stanza extra che abbiamo? Poi vedo un post da una traduttrice che sta accompagnando un bimbo arabo al primo giorno di scuola elementare, proprio vicino casa mia. È preoccupata che non riuscirà a preparare la schuletuete per il bimbo. La schuletuete è una sacra tradizione tedesca, un borsa a forma di cono ripiena di dolci, penne e matite. È la mia occasione, e mi do volontaria per prepararla. Ma un paio di minuti dopo qualcun altro risponde che l’ha già preparata, e i volontari si sono assicurati che tutti i bimbi di prima elementare abbiano la borsa, e che abbiano dolci halal.
Sabato, conto gli scatoloni rimasti in cantina e li offro al centro di accoglienza più vicino a casa. È solo a una fermata di metropolitana da casa, e mio figlio Julian, 7 anni, viene con me. Alla stazione, un ubriaco urla, insultando Angela Markel, ma si rivolge ad una famiglia tedesca che lo ignora bellamente. Julian mi chiede se ci saranno rifugiati dall’Africa al centro di accoglienza. Provo a spiegargli della guerra in Siria, e di chi scappa dall’Afghanistan, cercando di non dire nulla che lo possa preoccupare. Ma non so se ho risposto alla sua domanda.
Il centro dove stiamo andando è una vecchia scuola, tra le stazioni di Schoeneberg e Suedkreuz. È un anonimo edificio di mattoni rossi, sconsolatamente piazzato tra mega negozio di divani e un centro di riciclo dei rifiuti. Un uomo medio-orientale ci passa vicino e sorride vedendomi con i miei scatoli piegati, che il vento prova a farmi volare via. Dico buongiorno in tedesco, ma lui sorride senza dire parola.
Alla vecchia scuola, giriamo senza problemi trovando infine, in un corridoio, il tavolino della “reception”. Mi è stato detto che l’uomo dietro il tavolo è l’addetto alla sicurezza, anche se lui è vestito casual. Con calma ci aiuta, ci dice dove depositare le scatole e quando gli dico che mi fermerei per aiutare, mi indica le scale dirette alle cantine.
Lì troviamo qualcosa da fare. Siamo presentati a Alex, una volontaria che dirigere il lavoro di selezione. Ci fa vedere una stanza piena di borse di plastica e scatoloni, tutti strapieni di donazioni. Il centro ora rifiuta ulteriori offerte; in effetti i berlinesi sono stati così generosi che ora il problema e cosa farne di tutte queste scatole. Prima di accettare ogni altro oggetto, bisogna aprire le borse e selezionare cosa c’è dentro, così da usare ciò che è utile.
Alex ci dà un tesserino e, in inglese, ci spiega un paio di cose. Lenzuola e asciugamani nell’angolo dietro, oggetti per l’igiene personale sui ripiani, e poi scatole e scatole, tutte con indicazioni scarabocchiate in tedesco: vestiti per donna, per uomo, vestiti autunnali per ragazze. I vestiti estivi vanno nella stanza a fianco, l’estate qui è già finita.
Lavoriamo con altre sei-otto persone, il numero cambia perché la gente va e viene. Julian decide di selezionare le scarpe, e lo ritrovo contento a maneggiare stivali con il tacco e scarpe da ginnastica, legando le scarpe due a due con un cordino. Di tanto in tanto chiede istruzioni quando non riesce a riconoscere il numero. Ci parlano tutti in inglese.
Ci sono momenti divertenti. Siamo tutti d’accordo che chi ha donato un vestito da donna scollato, color grigio con brillantini, forse non ha immaginato che i rifugiati non andranno necessariamente subito a fare clubbing. Lo mettiamo in un contenitore per donazioni “non necessarie”. Ci chiediamo anche chi, segretamente felice di togliersele di casa, ha donato delle lenzuola rosse di raso, che brillano quando aperte. “A qualcuno piaceranno”, suggerisco con qualche dubbio. Ma per lo più lavoriamo a selezionare vestiti per stagione, taglia e genere.
Dopo un paio di ore, le scarpe sono state tutte divise, e vedo che Julian è davvero stanco. Ma mi supplica di fare ancora un borsone, infervorato dall’idea di chissà quali tesori si nascondono nella scatola successiva. Ma lo convinco ad andare. Salutiamo Alex e gli altri volontari, e chiedo come possiamo aiutare in futuro.
“Dai la tua disponibilità per selezionare i vestiti e per servire i pasti”, mi dicono. La selezione finirà presto, ma la necessità di volontari ci sarà comunque. “Lunedì offriremo caffè e torta” qualcun altro mi dice, “vieni a servire il caffè. Incontra i rifugiati.” Poi mi dice che più ogni altra cosa, c’è bisogno di esserci per parlare con loro. La lingua non è il problema, la questione è che i rifugiati devono sentirsi rilassati e benvenuti. Chiedo se si può fare qualcosa con i bambini, ma scuote la testa. “I bambini non possono fare nulla senza i genitori”, mi spiega. “Non hanno documenti o passaporto, e non possiamo portarli da soli in giro per la città.”
Come vado fuori, vediamo con discrezione i bambini giocare nel cortile, mentre uomini e donne sono seduti, gustandosi un ultimo raggio di sole. Vorrei salutare, ma per oggi la timidezza ha il sopravvento. Andiamo via, e porto Julian a mangiare un gelato in stazione, come premio per il suo gran lavoro. Poi, inizia improvvisamente a piovere, e i bimbi si riparano nella scuola, osservando il freddo clima del nord.
Tornati a casa, sento l’ansia di connettermi a facebook. Ci sono così tanti post in arrivo e non voglio perdermene nessuno, come se ce ne fosse uno in cui potessi aiutare. So che stasera ci saranno volontari al lavoro, anche perché altri rifugiati sono in arrivo e una nuova tendopoli è in allestimento a Spandau. Le notti stanno diventano fredde, e hanno bisogno di coperte e vestiti invernali.
So che se continuo a leggere i post, sarò sommersa dai messaggi, inondata da novità senza poter aiutare. Il modo migliore per gestire e scegliere una cosa da fare, a farla. Non so bene cosa sarà, se selezionare vestiti, servire i pasti o portare un pallone per far giocare i bambini, ma so che sarò una dei tanti che provano a essere di aiuto.
Sarò con quei berlinesi che hanno deciso che accogliere i rifugiati non è solo un compito del governo. Ho letto sulla stampa che c’è chi descrive il lavoro dei volontari non solo come compassione, ma come pragmatismo: fare il lavoro che va fatto. Per me è un atto di generosità, non solo perché qualcosa va fatto: va oltre quello, è un senso di responsabilità personale e impegno che non può essere represso.
Sono piena di ammirazione per quei berlinesi, che vivono in una città così affollata di ricordi di quando la gente non fece nulla, e di chi invece fa la sua parte, per fare della Germania un luogo di accoglienza.
English
When people turned out to cheer for the trains of refugees arriving in Munich, they revealed that it’s not just Germany’s politicians who are ready to welcome those who need help. And the gesture goes well beyond applause and bottles of water on arrival – as the days go by and more people arrive in cities like Berlin and Munich, ordinary people are giving belongings, money and time to try and ease the hearts and minds of those who have travelled so far to get here.
Right now, my Facebook feed is full of calls for help. Translators are the most in demand – people who can help do paperwork, talk with officials, and translate from Arabic, Farsi, Hindi, and more into German. Among the groups I have joined are the people who are writing a refugee phrasebook and translating it into as many languages as they can, to print out and hand out to new arrivals. There are the people coordinating emergency accommodation in the city for refugees. There are the volunteers who need help distributing food and clothing at the centres that are springing up around Berlin, in empty school buildings and ad hoc tent cities.
Among this deluge of calls for help, I start to feel a bit paralysed. An Australian myself, my German is poor, and I don’t speak any useful language pairs. Should I go down to Hauptbahnhof, Berlin’s main station, to greet people off the train with welcome packages? Should I volunteer to host someone in our back room over the weekend? Suddenly I see a post from a translator who is taking a young Arabic-speaking boy to the first day ceremony at the primary school right near me. She is worried that no one has organised a schuletuete him, the large cone of sweets and school supplies that all German children receive on their first day of school. This is my chance to be helpful, so I post a message offering to make one before the ceremony. But minutes later, someone else replies that it’s already done – volunteers have made sure that any children starting school will get a schuletuete full of halal sweets.
On Saturday, I count the moving boxes left in our cellar and offer to take them to the nearest centre. It’s one train station from my house, so my son Julian comes along. He is full of 7-year-old questions about refugees. At the station, a drunk man is yelling insults about Angela Merkel, but he is yelling them at a German family, who graciously ignore him. Julian wants to know if we will meet people from Africa at the refugee centre. I try to tell him about the war in Syria and the people fleeing Afghanistan, trying at the same time to tell him nothing upsetting. I’m not sure I really answer his questions.
The centre we are heading to is housed in an old school, between Schoeneberg station and Suedkreuz. It’s a nondescript red-brick building, standing forlornly behind discount sofa stores and a large recycling centre. A middle-eastern man walks past us and smiles at me and my boxes, which the wind is trying to tear away. I say good morning in German, but he just smiles wordlessly back.
At the school, we wander inside with no difficulties, and find a reception desk set up in a hallway. I know the man behind the desk is the security guard, because I was told so, but he’s casually dressed and quietly helpful. He tells me where I can leave the boxes, and when I say that we want to stay and help, he directs me downstairs to the cellar.
This is where we find something we can do. We are introduced to Alex, a volunteer who seems to be in charge of a large sorting process. She shows us a room full of bulging plastic bags and boxes, each overflowing with donations. The centre has put a stop on donations for now – people have been so generous that they cannot deal with everything they’ve received. Before they can take more, each bag must be opened and sorted into ever growing piles, so that the goods can be handed out and used.
Alex gives us name tags and a quick orientation in English. Bedsheets and towels in the back corner, toiletries and hygiene articles on shelving, and box after box of clothes, labelled in scrawled German: Women’s shorts, Men’s shirts, Girl’s autumn dresses. Summer clothes are in the next room, since the warm days are already coming to an end in Berlin.
We work alongside six or eight other people, the number fluctuating as volunteers come and go. Julian decides he wants to sort shoes, and I find him happily bundling pairs of high heels and runners and tying them with pipe-cleaners, stopping to consult with a couple of young men whenever he can’t identify the size. Everyone speaks English with us.
There are lighter moments. We agree that whoever donated the sparkly silver halterneck probably didn’t realise that the refugees won’t be out on the Berlin club scene right away. It goes into a “re-donate” bag of clothes, for inappropriate donations. We wonder if someone’s girlfriend was secretly pleased to get rid of a shiny red-and-black satin bedcover that sends off sparks as it’s unfolded. “Someone might like it,” I suggest to dubious laughter. But mostly we just work, dividing clothes into gender, season, size.
After a couple of hours, the shoes have been sorted and I can see Julian is tiring. He begs to be allowed to do one more bag, excited by the lucky-dip possibilities of what we might find, but I tell him we’ll come back another day. We say goodbye to Alex and the other volunteers and ask how else we can help.
“Put your name down to hand out clothes and serve food,” I’m told. The sorting will be finished soon, but the need for volunteers will continue. “We’re having a coffee and cake meeting on Monday,” someone else tells me. “Come and hand out coffee. Meet the refugees.” She tells me that more than anything else, they need volunteers to just come and talk to people. The language doesn’t matter, what the refugees need is to feel normal, to feel welcomed. I ask if anyone is doing anything with the children, but she shakes her head. “The children can’t do anything without their parents,” she explains to me. “They don’t have passports, so we can’t take them out to do anything around the city.”
As we walk outside, we glance shyly at the children playing in the yard, the men and women sitting and soaking up a spot of late season sun. I’d like to say hello, but for today at least, my shyness wins out. We leave, and I take Julian for an ice-cream at the train station as a reward for his hard work. The unfairness of it hits me. It begins to rain, and back at the school, the children will be sheltering inside the building, looking out at this chilly northern climate.
When we get back home, I feel a strange urge to connect to my Facebook feed. There are so many posts coming through, and I don’t want to miss one, as if there might somehow be one that I alone could help with. I know that tonight the volunteer work will go on, as more people arrive by train and the work to set up a tent city in Spandau begins. The nights are getting colder, and they will need blankets and warm clothes.
But I also know that if I keep looking at it, I will be drowned in the messages, flooded by all the ways I can’t help. The best way to handle it is to choose one thing I can do, and turn up and do it. I’m not sure what it will be yet, but whether it’s handing out clothes, serving food, or taking a football down to the yard for a kick-around with the kids, I know I’ll be just one of many people all trying to find a way to be helpful.
I’ll be alongside all the Berliners who’ve decided that welcoming refugees isn’t just a job for governments. I have read the news stories in the last few days that suggest that the response on the ground here is an example not just of compassion, but also of German pragmatism, getting on with a job that needs to be done. For me, this is true generosity – not that people see a job that needs to be done, but that they step forward to do it, with a sense of personal responsibility and duty that cannot be stifled. I am full of admiration for these people, who live in cities crowded with reminders of what happens when people stand by and do nothing, and who instead are doing their part to make sure that Germany is a place of refuge.
Nessun commento
Devi fare per commentare, è semplice e veloce.