Geopolitica
“Camminare rasente al muro”: Sani racconta la “libertà” nell’Iraq di oggi
Su gentile concessione dell’editore pubblichiamo alcuni estratti di Camminare rasente al muro, La libertà d’espressione in Iraq a vent’anni dall’invasione, di Fabrizio Sani, edizioni Malamente
DA 1.3 p. 44-46
Alle soglie del nuovo millennio, dopo essere stato uno dei paesi più ricchi tra quelli in via di sviluppo, in capo a un decennio l’Iraq si ritrova nel novero dei più poveri: la mortalità infantile, la malnutrizione e gli indici economici avevano raggiunto livelli simili a quelli dell’Africa sub-sahariana, il tasso di criminalità era raddoppiato e le divisioni settarie interne si erano acuite, spinte dalla radicalizzazione religiosa. Il Rais fa inserire nella bandiera nazionale le parole هللا ربكأ (Allah è grande); sia il regime che i suoi oppositori fanno ormai leva principalmente sul sentimento religioso. Il principale movimento nato da questo slancio è quello sadrista, dal nome del leader sciita Muhammad Sadiq Al-Sadr. Questi, paladino della norma islamica conservatrice, condannava la cultura occidentale definendo le sanzioni una sorta di attacco imperialistico all’Islam. Nel 1999 è stato assassinato assieme a due dei suoi tre figli; il terzo, Moqtada, guida oggi la formazione politica più votata alle ultime elezioni. Sebbene l’elenco dei crimini di Saddam vada oltre quelli che abbiamo citato in queste pagine, la causa determinante il suo definitivo crollo non è lì che va ricercata, ma in un evento esterno a lui e al suo paese: gli attentati dell’11 settembre 2001, casus belli sfruttato dall’amministrazione americana. Difatti, nonostante quindici dei diciannove dirottatori fossero sauditi (oltre a due dagli Emirati Arabi Uniti, uno dall’Egitto e uno dal Libano); nonostante Al-Qaeda – la cellula terroristica responsabile dell’attacco – fosse finanziata in larga parte da denaro proveniente dal Golfo Persico (in particolare saudita) e avesse la propria base in Afghanistan; e nonostante Osama Bin Laden fosse saudita e Khalid Shaikh Mohammed (identificato come stratega dell’attentato dalla Commissione ufficiale sull’11 settembre) pakistano; il giorno dopo già veniva pianificata l’invasione dell’Iraq. Lo dichiara Richard Clarke, all’epoca coordinatore nazionale per la sicurezza e l’antiterrorismo:
Il presidente, in modo molto intimidatorio, congedò me e il mio staff con la chiara indicazione che tornassimo da lui con qualcosa che dimostrasse che c’era la mano irachena dietro al 9/11, perché avevano pianificato di fare qualcosa in Iraq prima ancora di essere eletti […] Penso che avessero un’idea fissa, fin dal primo giorno d’insediamento volevano intervenire in Iraq. E mentre il World trade center era ancora fumante, mentre stavano ancora scavando corpi, questa gente alla Casa Bianca pensava: «Ah, questo ci dà l’opportunità che stavamo cercando per andare in Iraq».
Condoleezza Rice replicherà affermando che «l’Iraq, data la nostra storia, dato il fatto che ha cercato di uccidere un ex presidente, era un probabile sospettato» e Donald Rumsfeld, sulla stessa lunghezza d’onda, dirà che l’amministrazione Bush aveva una visione più ampia e stava guardando a una «guerra globale al terrore, non solo una guerra contro Al-Qaeda». Ma per tentare di convincere l’opinione pubblica della legittimità di un intervento in Iraq c’era bisogno di qualcosa di più tangibile. L’amministrazione americana imposta quindi la sua comunicazione su tre punti principali: la destituzione di Saddam Hussein avrebbe portato pace, democrazia e libertà nel paese e nell’intera regione; malgrado gli sforzi delle Nazioni Unite, l’Iraq era ancora in possesso di armi di distruzione di massa; l’Iraq aveva stretti rapporti con Al-Qaeda. Oggi sappiamo bene che tutte e tre queste asserzioni erano infondate ed è lecito pensare che siano state architettate deliberatamente. Non sono pochi gli indizi che vanno in questa direzione, a partire dalle affermazioni di Lawrence Wilkerson, ex capo di gabinetto del segretario di Stato Colin Powell, secondo il quale, in quel periodo:
Paul Wolfowitz [allora vicesegretario alla difesa] e Dick Cheney si premuravano di rendere pubblici tutti quei documenti che attestassero che l’Iraq era in possesso di armi chimiche, nonostante fossero una minima parte, molto inferiore a quelli che lo escludevano. Inoltre, li pubblicavano senza neppure verificare le fonti.
——-
[…] CAMMINARE RASENTE AL MURO – La libertà d’espressione in Iraq a vent’anni dall’invasione americana. DA 2.0 p. 83-85
C’è questo modo di dire molto comune in Iraq, che nella nostra lingua può essere tradotto in «camminare rasente al muro». Ho parlato con molti scrittori e scrittrici, intellettuali, giornalisti e giornaliste iracheni e irachene per scrivere queste pagine e, più di una volta, mi è stata ripetuta questa espressione per raccontare la vita sotto il regime ba’thista. È facile intuirne il significato: non farsi vedere, non farsi notare, non farsi sentire; il solo modo per stare lontani dai guai era essere invisibili. Nemmeno dentro casa ci si poteva sentire al sicuro: «avevamo paura di parlare davanti ai figli, nel caso poi a loro sfuggisse qualcosa a scuola», racconta l’irachena Samira Jamal Aldin. Ogni mezzo d’informazione era controllato dal regime, così come ogni produttore di cultura che volesse operare all’interno del paese. Questa la descrizione che mi ha fatto Hawra Al-Nadawi, scrittrice irachena che ha trascorso i suoi primi due anni di vita nelle carceri di Saddam, per poi fuggire dall’Iraq nel 1991 assieme alla famiglia:
Non esisteva libertà di parola o di espressione. Era uno Stato di polizia nel vero e proprio senso del termine. Gli iracheni mandavano rapporti contro i loro amici e vicini. Non avresti osato mostrare il tuo disprezzo per il regime nemmeno ai tuoi stessi fratelli. È stato bruttissimo. Criticando il regime o il capo di Stato [Saddam], avresti rischiato la vita. La mia famiglia, ad esempio, non era politicamente attiva, solo mio padre lo era e neppure molto, direi. Eppure, siamo stati tutti, come famiglia, sbattuti in prigione.
Come la famiglia di Hawra, la maggior parte degli scrittori e artisti iracheni che oggi conosciamo sono scappati dal paese durante il regime ba’thista. In un reportage per New lines magazine, Ali Al-Baroodi esprime le domande che molti iracheni si fecero all’epoca e continuano a farsi ancora oggi:
Volevamo l’invasione americana? Siamo loro grati per averci liberato da Saddam?». Mio padre ha ascoltato le notizie, sperando in silenzio che i trentacinque anni di oppressione di Saddam sarebbero presto finiti. Questa è davvero una domanda pesante per molti iracheni: volevamo l’invasione degli Stati Uniti? Non siamo loro grati per esserci sbarazzati di Saddam? Direi che quello che il popolo iracheno ha sempre voluto è questo: avere una vita dignitosa, l’opportunità di mettere il cibo in tavola e vivere dignitosamente, con o senza Saddam.
Alla vista delle truppe americane a Baghdad e della statua del Rais abbattuta a piazza Firdos non si respirava aria di giubilo ma, come per il padre di Ali Al-Barrodi, una silenziosa speranza, perché il silenzio era la lingua che avevano imparato a parlare gli iracheni. «La mancanza di libertà di parola è scolpita nelle menti del popolo iracheno», mi dice Hawra.
Ci siamo svegliati alla vista delle truppe statunitensi e degli Humvee [veicoli militari] nelle nostre strade a Mosul. Ma se qualcuno pensava che questo avrebbe inaugurato una nuova era, si sbagliava in parte […] Mentre le truppe americane hanno preso il controllo della nostra città, i saccheggiatori hanno preso il controllo di ogni struttura del governo, senza lasciare nulla, rubarono tutto. A poche ore dall’arrivo degli statunitensi, ho visto persone portare via sedie e scrivanie, caricare piccole auto con frigoriferi e condizionatori d’aria. All’università, la mia classe è stata vandalizzata. Gli uffici furono bruciati; le porte sono state tolte dai cardini e rubate. Tali battute d’arresto sembravano non essere pubblicizzate mentre le società americane affermavano con convinzione la loro pretesa sulla nostra economia.
Se dopo vent’anni dalla cacciata di un feroce dittatore quale è stato Saddam Hussein, ancora gli iracheni sono dubbiosi, non così certi di averci guadagnato, è inevitabile porsi delle domande su ciò che è stato fatto e sulle modalità con cui è stato attuato. La mia analisi si concentri sulla libertà d’espressione – sebbene non sia l’unico grave problema che investe l’attuale Iraq – per indagare i meccanismi che la minano, senza dimenticare le restrizioni alle altre libertà dei cittadini, a cui il dibattito internazionale dovrebbe prestare maggiore attenzione.

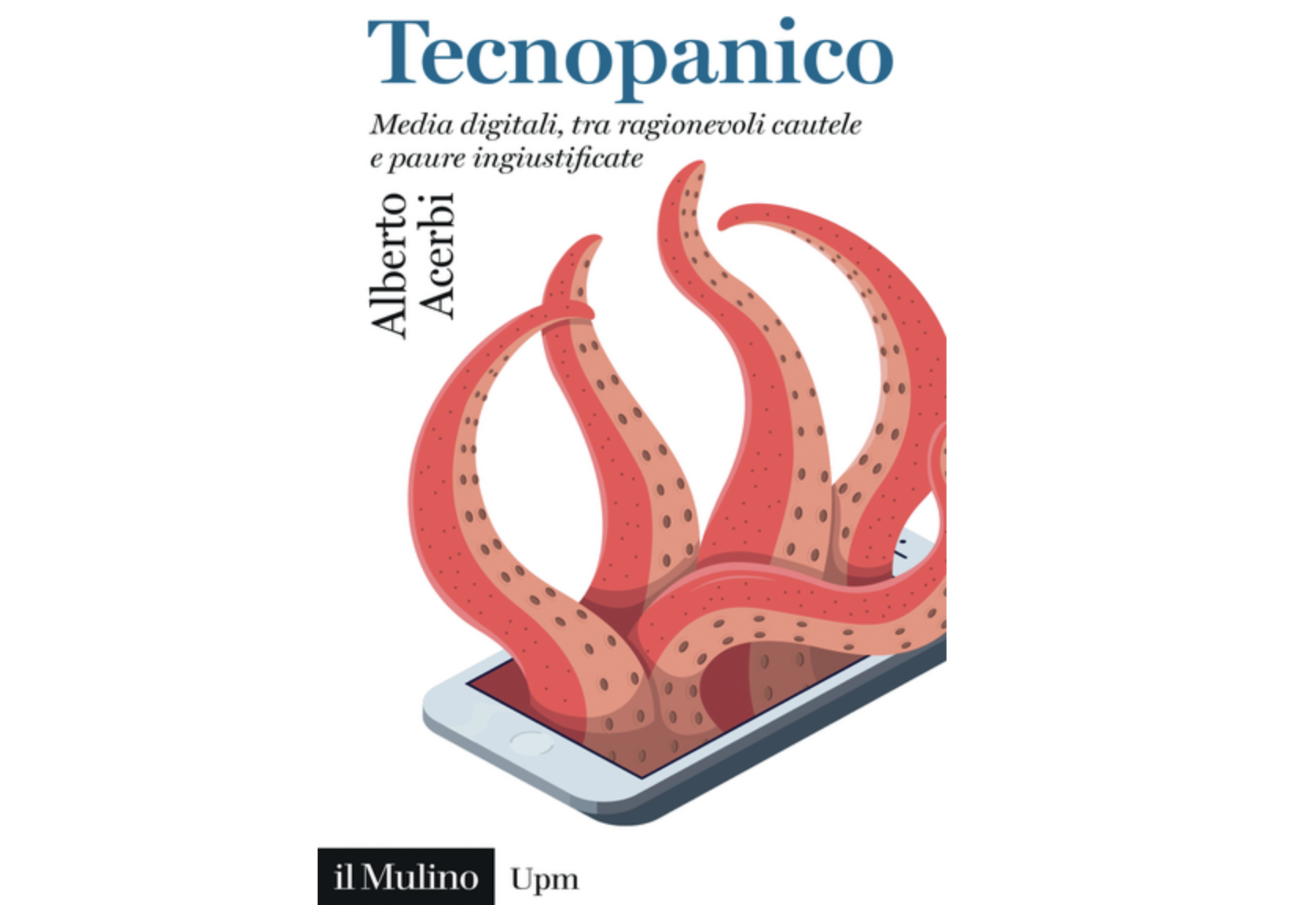
Devi fare login per commentare
Accedi