Sindacati
Deborah Lucchetti (Abiti Puliti):“In Bangladesh un modello economico predatorio”
Da alcune settimane i media italiani parlano, non molto per la verità, della rivolta dei lavoratori e delle lavoratrici del settore tessile nel Bangladesh, ma tacciono le responsabilità dei marchi europei e anche italiani rispetto a un modello economico, che Deborah Lucchetti, coordinatrice nazionale della campagna “Abiti Puliti”, definisce, nell’intervista che le abbiamo fatto, “predatorio”. Gli avvenimenti del Bangladesh, ci spiega, si inquadrano in un contesto più generale.
Visti i fatti del Bangladesh, puoi tracciare una panoramica complessiva della delocalizzazione del tessile e della moda nei paesi del sud del mondo ?
La moda è uno dei settori industriali che ha più risentito dei processi di delocalizzazione negli ultimi 40 anni. È stato relativamente semplice, a un certo punto, spostare le produzioni a più basso valore aggiunto in paesi a basso reddito, in costante competizione per inseguire un modello di sviluppo del tutto subalterno al commercio internazionale. Questo in pratica ha voluto dire orientare le proprie economie alle esportazioni e vincolare il successo delle industrie tessili nazionali, ove esistenti, alle c.d. catene di fornitura globali, dove i grandi brand internazionali dispongono prezzi di acquisto e di vendita delle merci a loro piacimento, costringendo migliaia e migliaia di fornitori ad accettare condizioni commerciali capestro, pur di entrare nei mercati internazionali. Intere macroregioni nel mondo sono diventate il milieu produttivo delle multinazionali della moda, che hanno avuto gioco facile in una situazione internazionale sempre più favorevole allo spostamento di merci e capitali, un ambiente “corporate friendly”, dove è stato possibile aprire fabbriche in paesi poverissimi, spesso ricevendo sussidi pubblici e agevolazioni di ogni tipo, da quelle infrastrutturali a quelle fiscali. Il costo del lavoro, definito per legge o dal mercato sempre molto al di sotto della soglia di povertà, è il fattore chiave che ha consentito alle imprese multinazionali di sfruttare sacche enormi di manodopera in condizione di particolare vulnerabilità, soprattutto donne di colore. Questo è accaduto non solo per l’assenza di una solida cultura dei diritti umani e del lavoro nei paesi di produzione, ma anche e principalmente a causa di un modello di produzione di tipo estrattivo, fondato sullo sfruttamento del lavoro e di materie prime vergini provenienti dal c.d. Sud Globale che restituisce alla collettività gas serra e rifiuti, da rispedire nei luoghi del saccheggio. Un sistema neo-coloniale globale, violento e asimmetrico, basato su occultamento di responsabilità delle multinazionali e massima competizione con l’unico obiettivo di garantire agli azionisti e ai manager profitti e stipendi d’oro, a totale detrimento dei lavoratori, delle comunità e dell’ambiente. La fast fashion è questo: produrre sempre più merci inutili e dannose (+100% negli ultimi 15 anni) solo apparentemente a basso costo, che generano decine di miliardi di tonnellate di rifiuti all’anno. Rifiuti che marciscono in immense discariche a cielo aperto o vengono inceneriti, anche se si tratta di capi quasi nuovi. Bisogna capire che danni ecologici e climatici, povertà e diseguaglianza hanno le stesse cause sistemiche, insite nel modello di produzione qui accennato. La crisi sociale e la crisi climatica sono fallimenti del mercato cui si intende rispondere con più mercato. Questo è un grave problema, perché chi ha prodotto la poli-crisi in cui siamo immersi fino al collo non può e non deve incaricarsi di individuare le soluzioni per uscirne.
In Bangladesh come si manifesta il fenomeno?
Il Bangladesh è un esempio fra i più significativi di come questo modello predatorio atterra su un paese che ha ancorato il suo sviluppo al mito della globalizzazione. Solo nel 2026 il Bangladesh acquisirà a tutti gli effetti lo status di Paese in via di sviluppo nell’ambito dei processi delle Nazioni Unite. Questo avrà delle implicazioni per quanto riguarda l’attuale accesso al mercato dell’UE. Le agevolazioni cesseranno e per usufruirne ancora il Bangladesh dovrà dimostrare di avere diversi requisiti, tra questi il rispetto degli standard internazionali sul lavoro. L’economia del Bangladesh oggi dipende per l’80% dalle esportazioni, trainate dal settore tessile, che rappresenta l’82% della totale. Una crescita robusta, che ha segnato un incremento del 35% dopo la pandemia, pari a un valore di circa 43 miliardi di dollari. Una recente ricerca, inoltre, ha messo in luce che il settore pronto moda del Bangladesh trae vantaggio dalle crisi in corso tra Russia e Ucraina e tra USA e Cina, perché sempre più marchi, che prima importavano capi di abbigliamento dalla Cina, ora si riforniscono in Bangladesh. Parliamo del secondo grande esportatore dopo la Cina, con 3.600 fabbriche tessili (erano appena 50 nel 1980) e più di 4 milioni di lavoratori poveri, sempre più indebitati. Con un tasso d’inflazione ufficiale che negli ultimi mesi ha toccato punte superiori al 9%, la situazione per i lavoratori si è ulteriormente inasprita. E secondo le previsioni non ufficiali i dati sono ancora più preoccupanti con il prezzo di alcuni dei principali beni alimentari quasi raddoppiati. Una situazione insostenibile, che continua a erodere il potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici, costretti a scelte sempre più drastiche: saltare i pasti, indebitarsi, lavorare senza sosta per portare a casa più denaro e mandare i figli a lavorare anziché a scuola.
Che ruolo giocano le aziende italiane e che tipo di imprese troviamo: grandi gruppi. piccola impresa familiare, terzisti ecc.?
Una delle nostre richieste più importanti riguarda la trasparenza delle catene di fornitura. Sono anni che chiediamo ai marchi di pubblicare la lista dei loro fornitori con nomi e indirizzi delle fabbriche. Grazie alla crescente pressione pubblica, numerosi marchi importanti lo hanno fatto, ma non la maggioranza. In attesa che una legge lo renda obbligatorio, per capire da dove vengono i vestiti che acquistiamo, al momento possiamo solo contare solo sulla scelta volontaria delle imprese, data l’inadeguatezza delle etichette che non contengono le informazioni chiave sulle fasi produttive e nemmeno quelle necessarie a misurare la qualità sociale di un prodotto. Dico questo per spiegare perché non è facile rispondere a questa domanda, visto che ciò che sappiamo sulla filiera o lo dicono le imprese o lo scopriamo tramite le ricerche e i casi di violazione di cui ci occupiamo. Le aziende italiane comunque, come tutti i marchi internazionali che hanno delocalizzato la produzione in paesi vulnerabili dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, hanno rapporti commerciali importanti con il Bangladesh, come abbiamo visto, principale fornitore mondiale di prontomoda dopo la Cina. I marchi, inclusi quelli italiani, possono avere rapporti diretti coi fornitori nei vari paesi di produzione oppure si rivolgono a intermediari che svolgono un lavoro di facilitazione e mediazione commerciale con le fabbriche. Non dimentichiamo però che l’Italia rappresenta un importante snodo della manifattura mondiale. Con oltre 55mila imprese e più di 470 mila addetti (dati Istat 2019), le piccole imprese e i terzisti italiani sono entrati a pieno titolo nella competizione globale, un gioco pericoloso che ha esacerbato la compressione del costo del lavoro e sta mettendo a rischio la tenuta dei diritti conquistati in decenni di lotte sindacali anche in Italia. Il modello Bangladesh, sia per le condotte di impresa sempre più irresponsabili, sia per i tanti migranti che alimentano le catene di fornitura del made in Italy, è molto più vicino di quello che immaginiamo.
Perché secondo te l’esplosione delle scorse settimane? È solo l’inflazione la goccia che ha fatto traboccare il vaso o ci sono aspetti più di fondo?
La revisione del salario minimo da parte della commissione formata dal governo è partita in un momento difficile per il movimento per i diritti dei lavoratori del Bangladesh. Il recente omicidio del sindacalista Shahidul Islam testimonia l’ambiente incredibilmente repressivo in cui sono partite le trattative e sintetizza l’alto livello di tensione sociale in cui versa il Paese. Anche in passato le revisioni del salario minimo hanno portato a un numero impressionante di disordini. In occasione dell’ultima, nel 2018, quando il salario minimo venne fissato ad appena 8000Tk (67 euro), un lavoratore fu ucciso mentre decine rimasero feriti e migliaia persero il lavoro. Quel salario era già insufficiente per condurre una vita dignitosa quando è entrato in vigore cinque anni fa, nel 2019. Da allora i lavoratori hanno dovuto sopportare l’ulteriore pressione generata dalla pandemia e poi dall’alta inflazione figlia della poli-crisi internazionale, senza nessuna rete di protezione sociale. Le proteste a Gazipur sono iniziate dopo che la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) ha presentato la sua proposta per la fissazione del nuovo salario minimo a 10.400Tk (87 euro), meno della metà della richiesta dei sindacati di 23.000Tk (193 euro).
Uno schiaffo in faccia ai lavoratori e alle richieste dei sindacati, nonostante queste fossero allineate coi criteri prescritti dalla legge sul lavoro del Bangladesh e dalla Convenzione 131 dell’OIL sulla fissazione dei salari minimi. Senza considerare che esistono diversi indicatori sul salario minimo dignitoso per il Bangladesh e che i 23000Tk richiesti dal sindacato sono il livello davvero minimo per sopravvivere.
Da Gazipur le proteste si sono diffuse in altre aree del Paese e sono una conseguenza dell’estremo impoverimento delle lavoratrici e della loro perdita di fiducia nel processo di revisione avviato dal governo. L’uccisione di Rasel Hawlader, operaio tessile colpito da un proiettile mentre manifestava pacificamente, è un esempio estremo dei tentativi di sedare con brutale violenza le proteste. A oggi sono già almeno tre i lavoratori uccisi, mentre molti altri sono rimasti feriti. La polizia inoltre ha arrestato più di 100 manifestanti, tra cui diversi leader sindacali, con l’accusa di violenza e vandalismo nelle fabbriche. Qualche giorno fa Sheikh Hasina, primo ministro del Bangladesh, ha dato il colpo di grazia ai lavoratori scesi in piazza per la loro sopravvivenza, esortandoli ad accettare la cifra indicata dal governo di 12.550 Tk (102 euro), oppure di “tornare al loro villaggio”.
Cosa propone Abiti Puliti e quali sono i vostri interlocutori? Avete rapporti con le organizzazioni sindacali dei paesi coinvolti? E il sindacato italiano cosa può fare?
Prima di tutto chiediamo al governo del Bangladesh di porre fine alla violenza usata contro i lavoratori, che hanno il diritto di manifestare, anche secondo la legge del loro Paese. Inoltre chiediamo al governo del Bangladesh di smettere di politicizzare le proteste salariali e di riconoscere invece le agitazioni come una reazione diretta all’oltraggiosa proposta dell’associazione industriali, di poco incrementata dalla successiva decisione del governo, che semplicemente intrappolerà i lavoratori nella povertà per altri cinque anni, a prescindere dal panorama politico nazionale.
Anche i marchi che si riforniscono dal Bangladesh hanno giocato un ruolo innegabile nei recenti sviluppi. La maggior parte si è rifiutata di rilasciare dichiarazioni pubbliche a sostegno della richiesta dei lavoratori, ignorando diverse richieste in tal senso da parte della Clean Clothes Campaign e dei sindacati con cui è in costante contatto. Nonostante codici di condotta e dichiarazioni a favore di meccanismi di determinazione dei salari trasparenti e inclusivi, la maggior parte dei marchi non ha preso una posizione chiara a favore delle richieste dei sindacati del Bangladesh. Mentre i lavoratori rischiano la vita per chiedere il minimo per uscire dall’incubo della povertà, i marchi che si riforniscono in Bangladesh si rifiutano di sostenere le loro richieste, legittimando così l’ambiente repressivo e antidemocratico che accompagna il processo di revisione sfavorevole ai lavoratori, sin dalle premesse. Infatti non dobbiamo dimenticare che buona parte del Parlamento locale è composto da imprenditori tessili e che nessuno dei sindacati più rappresentativi che guidano la protesta siede nel comitato di revisione salariale. I marchi internazionali tacciono perché sostenere le richieste dei sindacati implicherebbe adeguare le loro pratiche commerciali ad un costo del lavoro più alto. Cosa che evidentemente non vogliono fare, pur essendo necessario per consentire ai fornitori di alzare i salari ai 4 milioni di lavoratori che fabbricano buona parte dei nostri vestiti. Cosa che senza dubbio potrebbero fare, visto che il costo del lavoro in Bangladesh equivale in media al 3% del prezzo pagato al fornitore, vale a dire 4 centesimi per una T-Shirt venduta a 5 euro. Credo sia molto importante fare arrivare la nostra solidarietà e il nostro supporto concreto alle operaie tessili in lotta, come cittadini e come lavoratori organizzati. Il sindacato italiano, insieme a quello europeo, può fare molto in questo senso, perché la solidarietà internazionale tra lavoratori è un dispositivo potente, e perché se è vero che il pesce puzza dalla testa, sempre di più occorre organizzare lotte che travalichino i confini nazionali.
Intervista tratta dalla newsletter di PuntoCritico.info del 24 novembre.


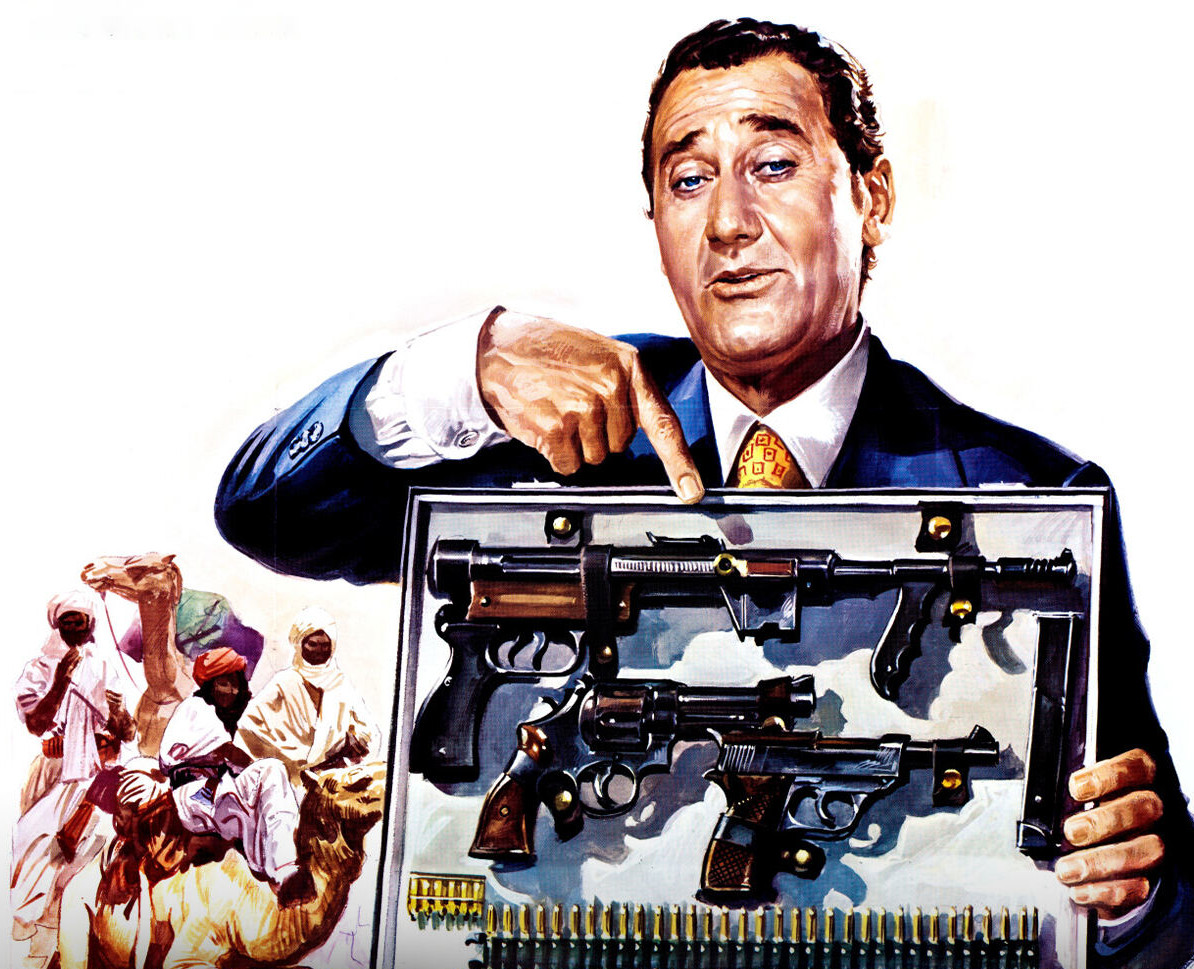
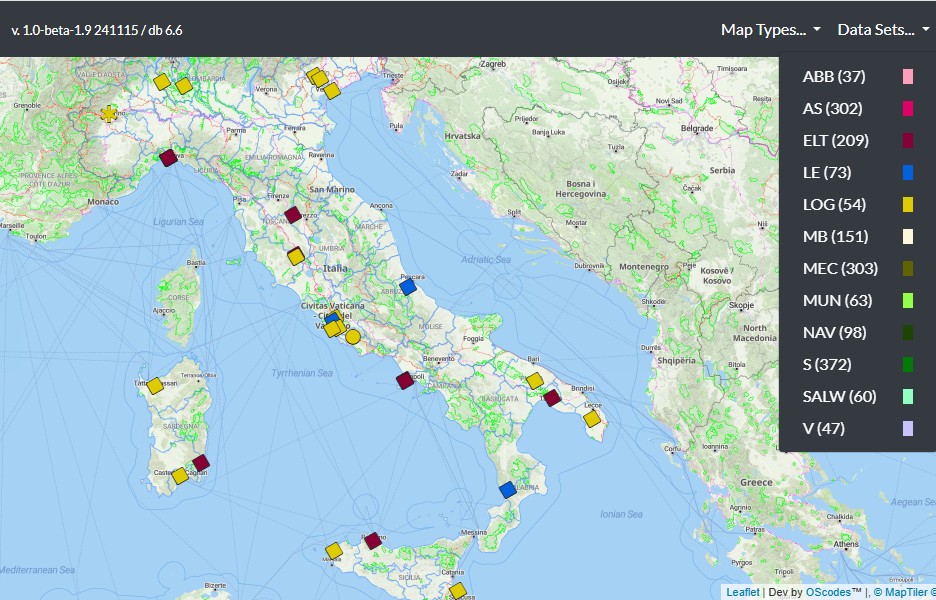

Devi fare login per commentare
Accedi