Lavoro
Lavorare stanca
Il volume pubblicato da Egea, Dialogo sul lavoro e la felicità, è la trascrizione fedele di una conversazione tenuta tra Paolo Iacci, docente di Gestione delle risorse umane alla Statale di Milano, e il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti. L’editore ha deciso di lasciare inalterata l’originale versione orale per non togliere immediatezza al testo, che risulta infatti vivace e di godibile lettura, nonostante l’argomento trattato non sia dei più accessibili.
Al giorno d’oggi il lavoro, fondamentale ancoraggio alla vita reale, è diventato una chimera per molti: giovani che non lo trovano, laureati costretti a emigrare, personale qualificato espulso dalla catena produttiva, donne che non riescono ad accedere a un impiego. E tra chi ha conquistato un suo ruolo nel sistema, quanti sono i privilegiati che possono dire di amare il proprio mestiere, e quanti invece lo reputano una condanna, conseguenza della maledizione divina lanciata contro Adamo nel giardino dell’Eden?
Galimberti, rifacendosi alla cultura classica, prende in esame i due termini di felicità e di ozio. Per i greci l’eudaimonia si basava sull’armonia, l’equilibrio e la misura, acquisibili solo attraverso una profonda conoscenza e padronanza di sé, in accordo con il daimon interiore che è presente in ogni persona e ne guida le azioni. Nella società contemporanea, regolata dal mercato e basata sulle logiche di prestazione ed efficienza volte solo al profitto, l’obiettivo della felicità individuale, ottenuta con l’espressione e la realizzazione di ciò che siamo, viene subordinato al raggiungimento di altri traguardi (denaro, successo professionale, competizione esasperata), asserviti a ideali esteriori e futili.
L’otium dei latini coincideva con l’agire proprio degli uomini liberi, in opposizione al negotium, inteso come incombenza faticosa e costrittiva, e indicava lo spazio che ciascuno dovrebbe dedicare a se stesso, coltivando lo studio, le relazioni arricchenti, il perfezionamento del proprio carattere. Oggi per ozio si intende solamente lo svago, il riposo dalle fatiche lavorative, la distrazione offerta da diversivi superficiali.
Paolo Iacci considera l’essere umano come biologicamente costruito per un’attività diretta a un fine, e ritiene che l’ozio, o l’attività priva di scopo, provochi sofferenza e atrofia: l’idea del “lavoro ben fatto” è invece talmente radicata da spingere a perfezionare anche quello imposto, schiavistico. Il motto Arbeit macht frei, diabolicamente esibito all’ingresso del lager di Auschwitz, in cui si mirava in realtà all’annullamento della dignità e della vita dei prigionieri, era tuttavia assolutamente veritiero. Il lavoro rende liberi, ma i nazisti miravano a svilirlo e disprezzarlo, proprio perché atto “sovversivo” di sopravvivenza e di riscatto.
Alla valutazione positiva di Iacci, Galimberti oppone la constatazione che nella nostra età della tecnica non si viene valutati per il risultato dell’opera fornita, ma per la modalità con cui la si esegue; non si richiede adesione emotiva ma unicamente prestazioni all’altezza delle aspettative del mercato. Il modello economico adesso imperante piega la volontà dei singoli alla dura logica del rendimento e del profitto. Il lavoratore è sempre più dissociato dalla propria azione, poiché “l’oggetto che il lavoro produce, il prodotto del lavoro, gli si contrappone come qualcosa di estraneo, come una potenza indi pendente da colui che lo produce”, secondo quanto scriveva Marx più di un secolo fa. Sarebbe pertanto necessario e doveroso sottrarsi all’alienazione del produrre fine a sé stesso, favorendo in primo luogo nei salariati “lo sviluppo dei propri talenti, la realizzazione della propria identità”, più che la sudditanza a un mezzo di mantenimento. In un’epoca come quella in cui viviamo, oppressa da paralizzanti paure (i terrorismi, le pandemie, i tracolli finanziari) è tanto più necessario un profondo ripensamento del nostro modo di vivere e di progettare il futuro, traendo dal sentimento di angoscia che ci pervade nuove occasioni di riflessione e interiorità, consapevoli però di quanto il mondo sia cambiato, con il prevalere dominante della tecnica, convertita da mezzo a fine, non più strumento ma soggetto stesso della storia umana. Dobbiamo revisionare tutte le nostre categorie concettuali, nella vita economica, sociale e relazionale. I modelli economici tradizionali si dimostrano oggi carenti perché tentano di rintracciare una razionalità sequenziale che è ormai tramontata. Le antiche variabili chiave del mercato (domanda, offerta e concorrenza) non sono più utilizzabili per interpretare un sistema produttivo complesso, specializzato, parcellizzato, iperconnesso, computerizzato, e pertanto soggetto a imprevedibili e paradossali rivolgimenti, non inquadrabili in schemi mentali obsoleti.
Dal punto di vista etico, poi, sembra che le indicazioni morali delle religioni e delle filosofie tradizionali abbiano ben poco da dire a individui sempre più egocentrici, isolati, disillusi e scettici, incapaci di slanci altruistici e solidarietà, indifferenti al mistero e alle questioni metafisiche. Il nichilismo a cui è approdato l’occidente, negando ogni speranza di futuro, riduce all’insignificanza l’agire umano, e quindi la stessa attività lavorativa, che attualmente è caratterizzata in primo luogo da cieca competitività, invidia sociale, conformismo diffuso e paralizzante senso di inadeguatezza. Nella vita produttiva, l’identità non è più determinata da fattori religiosi, culturali, familiari, di razza o di genere, ma è decisa dal ruolo occupato in azienda, dalla carriera fatta, dal riconoscimento degli altri affidato alla parola pubblica, secondo il primato dell’oggettività e l’appiattimento della soggettività.
Risulta pertanto difficile trovare una sintonia tra lavoro e felicità. La felicità sembra possa essere possibile dopo il lavoro, malgrado il lavoro e non anche grazie al lavoro. Dovremmo invece tentare di renderlo desiderabile e non solo causa di fatica e luogo di tensioni. In che modo? Paolo Iacci suggerisce di sperimentare nuove forme di organizzazione dell’attività lavorativa, non più basate sul paradigma del comando/controllo, ma contraddistinte da maggior delega, più ampia autonomia delle persone e una superiore attenzione alla loro motivazione e individualità. La tecnica continuerà a proseguire nel suo planetario sviluppo auto-referenziale, ma i luoghi di lavoro, per poter funzionare, dovranno concedere spazio anche alla dimensione emotiva e non unicamente a quella professionale e razionale, nell’ambito di un’educazione alla cultura e ai sentimenti intesi in senso lato.
La proposta di Umberto Galimberti appare addirittura più estrema: indica la necessità di passare gradatamente dal “lavoro come produzione” (che ha in vista solo la sua crescita esponenziale, senza ragione e senza perché) al “lavoro come servizio”, in grado di offrire non soltanto merci e beni spesso inessenziali, imposti da un consumismo esasperato, ma anche di erogare tempo, cura, relazione. Senza trascurare la parte irrazionale, istintiva, ludica, affettiva ed emozionale dell’essere umano, attraverso cui ci si possa avvicinare individualmente e collettivamente alla felicità.
PAOLO IACCI, UMBERTO GALIMBERTI, DIALOGO SUL LAVORO E LA FELICITÀ
EGEA, MILANO 2021





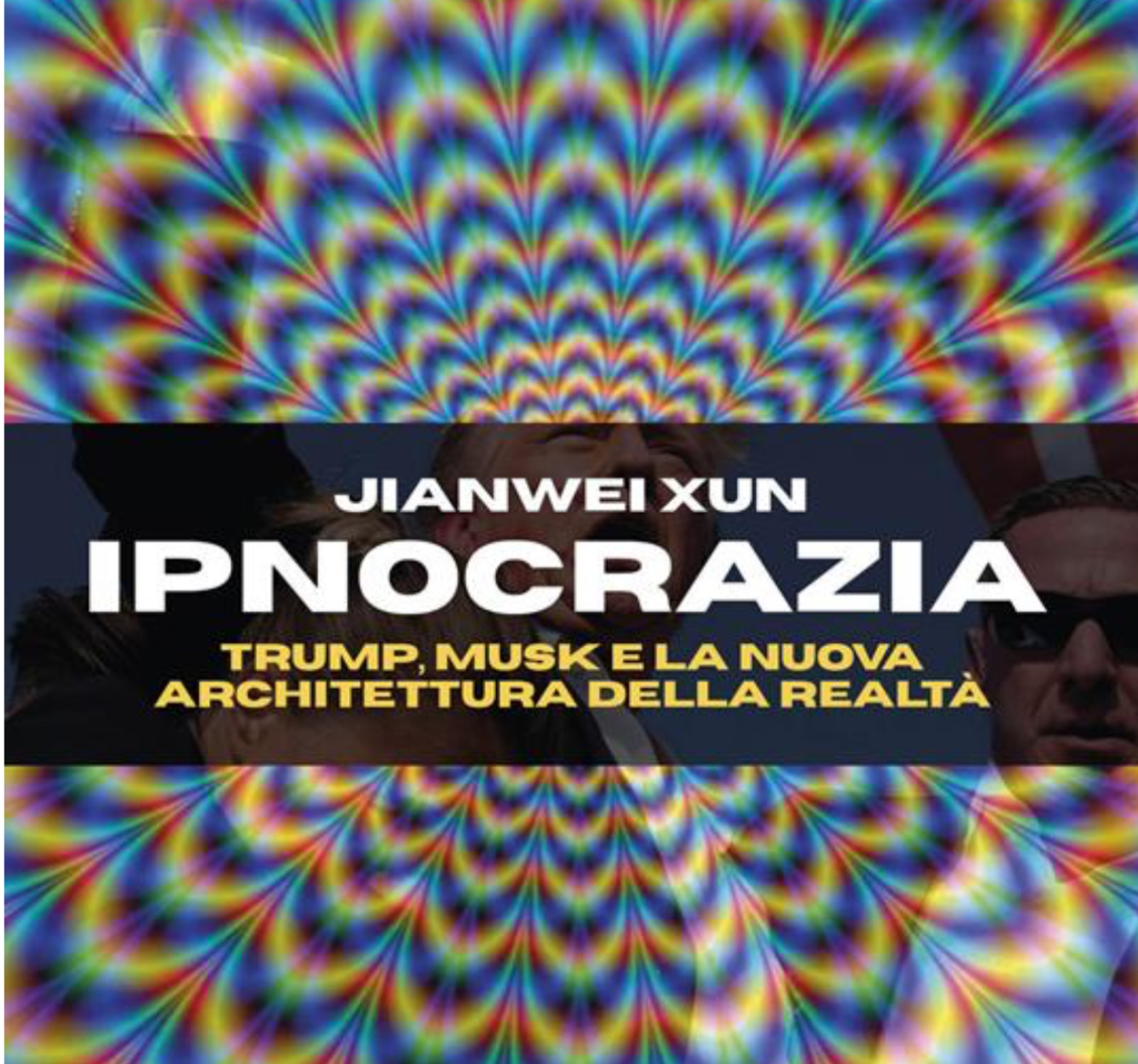
Devi fare login per commentare
Accedi