Grandi imprese
Che fine farà la pubblicità? Cronologia da Mike Bongiorno al Covid-19
In principio era Mike. Nessuno come lui, nessuno più di lui sapeva impossessarsi di uno sponsor e renderlo ricco, dedicandogli uno spazio apposito di svariati minuti nei suoi telequiz, portando avanti quel brand per settimane, trasformandolo nel prodotto più desiderato dagli italiani, di qualunque genere esso fosse. Era la “Seconda Repubblica” della pubblicità, la tv commerciale che, oltre che dai fondi di dubbia provenienza, dipendeva dalla pubblicità, da quelli che oggi chiamiamo brand, ovvero le aziende italiane. Quanto desideravate andare a Gardaland? Era il protagonista assoluto delle sigle di Bim Bum Bam. E sempre parlando di quel format, quanto desideravate i Giochi Preziosi? Poi, col passare degli anni novanta, si è evoluto tutto negli anni duemila, quando è iniziato a girare il termine branded, con questa idea per la quale un marchio poteva diventare l’editore al posto della rete televisiva (parole non mie, ma di Renzo Rosso di Diesel): l’azienda poteva sponsorizzare i format televisivi inserendo il proprio marchio e i propri prodotti nello svolgimento dello show tv (product placement), non solo in spazi promozionali ad esso dedicati. Nasce così il branded entertainment: ma funziona? Che ritorni hanno le aziende da questo tipo di investimenti? Alla pari dei classici spot in tv? Alla pari delle sponsorizzazioni con Mike o con Gerry Scotti? E a livello di competenze, se il direttore marketing di un’azienda diventa a tutti gli effetti il produttore esecutivo di uno show televisivo, ha il knowhow necessario nel campo dello spettacolo? E dall’altro lato: i dirigenti televisivi italiani che arrivano dalla bambagia degli anni 80 e 90, sanno adeguarsi a questi nuovi “organigrammi non scritti” e trasformarsi in account procacciatori di sponsorship? Neanche il tempo di rispondere a queste domande ed ecco il 2008 con la sua crisi: crolla tutto.
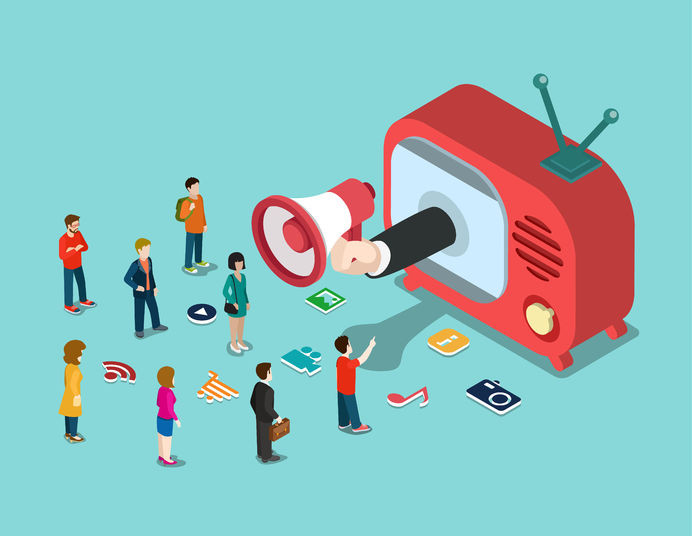
La televisione, l’editoria, gli eventi (e altri settori) come reagiscono? Si legano mani e piedi ai brand: senza il loro denaro non si costruisce più niente. Ma le aziende italiane proprio da quell’anno hanno un nuovo media in cui investire, cioè i social network: attenzione però, perchè se prima si investivano 300 mila euro da dividere tra concessionaria, rete tv/agenzie e produzione, ora il rapporto può essere diretto con il nuovo “canale” e costa meno di un terzo. I budget diventano risicatissimi, centinaia di realtà si dividono una torta che in breve tempo lascia sul piatto solo le briciole e sia i colossi, sia le medie realtà devono rendere conto delle loro impostazioni rimaste uguali, sia per quanto riguarda la mentalità, sia per quanto riguarda il numero dei dipendenti. Crisi su crisi, licenziamenti, adeguamenti strutturali, interventi sindacali, contratti praticamente illegali per i dipendenti, tutto con il solo scopo di rimanere a galla in quella che si delinea sempre più come una guerra tra poveri. Il nuovo versante è il branded content e i canali sono i social network, mentre il branded entertainment cola a picco lasciando in vita pochissime realtà, che comunque non se la passano bene. Allora, siccome dalle necessità nascono le nuove idee, le agenzie pubblicitarie più intelligenti diventano digital, oppure nascono da zero nuove agenzie che hanno già questa impostazione. Le aziende nel frattempo si adeguano, sviluppando al loro interno nuove sezioni dedicate al marketing e comunicazione digital. Gli esperimenti per far funzionare questa nuova macchina sono numerosi: preroll su Youtube (sperando che nessuno clicchi “skip this ad”), formati video di lunghezza variabile su Facebook (sperando di catturare l’attenzione del consumatore per una manciata di secondi), campagne fotografiche e poi video su Instagram, Pinterest e Twitter, inserendo o meno il proprio marchio o il proprio prodotto, il tutto rendendo potentissimo e ricchissimo Mark Zuckerberg, ma vedendo a fatica delle entrate utili sul conto corrente dell’azienda (e di tutti i mediatori, produttori ecc..). I più bravi, svegli e furbi però ce la fanno: sono quelli che sanno approfittare di questo momento con le idee giuste al momento giusto e che devono prediligere (ahimè) la quantità rispetto alla qualità. E’ un capovolgimento totale davanti agli anni 80 e 90: è meglio avere 30 clienti e realizzare tanta pubblicità di qualità medio/bassa piuttosto che averne pochi e tenere la qualità alta. E’ una mera questione di budget e guadagni. Chi resta indietro muore, oppure agonizza tra acquisizioni societarie, fusioni ed esuberi, dove (purtroppo) il Governo Tecnico del 2011 dà una grande mano. Poi c’è la questione della professionalità: a causa dei budget molto bassi, la nuova classe dei professionisti del settore è sottopagata, viene prelevata direttamente dalle università (dando loro dei job title pomposi da inserire nella firma della propria email aziendale) e non vengono adeguatamente preparati con corsi e master forniti dalle aziende (utilizzando Sales Force o programmi di Project Management). Di conseguenza, i “nuovi account” sono troppo giovani e improvvisati, asserviti a qualsiasi idea e decisione (anche controproducente) di un cliente, perchè non hanno i mezzi per poter proferire parola.
Ma in tutto questo, che cos’è il vero branded content? E’ un format molto innovativo ed efficace, se usato nel modo giusto: ovvero comunicare qualcosa di utile e interessante da raccontare, cioè avere un vero e proprio contenuto. Ci provano più o meno tutti, destreggiandosi tra scivoloni epocali (vedi le dichiarazioni di Guido Barilla nel 2013) e operazioni vincenti (vedi Ferrero e Lavazza), accogliendo contemporaneamente la grande novità dei nuovi players sul mercato, veri maestri della comunicazione digital: i canali in streaming. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Hbo Max (che non c’è in Italia) diventano le nuove “reti televisive” verso le quali si converte la maggior parte della popolazione. Avete visto recentemente il messaggio tv di Mediaset che per la prima volta nella sua vita chiede ai propri spettatori di investire nella pubblicità sui propri canali? Forse non ci avete dato molto peso, ma è una svolta epocale. La pubblicità non è più una comunicazione B2B con lo schema classico “rete – concessionaria – brand”, ma diventa B2C, dove la rete parla direttamente alle persone a casa sul divano davanti alla tv chiedendo loro, in poche parole, un aiuto per sopravvivere. E a cosa devono sopravvivere? Agli investimenti pubblicitari ormai concentrati sui social network e al devastante impatto delle piattaforme streaming elencate poco fa.
E queste, come si sono fatte conoscere e come si sono letteralmente mangiate il mercato in 5 anni? Prima applicando una strategia promozionale basata sui propri contenuti (film, serie tv, documentari) per mostrare cosa potesse ottenere un nuovo abbonato, guardando tutto senza interruzioni pubblicitarie; poi, una volta ottenuta l’attenzione e la fiducia di milioni di persone, si sono stabilizzati sul brand awareness, ovvero sono consapevoli della loro potenza e adesso basta loro mostrare il proprio logo per pubblicizzarsi. Ma non solo: Netflix per esempio ha brandizzato il Pride a Milano nel 2018, sposando i valori della comunità LGBT e finanziando tutto lo spettacolo col carro del Pride in centro città e gli arcobaleni sui Bastioni di Porta Venezia e nella stazione della metro (che poi, per volere del Comune, è rimasta arcobaleno). In questo modo rafforzi il tuo brand, dai un grande esempio di modernità e di controcultura (in Italia) e aumenti gli abbonati. L’agenzia che ha seguito questa operazione era We Are Social, che a sua volta ha prodotto quest’anno un bellissimo documentario per Lavazza (si trova su Amazon Prime Video) sul riscatto dei lavoratori nei campi in Colombia, che invece di lavorare per le coltivazioni di coca, si sono salvati lavorando nel settore del caffè per Lavazza. Altro esempio: Ikea nel 2019 ha fatto produrre in particolare due campagne, una per il Pride e una contro il cyberbullismo. Questo è il vero branded content: pubblicizzare la propria azienda (e di conseguenza il proprio prodotto) attraverso contenuti utili e interessanti, senza la necessità di dover mostrare direttamente il prodotto. E se un prodotto video o fotografico di questo tipo piace, non bisogna nemmeno sottovalutare il “passaparola” tra utenti, esattamente come quando si consiglia di persona agli amici o sui social una serie tv da guardare.
Ma non è finita. Nel 2020 è arrivato il Covid-19, che può essere chiamato, come diceva Totò, “la livella”. Le aziende si fermano, le tv si fermano, le agenzie e le produzioni si fermano. Grandi realtà legate ai fasti del secolo scorso, che sarebbero cadute entro un paio d’anni, anticipano la loro fine. Purtroppo devono seguirle anche realtà meno grandi, ma oggi davanti a un’emergenza mondiale non scappi alla tua sorte se non hai guadagnato abbastanza per rimanere in piedi tre mesi senza fare niente (e tutta l’estate con la cassa integrazione). Per non parlare delle piccole realtà, che purtroppo non hanno scampo. L’effetto domino è devastante, sono tutti collegati a cascata e, per la prima volta dopo decenni di business in questo settore, sono tutti allo stesso livello, tutti uguali. Forse questo servirà a ripensare quasi da zero il modo di lavorare e fare strategia nei media e nella pubblicità, forse dalla crisi nasceranno nuove opportunità, forse sopravviverà solo chi ha la capacità di reinventarsi senza restare fermo al palo aspettando un intervento dall’alto. La certezza, al momento, è che ne sia stata colpita profondamente la mentalità, insieme al portafogli. Che fine farà la pubblicità?



Devi fare login per commentare
Accedi