Agricoltura
L’Italia, terra di terre marginali. L’agricoltura come nuovo umanesimo
Pubblichiamo un estratto dal volume “Terre marginali” (Quodlibet), di Francesco Caponetti. Ringraziamo l’editore per la disponibilità.
Alla chiara denuncia delle colture industriali intensive, figlie della modernità occidentale, si affiancano però abbozzi di modelli alternativi, che possono costituire nuove opportunità di crescita. Francesco Caponetti – Senior Industrial Advisor della Bers (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e direttore generale – oltre che membro del consiglio di amministrazione – della Cediamsa (Centre d’Étude et de Développement Industriel et Agricole du Mali) – propone come possibile vettore di cambiamento, una visione umanistica basata sull’inversione della rotta fin qui seguita, e dunque sulla concretizzazione, per le popolazioni che migrano da contesti difficili, della possibilità di contribuire al loro sviluppo nei territori d’origine.
“Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”. Non sono un letterato, per carità. Però penso che l’umanesimo italiano sia nato da questi due versi di Dante, a cavallo fra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo.
Se si va sulla Treccani, l’enciclopedia del sapere italiano, questa è la prima definizione di umanesimo:
Periodo storico le cui origini sono rintracciate dopo la metà del XIV sec., e culminato nel XV: tale periodo si caratterizza per un più ricco e più consapevole fiorire degli studi sulle lingue e letterature classiche, considerate come strumento di elevazione spirituale per l’uomo, e perciò chiamati, secondo un’espressione ciceroniana, studia humanitatis.
Ma non è questa, la definizione che ci interessa. O forse la riprenderemo più avanti. Proviamo con un’altra. La seconda: L’umanesimo nasce per primo in Italia perché qui, prima o più che altrove, esistevano le condizioni favorevoli alla nascita dei rapporti economici mercantilistici. Nei secoli XIV e XV l’Italia era uno dei paesi più progrediti del mondo (in senso borghese). L’Italia di allora era quindi paragonabile al Primo Mondo di oggi. In molte città-stato repubblicane era avvenuta l’emancipazione dei contadini dalla servitù della gleba. Una libertà che consentiva loro di trasformarsi in operai salariati nelle fabbriche di panno (opifici) o in braccianti.
Era perciò un bel passo avanti. Però quella libertà si era trasformata in una nuova forma di sfruttamento. Erano sfruttati da artigiani arricchiti, i quali consegnavano loro la materia prima o semilavorata ricevendo in cambio il prodotto finito. Sfruttati dai maestri delle corporazioni, che spesso li costringevano a restare garzoni e apprendisti per sempre. Sfruttati da mercanti-imprenditori, che li utilizzavano nelle loro manifatture solo per produrre merci d’esportazione, offrendo loro salari molto bassi, orari molto pesanti, mansioni parcellizzate, pochissimi diritti e stretta sorveglianza sul luogo di lavoro. Sfruttati da altri ricchi contadini neo-proprietari o persino dagli stessi feudatari di prima che ora li sfruttano con altri metodi (ad esempio, la rendita in denaro).
Non ci ricorda qualcosa? Non è forse la posizione del Primo Mondo nei confronti degli altri?
Sommiamo adesso la prima e la seconda definizione.
Probabilmente i risultati più significativi e duraturi l’Italia li ottenne non sul terreno economico e politico, ma su quello culturale, poiché la nascita dell’umanesimo portò alla nascita delle arti rinascimentali.
La riscoperta dell’autonomia della natura, con le sue leggi specifiche, portò allo sviluppo delle scienze esatte e applicate. Quindi, parlando di arti rinascimentali, non dobbiamo pensare solo alla Gioconda, alle statue di Verrocchio o Michelangelo, ma anche alle scienze.
Dobbiamo pensare a Leonardo, ad esempio: quel Leonardo che, su incarico di Cesare Borgia, progetta i canali per bonificare la val di Chiana e gli strumenti per irrigarla razionalmente. Dobbiamo pensare allo sviluppo della geografia e della cartografia, della meccanica, dell’ottica, delle costruzioni navali. E anche dell’agronomia. La borghesia aveva bisogno dello sviluppo delle scienze basate sull’esperienza e sul calcolo, indispensabili alla produzione e al commercio dei beni di consumo.
Ed eccoci arrivati alla fine del nostro ragionamento. Oggi non è più solo la borghesia (che in termini moderni possiamo identificare nel Primo Mondo) ad avere bisogno dello sviluppo. Oggi non si può parlare più di produzione di beni di consumo. Di quelli, ce ne sono persino troppi.
Oggi il vero drammatico obiettivo è quello di sfamare gli altri mondi; di farlo in modo equo ed eco; di riuscirci andando a sostenere lo sviluppo là dove ce n’è bisogno. E di farlo in modo realmente sostenibile, cioè rispettando gli equilibri di un ecosistema che diventa sempre più fragile e che non ha più le risorse per potersi autorigenerare. Per farlo, occorre recuperare il senso della misura, che è ben lontano dai grandi numeri e dalle grandi produzioni. E un profondo rispetto per tutto l’ambiente che ci circonda. Fosse solo perché questo mondo è l’unico possibile nel quale poter vivere.
L’italia può farlo. Non solo perché ha fondato la propria economia su quella piccola e media impresa che ha saputo riscattare le proprie lentezze strutturali rispondendo con progetti sperimentali e coraggiosi; non solo perché grazie a quel coraggio oggi è padrona di competenze tecniche e industriali avanzatissime; ma anche perché è riuscita a fare sistema creando filiere allargate, un tessuto, cioè, di circa due milioni di imprese che lavorano e portano servizi e tecnologie nel settore agroindustriale. Un settore cresciuto all’interno di una cultura del piccolo, del prossimo e del bello, che gli ha consentito di affinare uno sguardo che potremmo definire da geologo: in grado di leggere, cioè, strati e sedimenti del passato, con quella visione – umanistica – che si orienta nelle differenze e legge le relazioni tra le parti.
L’Italia è un meraviglioso mosaico di terre marginali: ognuna con una sua caratteristica, con una sua produzione agricola, con un suo patrimonio di identità culturale e di biodiversità.
Cito dal sito ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali:
L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’Unione Europea. Un’ulteriore dimostrazione della grande qualità delle nostre produzioni, ma soprattutto del forte legame che lega le eccellenze agroalimentari italiane al proprio territorio di origine.
Il sistema delle Indicazioni Geografiche dell’Ue, infatti, favorisce il sistema produttivo e l’economia del territorio; tutela l’ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità; sostiene la coesione sociale dell’intera comunità. Allo stesso tempo, grazie alla certificazione comunitaria si dànno maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti. Ormai in Italia, la certificazione l’hanno ottenuta ben 293 (dico duecentonovantatré) prodotti agricoli alimentari DOP, cioè a Denominazione di Origine Protetta.
Vanno dall’aglio di Voghera al cappero di Pantelleria, dall’olio di Canino al Bruzio di Cosenza, dal carciofo romanesco del Lazio alla ciliegia di Marostica, dalla nocciola di Giffoni allo zafferano di Sardegna. E, grazie a una politica lungimirante, quel prodotto si è trasformato in un tesoro per quel piccolo tassello di terra: un patrimonio che proviene dalle tradizioni più antiche dell’agricoltura locale e diventa oro.
Diventa benessere per chi vive lì, diventa possibilità di reinvestire, di mantenere, di tutelare, di dare un futuro alle proprie tradizioni, ma non con l’approccio ingenuo del revival folkloristico, bensì con lo sguardo umanistico che cerca il progresso senza necessariamente distruggere il pregresso. Guardando a queste terre con la consapevolezza che queste rappresentano gli unici, e ultimi, spazi di vita e salvaguardia di un intero ecosistema.
È stato proprio grazie alle infinite diverse esigenze di ognuna di queste tante terre marginali, che in Italia si è sviluppato, molto più che in altri paesi del mondo, il settore della produzione di macchine, di macchinari, di impianti diversi per ogni singola necessità o potenzialità agricola.
E si è sviluppata una forma di cultura agronomica che pochi possono vantare.
La cultura non solo di saper sentire la terra – come ci suggeriva il Polverini quando ero ragazzo – ma anche di saper valutare l’ambiente in cui quella terra si trova, anche di capire le tradizioni sulle quali l’agricoltura locale si è sempre poggiata, anche di saper valutare quale impatto positivo o negativo le innovazioni tecnologiche possono determinare sul territorio e sulle genti.
Con una visione che davvero possiamo definire umanistica.
Oggi l’Italia può fornire non solo mezzi e strumenti per l’agricoltura. Può, o forse dovrebbe, diventare una guida per le linee di sviluppo delle nuove agricolture in tanti paesi del mondo e del Terzo Mondo. Ha la cultura umanistica, quella scientifica, la ricerca nelle tecnologie e nelle materie e, anche, una propria tradizione progettuale che ci ha resi famosi nel mondo.
In Italia, a Parma, esiste già l’EFSA, cioè la European Food Safety Authority, ovvero, in italiano, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare che fornisce consulenza scientifica e di comunicazione in materia di rischi, esistenti ed emergenti, associati alla catena alimentare. Cioè dei prodotti agricoli. Un baricentro istituzionale strategico al quale agganciare tutti gli altri poli istituzionali. Forse è già così, non saprei, ma sicuramente sarebbe possibile immaginare uno scatto in avanti, proporre un paradigma differente che possa essere assunto a modello di sviluppo da esportare.
Ma sarebbe solo un primo passo.
La visione deve essere il mondo, ma la missione deve essere il Terzo Mondo e prima di tutto l’Africa, perché è il continente che nell’immediato futuro sarà il vero protagonista degli investimenti economici e di colonizzazione mondiali. Un terreno troppo gustoso per gli appetiti dei grandi investitori e, al tempo stesso, il contesto nel quale le emergenze ambientali subiscono accelerazioni inimmaginabili. Partire proprio da là potrebbe significare lanciare un messaggio forte sulla volontà, concreta, di intendere la progettazione come un agire responsabile, sia in termini di sviluppo che di contrasto alle emergenze.
L’Italia, da sempre, è stata il ponte fra l’Europa e l’Africa e l’Oriente. È stata l’ordito sul quale sono state costruite trame di commerci, traffici e storie. Il Mediterraneo ha rappresentato un fitto scambio di saperi e culture e l’Italia terra di approdo.
Lo è ancora, sempre di più. Ma oggi le rotte significano altro: pensiamo alla spaventosa, epocale tragedia che stiamo vivendo tutti i giorni con gli sbarchi quotidiani di popoli interi, disperati, che arrivano da quei paesi fuggendo da guerre e fame. Inseguendo le chimere del Primo Mondo, forse. O semplicemente scappando. Volendo vivere, sicuramente.
Cercando da noi un aiuto che noi, volenti o nolenti, non possiamo non dare. Ma non pensando solo ai loro difficili destini. Pensando anche ai nostri, a quello che ci aspetta da qui a qualche decina di anni. Con la consapevolezza che questo è l’unico mondo possibile. Ed è la somma di tante terre. Marginali.

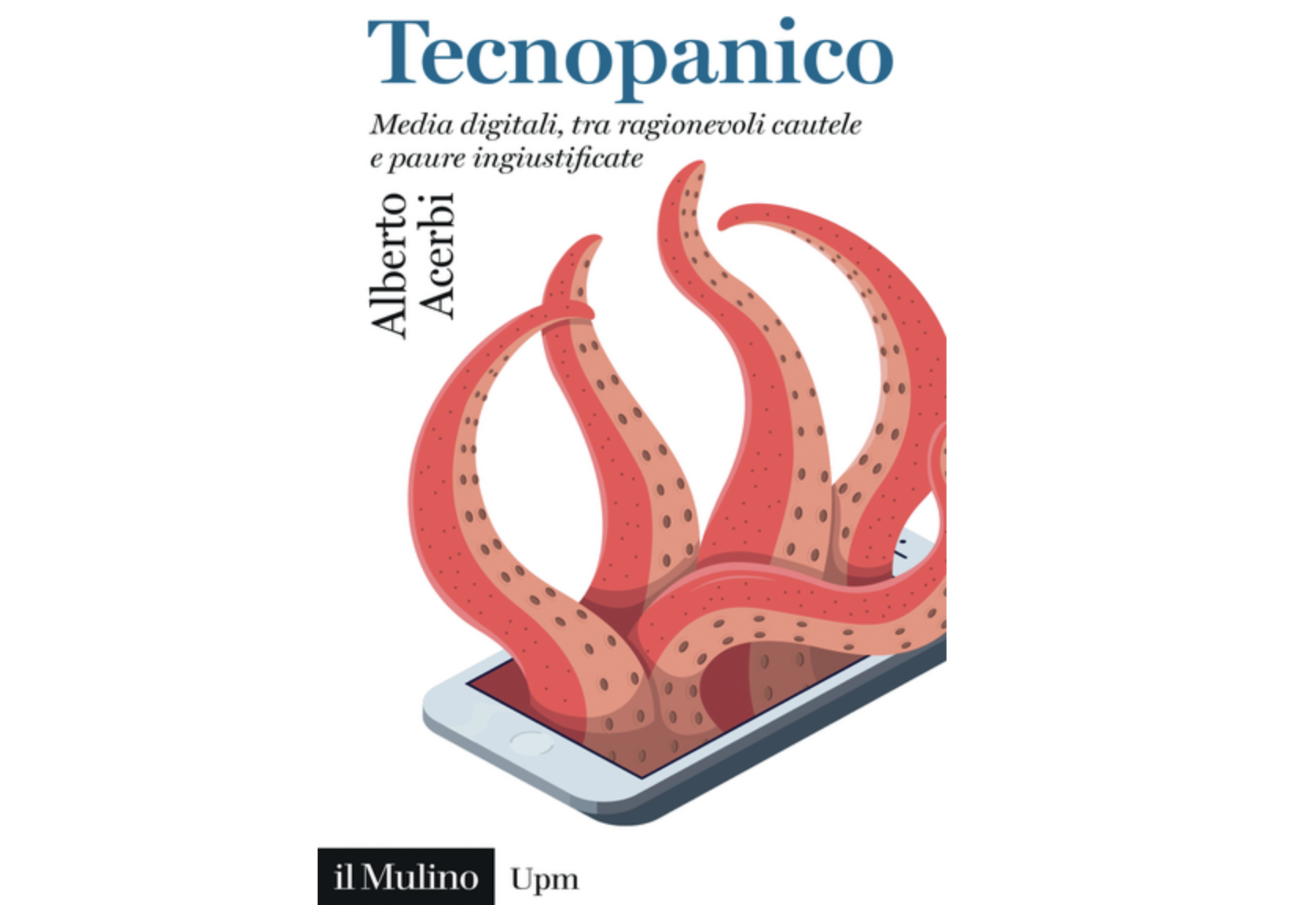
Devi fare login per commentare
Accedi