
Teatro
La farsa della vita
Una riuscita riscrittura dei Menecmi di Plauto.
Plauto è una straordinario inventore di macchine teatrali. Non gli interessa la verosimiglianza dell’azione, la plausibilità dei caratteri, devono funzionare l’intrigo complicato, l’equivoco, il dialogo, le battute indimenticabili, a rappresentare sulla scena il nonsenso della vita. Mercurio, nell’Amfitrione, tempesta di pugni lo schiavo Sosia, perché rinunci a credersi Sosia. I pugni sono un argomento convincente. E Sosia non sa che pesci pigliare, e alla fine gli chiede: “Ma se non sono Sosia, chi sono?” In questa battuta c’è in fondo tutto il senso del teatro di Plauto. La realtà è piuttosto meschina, perché Sosia non deve entrare in casa, in quanto là dentro c’è Giove che trasformatosi in Amfitrione si sta godendo a letto la moglie di Amfitrione. Da questa bellissima commedia sia Molière sia Kleist trarranno altre due bellissime commedie, nelle quali il gioco dell’identità è messo a rischio. I personaggi sono fissati in maschere, in tipi, come nell’atellana, spettacolo assai popolare a Roma, e il cui spirito entra tra gli elementi della commedia plautina. Verrà Terenzio a recuperare la finezza psicologica della commedia nuova di Menandro. Plauto vuole far ridere il pubblico. E qualsiasi espediente è benvenuto. È per questo il modello della commedia d’intrigo fino ad oggi, da Shakespeare a Goldoni, dalla commedia italiana rinascimentale, alla commedia dell’arte, a Molière, dalla commedia del siglo de oro, soprattutto Tirso e Lope, al vaudeville parigino. Plauto era inoltre uno straordinario manipolatore della lingua. Le fonti del teatro greco alle quali attinge sono manipolate, tagliuzzate, ricomposte, mescola più commedie, il risultato è un fuoco d’artificio d’invenzioni esilaranti. Un genio della comicità come ne esistono pochi: Aristofane, Molière, Chaplin, Buster Keaton.
Vincenzo Zingaro, al Teatro Arcobaleno di Roma, ripropone i Menecmi (Menaechmi), la commedia che fu modello a Shakespeare per la Comedy of Errors e a Goldoni per I due gemelli veneziani. E a tantissimo teatro d’arte. E si prende con Plauto le libertà che Plauto si prende con la commedia greca: a Roma si proibì, visto anche l’enorme successo di pubblico, che sulla scena si satireggiassero i costumi romani, e i comici furono costretti a rappresentare solo soggetti greci. I greci si potevano prendere in giro, i romani no. L’Italia di oggi sembra avere imparato bene la lezione. Una querela zittisce subito l’importuno che osa ridicolizzare un potente italiano. Nella commedia dell’arte le maschere parlavano ciascuna il dialetto della città in cui erano nate, Pulcinella il napoletano, Arlecchino il bergamasco e poi il veneziano, Pantalone il veneziano, Balanzone il bolognese, Gianduia il torinese, Rugantino il romanesco. Recitavano nei teatri e nelle piazze d’Italia ed erano capiti dovunque. Zingaro fa parlare uno dei due Menecmi siciliano, perché di Siracusa. Gli altri personaggi parlano chi il romanesco, chi il napoletano, chi il barese. Il testo latino di Plauto è riscritto nelle parlate locali italiane, come Plauto riscriveva il testo greco dei commediografi greci. E anzi adatta perfino ai costumi romani le convenzioni della commedia. Il divieto di ridicolizzare Roma, cacciato dalla porta dell’ambiente scenico, che era obbligatoriamente greco, rientrava dalla finestra delle battute. Se la lettera plautina può sembrare offuscata, l’irresistibile spirito comico plautino è restituito in pieno. La commedia racconta di due fratelli gemelli separati da un naufragio. Uno fa fortuna a Epidamno, sulla costa illirica, l’attuale Durazzo, l’altro lo cerca per tutti i mari finché arriva anche lui a Epidamno. Menecmo I, che vive a Epidamno, si è sposato, ma tradisce regolarmente la moglie con una prostituta, Erotia (nomina sunt consenquentia rerum), che gli vive di fronte. Quando arriva Menecmo II è scambiato per il primo e da qui tutta una serie di esilaranti equivoci, non ultimo che Menecmo II è molto più bravo di Menecmo I a fare godere le donne.
L’equivoco si scioglie quando sulla scena i due compaiono insieme. La maschera nasconde il volto, bastano gli stessi abiti a designare i gemelli, anche se interpretati da due diversi attori. Ma solo nella scena finale. Perché per tutta la commedia i due Menecmi sono recitati dallo stesso attore, Piero Sarpa, bravissimo, duttilissimo, anche a cambiare dialetto. La scena sembra un teatrino di marionette. E gli attori gestiscono come marionette, senza nessuna ricerca di realismo, come fino a qualche anno fa si poteva vedere sulla terrazza del Pincio, a Roma, dove agiva un bravissimo burattinaio che divertiva bambini, ragazzi, e accompagnatori, i quali ultimi forse si divertivano più ancora degli accompagnati. Il pubblico, come nel teatro d’arte, ride, applaude le battute più spiritose, e alla fine decreta per tutti un successo trionfale. Resta in scena fino al 9 marzo. Chi vive a Roma o ci passa, non se lo perda. Annalena Lombardi è una divertentissima Erotia, Giovanni Ribò il servo Spazzola, Rocco Militano il servo Messenione, commovente la battuta in cui chiede la libertà, Fabrizio Passerini il rabelaisiano Cuoco e un Medico spassosissimo, oltre che Menecmo II nel finale, Laura de Angelis la moglie e un’ancella, Maurizio Casté un irresistibile vecchio che parla romanesco, è padre della moglie di Menecmo, mezzo cieco e imbranato: non capisce che cosa gli dicono, e se gli strillano protesta: “Ahò! so’ cieco mica sordo”. Azzeccatissime le musiche di Giovanni Zappalorto. La scena è disegnata dallo stesso Zingaro che cura anche la regia.




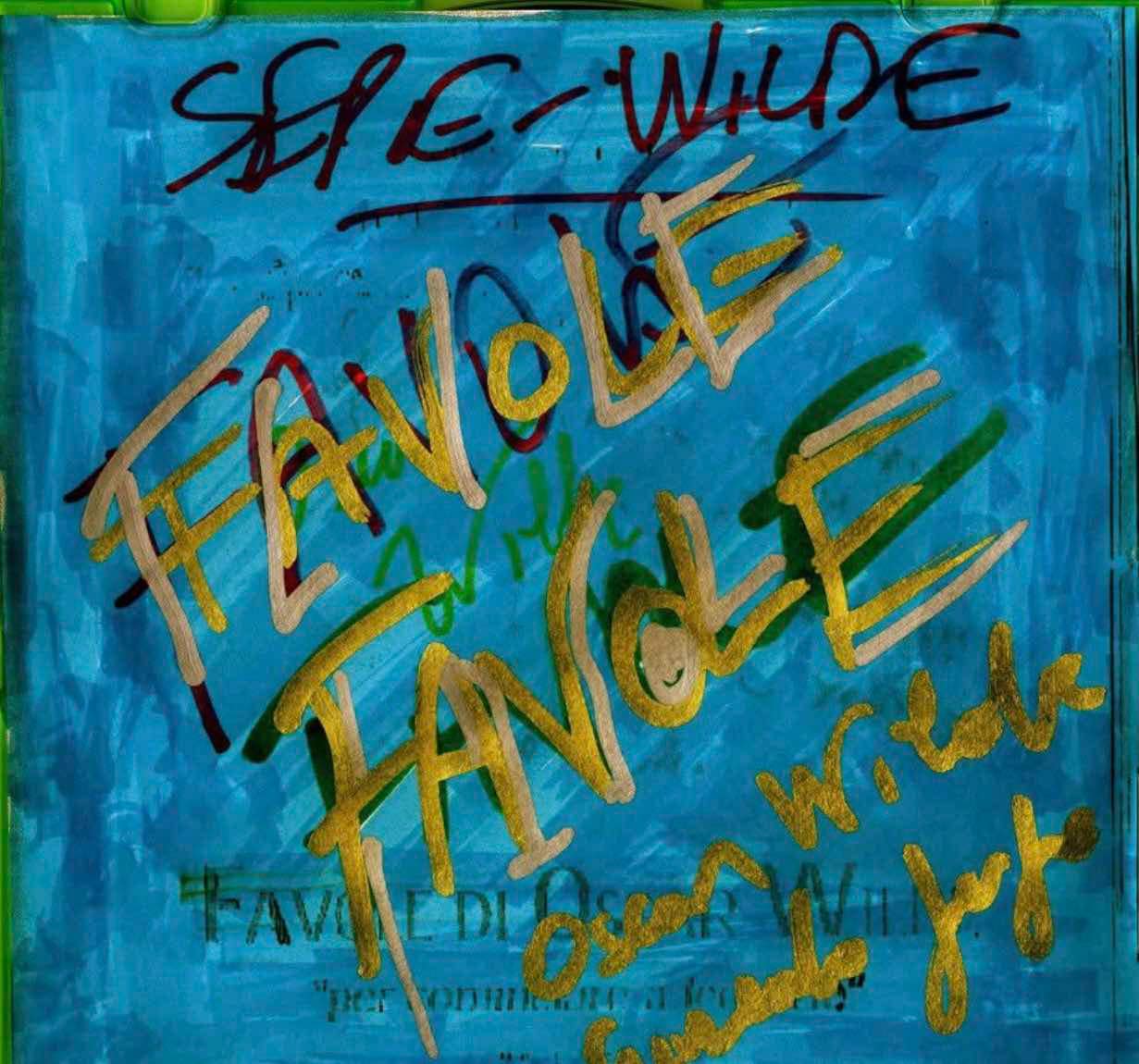


Devi fare login per commentare
Accedi