Teatro
Alessandro Serra e la regia da Edward Hopper a Shakespeare
Sta vivendo un momento di creatività particolarmente felice, il regista Alessandro Serra. Oltre ai lavori realizzati con la sua compagnia Teatropersona, fondata nel 1999, Serra è in scena alla Triennale di Milano con il suo intensissimo Macbettu, versione barbaricina della tragedia shakespeariana, prodotto dal Teatro Stabile di Sardegna (fino a domani); poi sarà al festival Primavera dei Teatri di Castrovillari e infine presenterà al Napoli Teatro Festival (il 10 e 11 giugno) il suo nuovo spettacolo, F R A M E (scritto proprio così, maiuscolo e staccato) dedicato alla pittura di Edward Hopper, allestito con il teatro Koreja di Lecce. Mentre non si è ancora spenta l’eco di un allestimenti firmato per il cosiddetto “teatro ragazzi”: quell’H+G, tratto da Hansel e Gretel, realizzato con la Ribalta, Accademia arte della Diversità che seguiva altri ottimi lavori come Il principe Mezzanotte o Il grande viaggio, fatto con Accademia Perduta. Ma nel percorso della compagnia ci sono anche titoli come L’ ombra della sera, dedicato a Giacometti, interpretato da Chiara Michelini o ancora i primi spettacoli come Aure, Trattato dei Manichini, Beckett Box.
Dunque, è naturale provare a fare il punto su questo percorso, ponendo qualche domanda al regista e autore.
Partiamo proprio da Hopper, da questo F R A M E. Di che si tratta?
«È un progetto nato su invito di Salvatore Tramacere, per un laboratorio fatto al teatro Koreja di Lecce, alla fine del quale ho individuato cinque attori con cui abbiamo deciso di realizzare lo spettacolo. Da tempo, Edward Hopper mi ronzava per il cervello. Mi rendevo conto, però, che l’errore madornale sarebbe stato cercare di raccontare storie attraverso le sue immagini. Il che è paradossale, sarebbe stato esattamente quello che lui ha sempre cercato di non fare. Hopper, infatti, ha puntato a cristallizzare l’emozione in un frammento, in un frame: una frattura, una crepa nella vita còlta in un unico momento, senza svelare nulla. Tanto più ometteva indizi tanto più era forte l’immagine. C’è un dipinto, in particolare, in cui Hopper accenna a una espressione del viso, a un libro sul letto che ha una certa connotazione, forse Platone: ma con questi indizi quel quadro perde di potenza rispetto ad altri in cui è meno esplicito. Allora, se l’idea iniziale era quella di scrivere un testo partendo dalle storie che sono nascoste dietro le immagini, mi sono reso conto presto che la cosa sarebbe stata impossibile. Così, abbiamo lavorato sulle fragilità, su quelle fratture, su quei momenti appena accennati, eppure sono momenti di svolta della vita, cambiamenti…».
Lo spettacolo, visto in prova, è uno struggente e poetico “atto senza parole”, in cui sembra prevalere un aspetto cupo, oscuro, rispetto a certa solarità che pure si nota nelle tele di Hopper…
«Ma in Hopper, come in Munch, c’è sempre il nero. Un nero di fondo, misterico. Con Hopper quasi non te ne accorgi, sei sedotto dal vuoto. Pensiamo agli alberi illuminati, che lui ritrae: sono brillantissimi, ma sotto, sul fondo, i tronchi sono oscuri, cupissimi, creano sentieri neri. C’è sempre un vuoto, che risucchia chi osserva».

Come crea le immagini dei suoi spettacoli? Da cosa nasce una immagine?
«È una domanda che mi sono posto a lungo. Addirittura dai tempi della mia tesi all’Università di Roma, che era proprio sulla drammaturgia delle immagini. La domanda che mi ponevo era come comunicare solo attraverso le immagini. La cosa sorprendente è che da allora a oggi il mio punto di vista non è cambiato. Ricordo di aver studiato molto, attingendo a fonti molto più nobili della mia misera esperienza e quel percorso di studio mi è servito da scuola. Partendo da Leonardo da Vinci, per arrivare a oggi, ho potuto riflettere molto su questo tema. Ma il mio modo di lavorare non è cambiato».
Ossia?
«Intanto, sin dai primi giorni di prova, lavoro con gli attori avendo già a disposizione tutto quel che serve. Mi occupo non solo della regia, ma anche delle scene, costumi, luci, testo. E incontro gli attori solo dopo aver fatto i miei studi sul lavoro che affrontiamo. Iniziamo a lavorare con gli oggetti necessari – anche se non definitivi – e da quel momento metto tutto me stesso e i materiali elaborati a disposizione dell’incontro con gli attori. Nella fase iniziale, lavoro con gli oggetti emancipandoli dalla storia, dalla drammaturgia, dal tema: ad esempio, se Hopper mi suggerisce una “sedia” o Macbeth un “coltello”, io, fedele al testo, prendo questi oggetti e li do in pasto agli attori. Ma lo faccio emancipandoli dal testo stesso. Lavoriamo con l’oggetto quotidiano e vediamo cosa ne scaturisce. Allora ci chiediamo che tipo di emozioni può creare l’immagine che abbiamo elaborato, oppure, meglio, ci interroghiamo su cosa sia quella immagine. Una signora che si siede sulla sedia? E poi? Che emozione veicola? Partiamo da domande simili e, infine, solo successivamente, dopo il “Cosa” e il “Che emozione”, ci chiediamo come terza domanda che cosa sia quell’immagine rispetto al testo o rispetto all’universo al quale ci stiamo relazionando. Nei primi anni di lavoro, erroneamente anteponevo questa terza domanda alle altre, ma sbagliavo. Il rapporto con il testo arriva successivamente. Perché le nostre immagini sono emotive. La natura delle immagini è emotiva. Sempre: una immagine non è né concettuale – ossia non la creo – né, tantomeno, l’illustrazione del testo. È qualcosa che nel corso delle improvvisazioni con gli attori emerge e commuove tutti».
Le “formule del pathos”, direbbe Warburg…
«Sì, esatto. Se poi questa immagine emersa deve stare in vita, allora resta nello spettacolo, altrimenti, se destinata a morire, muore…».
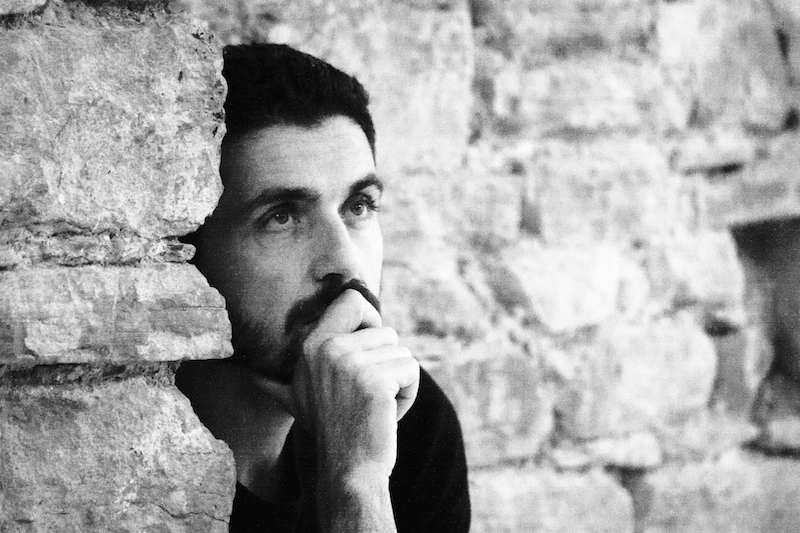
La drammaturgia segue la composizione scenica o arriva prima?
«È la materia a dettare legge. La drammaturgia arriva dopo. Con gli attori pratico questa cosa desueta che è il “training”. Lo guido io stesso. Per il lavoro su Hopper, come nel Macbettu, mi ha aiutato Chiara Michelini, che cura anche i movimenti di scena. Ma di solito, con qualsiasi gruppo di attori, mi presento in tuta e facciamo training assieme. “Arriviamo ai testi sudati”, come dice Peter Brook. Ed è un aspetto importante, altrimenti si avvia un lavoro con il rischio di “illustrare le idee del regista”, cosa che trovo molto deprimente. C’è una frase di Decroux che mi piace molto e diventa negli anni sempre più importante: “compiere lo straordinario attraverso l’ordinario”. E non viceversa. Nei miei primi anni da regista commettevo l’errore di fare il contrario. Adesso credo di aver intrapreso una nuova, e buona strada, che si è consolidata proprio con Macbettu, al quale ho lavorato a lungo».

Vuole raccontarci questo lavoro?
«Come avvenuto per H+G, è un modo per riconciliarmi. Macbettu è stato un modo per riconciliarmi con mio padre, mentre H+G per riconciliarmi con mia madre. Non so se ci sono riuscito. Ma ci ho provato. È un lavoro che inizia dieci anni fa. Come hobby ho la fotografia e nel febbraio 2006, feci un reportage fotografico tra i carnevali della Sardegna. I suoni cupi dei campanacci e le pelli di animali, le corna, il sughero. Le maschere e poi il sangue, il vino rosso. Erano Sorprendenti le analogie tra Sardegna e Scozia, e tra Shakespeariano e i tipi e le maschere sarde. A Mamoiada sfilarono i Mamuthones, ed erano la foresta che avanza. Un bambino mascherato da Issohadores era il fanciullo coronato, e poi le streghe, le attitadoras del carnevale di Bosa, uomini vestiti da vecchie. Dopo dieci anni sono riuscito a fare quel Macbeth. È il mio primo spettacolo di prosa. Adoro il teatro di prosa, vengo dalla ricerca, ma per me è un valore, non un disvalore».
Significativa è la scelta della lingua. Lei parla sardo?
«In casa si parlava solo sardo: io però non lo parlo ma lo capisco. È stata un’intuizione. Ero a Lula, mentre li sentivo parlare mi sembrava fosse giusto: una lingua così asciutta, così violenta, in cui non c’è un modo per dire “ti amo”, era perfetta per quel mondo di violenza di Macbeth. Ma all’inizio era solo una folgorazione. Tre anni fa, invece, organizzammo un laboratorio e un atelier a Palau con attori sardi. Nel gruppo di lavoro c’erano anche un attore inglese, Francis Pardeilhan, e Giovanni Carroni che poi ha tradotto il testo, e in quell’occasione abbiamo messo a confronto la lingua di Shakespeare e il sardo. Gli attori inglesi recitano Macbeth benissimo, ma “à la Shakesepeare”, ossia con un ritmo e un suon bellissimo eppure quasi innaturale, che non corrisponde al clima cupo di quella tragedia. Con il sardo non è così. In particolare, poi, abbiamo scelto il sardo barbaricino, quello dei miei nonni, che è ancora più asciutto, crudo, terribile. Una meraviglia».

Vorrei parlare un istante di H+G. Uno spettacolo particolarmente significativo, un passaggio importante credo, nel suo percorso registico…
«Non ho grande simpatia per il “teatro ragazzi”: ricordo gli spettacoli che vedevo nei primi anni di frequentazione del teatro e a tratti mi infastidivano. Raramente ho visto cose che mi affascinavano. Eppure adoro l’infanzia, e adoro i cartoni animati per l’infanzia, come quelli di Miyazaki. Ho creato due spettacoli per l’infanzia che forse non sono per l’infanzia, eppure ai bambini parlano. Cechov diceva una cosa bella: “non esiste una letteratura per bambini, esistono cose scritte da bravi autori che vanno bene anche per i bambini”. Questo mi sembra molto sensato. E non capisco perché ancora ci si ostini a mascherarsi da bambini, a fare le vocine. È così semplice, no?».
Chi considera suoi maestri?
«Non posso non riconoscere a Grotowski un merito eccezionale: è nato tutto da lui. Torno spesso ai suoi scritti, alla sua opera. Non ho studiato direttamente con Grotowski, ma con i suoi allievi, sono stato anche in Polonia. E tramite lui ho incontrato il Terzo Teatro. Però, a un certo punto, mi sono dovuto fermare. Nella ricerca para-teatrale di Grotowski vi è una evidente profondità, ma se esci dalla sfera dell’arte, allora può andare bene tutto. E la contraddizione nasce dal fatto che è stato lo stesso Grotowski ad affermare che il training serve a liberare e a consentire all’attore di donarsi allo spettatore, il training è un mezzo, e in quanto tale non andrebbe mostrato. Restando nell’arte del sei tutelato, puoi andare sino in fondo. Altrimenti, le derive possono essere rischiose: si confonde lo stato in cui sprofonda l’attore con quello che dovrebbe investire lo spettatore. Il rischio è di vedere cose imbarazzanti. Eppure Grotowski era un grandissimo regista: vidi Akropolis in un video, all’Università La Sapienza, ricordo di aver pianto. L’altro polacco, anche lui per me fondamentale, è Kantor: soprattutto, e forse paradossalmente, per quel che afferma sul lavoro dell’attore. Poi, ovviamente, ci sono altri riferimenti. In questi giorni leggo Re Lear – Shakespeare fa sempre bene alla salute – e ho ripreso un vecchio libro-intervista di Strehler: è molto lontano da me, eppure serve. Sono cresciuto con i film di Ingmar Bergman, il nome della nostra compagnia, Teatropersona viene da lì: una delle prime cose che ho fatto è stato scrivere testi teatrali tratti dai film di Bergman. Come un pazzo, con il videoregistratore, avanti e indietro: ma è stata la mia scuola di drammaturgia. Il teatro come lo faceva lui è sempre molto affascinante. Oggi posso dire che, pur essendomi formato nel teatro di ricerca, la parola “prosa” non mi fa paura. Mi fa paura, a volte, quella che vedo, non la prosa che vorrei fare o che ho visto qualche volta. E mi piacerebbe lavorare sui classici».
Ad esempio?
«Con la mia compagnia ho la possibilità di poter fare quello che voglio quando voglio. Ed è una libertà che mi tengo stretta. Ma i progetti non possono che essere piccoli, come sono stati Aure o il Trattato dei Manichini, che hanno avuto una lunga vita e con cui abbiamo girato tanto anche all’estero. Ma per progetti più ampi servono condizioni adatte. In Sardegna, ad esempio, ho chiesto 50 giorni di prove: uno sproposito visti i tempi produttivi di oggi. E lo Stabile mi ha concesso totale libertà, di occuparmi di tutto. Dunque un’occasione preziosa, anche per l’incontro con un attore come Leonardo Capuano. Ci siamo trovati molto bene, e mi mi piacerebbe incontrare altri artisti del suo livello con cui collaborare in futuro. Dunque lo sguardo è rivolto alla prosa: ci sono opere su cui vorrei continuare a lavorare. Questa estate dedicherò un atelier a Re Lear; lo scorso anno, il Giardino dei Ciliegi – amo molto Cechov –, ed è un testo potentissimo».
(Le immagini di copertina e dell’articolo sono dello stesso Alessandro Serra, che ringrazio)

Devi fare login per commentare
Accedi