
Storia
Carlo Levi: non più cose, ma persone
A cinquant’anni dalla scomparsa (4 gennaio 1975) che cosa rimane oggi di Carlo Levi? Si potrebbe dire che rimangono molte cose: la scoperta del Mezzogiorno (non solo Cristo si è fermato a Eboli, ma la scoperta della mafia in un tempo in cui la parola ancora si sussurrava, nel suo Le parole sono pietre); la delusione della sconfitta (il riferimento è alle pagine de L’orologio) il senso di che cosa sia la posibilità del potere totalitario e del possesso delle persone. È il tema che sta al centro di Paura della libertà (ora qui a pp. 132-204) che Levi scrive tra 1939 e 1940, e che a lungo abbiamo letto come lo smarrimento di un momento, ma che forse è tornato ad essere un testo da rileggere nel tempo presente.
A questo primo elemento credo sia importante ricordarne un secondo che sta lugo tutto l’asse della riflessione di Carlo Levi: il giudizio sulla politica. Anche questo secondo aspetto ha a che vedere con il nostro tempo presente.
Comincio dal primo
Le riflessioni di Paura della libertà nascono in uno scenario dove lo Stato è tutto e la libertà dell’individuo è niente. A lungo abbiamo ritenuto che fossero parole per un tempo chiuso, finito. Forse quel tempo si è riaperto.
C’è un aspetto di Paura della libertà che non emerge immediatamente e che merita, invece, di essere sottolineato in un’epoca di apparente disincanto per la dimensione politica pubblica quale quella che noi oggi viviamo.
Nella descrizione del rapporto tra cittadino e Stato – ma più correttamente si potrebbe dire tra potere e suddito – che Levi pone indubitabilmente al centro di quelle sue pagine (qui, pp. 189-198) – si colloca la denunzia di un eccesso della politica proprio sulla base e in forza di una sua spoliazione, ovvero in relazione e in conseguenza di una depoliticizzazione dell’individuo. Non è l’unico paradosso su cui Levi lavora, ma è uno dei tanti ossimori che è bene tenere a mente. È il filo tenue, ma tenace che si consegna a noi, qui e ora.
La paura è un grande tema politico. Noi siamo usciti dal XX secolo ritenendo che il racconto dell’orrore fosse il viatico migliore per costruire cittadini più consapevoli, anzi per fare in modo che uomini e donne divenissero cittadini consapevoli.
Se consideriamo la nostra quotidianità si dovrà rilevare, forse con amarezza, non senza un certo disagio, che l’orrore e la sua narrazione non insegnano nulla. È la paura, invece, questo grande tema barocco su cui si costruisce la dimensione della politica quale noi oggi la conosciamo, che costituisce la macchina generativa del potere. Un potere che proprio mentre denuncia i mali della politica e tenta di accreditarsi attraverso l’offerta di protezione salvifica, riconferma il carattere alienante ed espropriatore della decisione politica.
Non è forse questo il linguaggio che quotidianamente caratterizza il nostro tempo ora? È la paura, il collante che va rimosso per liberare la politica, diversamente per restituire lo scettro al cittadino. Ma anche per invitarlo a divenire cittadino.
Questo percorso apre al secondo tema, quello del rapporto tra cittadino e politica.
C’è nella riflessione amara di Carlo Levi quella che mette in bocca a Andrea (un personaggio che nei tratti somatici e nei lineamenti caratteriali ricalca Leo Valiani) nelle pagine de L’orologio forse il manifesto apparentemente più smaccato della riflessione dell’antipolitica. Sono le pagine in cui Carlo Levi distingue tra Luigini e Contadini.
Nell’immediato dopoguerra l’immagine del “contadino” come uomo concreto, attento al benessere e allo sviluppo e facitore di ricchezze a fronte e in contrapposizione all’uomo urbanizzato, alla figura “cittadina” più vicina a quella del parassita o del dissipatore di ricchezze, su cui per esempio scrive Corrado Alvaro, sembrerebbe assimilare la riflessione di Levi alla retorica di «strapaese».
Sembrerebbe così che la politica, a giudizio di Levi, si manifesti come espressione del grande partito luigino. La politica, pur presentandosi come lo strumento migliore a disposizione di tutti, spesso si capovolge manifestandosi come vittoria della massa passiva, manipolata e interessata.
E tuttavia la dimensione della politica nelle riflessioni di Carlo Levi va anche colta per un altro aspetto su cui a lungo è venuto meditando negli anni del fascismo e che ha le sue prime avvisaglie fin dai suoi scritti giovanili.
All’origine della critica di Levi alla politica non sta infatti il rifiuto della attività politica, ma la convinzione che la politica è soprattutto il risultato di coloro che ne hanno storicamente incarnato la raffigurazione dominante. Il ritratto che egli dipinge di Antonio Salandra nel primo testo che egli scrive per “Rivoluzione liberale” [ora qui a pp. 3-16] è in un qualche modo paradigmatico di un profilo culturale generale che fonda la sua idea di politica.
A proposito della tipologia Salandra Levi osserva che il problema della classe politica è quello della sua pochezza, del suo profilo tutto affaristico, del parvenu in quanto professore che si atteggia tra gli ignoranti.
Antonio Salandra – scrive Levi facendo un ritratto tagliente di una tipologia più che di un individuo concreto, comunque di una tipologia che tornerà più volte nella storia pubblica italiana fino ai nostri giorni – non è superiore ai suoi tempi. Alla generale debolezza egli aggiunge la debolezza sua particolare, non per questo meno interessante. Tra le nostre molte maschere politiche è anche egli maschera dai caratteri comici ben definiti: appare egli il professore saputo tra gli ignoranti, la cattedra tra gli analfabeti, il sapiente tra i privi di senno, il grande teorico tra gli affaristi frettolosi [ora qui a p. 3]
Il tono è quello del giudizio su una classe politica invecchiata, priva di morale, da parte di un individuo che si sente parte di gruppo votato alla necessità del rinnovamento della classe politica. Ma anche consapevole della propria condizione di “esilio interno”.
Il discorso di Andrea su contadini e luigini, da cui siamo partirti con queste considerazioni, va inteso allora come un elogio o, viceversa, come una maledizione della politica? A seconda di come si risponde a questa domanda Carlo Levi potrà apparire uno strenuo difensore della politica o un elogiatore dell’antipolitica.
Personalmente mi sembra più fondata la prima lettura. Su questo aspetto mi sembra ancora coerente la riflessione proposta molti anni fa da Vittorio Foa (leggibile in una raccolta di suo scritti dal titolo Per una storia del movimento operaio, Einaudi, pp. 42-52). Anche allora Foa si poneva questa alternativa e così si rispondeva:
Fin dall’inizio la sua [di Carlo Levi, ndr] esperienza politica è stata paradossale – e per ciò rigorosamente coerente: la lotta è politica quando nega gli strumenti correnti (e tradizionali) della polit6ica stessa, quando nega la delega (del cittadino allo Stato, del lavoratore al padrone, del piccolo paese alla grande potenza) – e quindi gli istituti tipici della lotta politica – quando nega l’intermediazione altrui come regola nei rapporti fra gli uomini; la lotta è politica quando gli uomini stessi che la conducono si educano (singoli oppure fra loro associati) a liberarsi dalla loro stessa paura nei confronti della passione, della libertà, della responsabilità, quando essi imparano a costruirsi i loro propri strumenti di azione (anziché affidarsi agli strumenti altrui) e quindi a riconoscere le loro proprie capacità creative. Poiché oggi la politica (almeno nell’area industrializzata del pianeta) attraversa una profonda crisi (nel doppio significato di declino della sua influenza e di apparizione di nuove virtualità), la critica politica di Levi è una critica attuale. [p. 42]
In quelle pagine di Foa di nuovo tornava la riflessione sui tornesi di Carlo Felice sul rifiuto dello sguardo sulle conseguenze della modernità [ora qui a pp. 30-33] comunque su una città che almeno in una sua parte consistente – e politicamente dominante – espelleva da sé la fonte del suo stesso benessere. Vittorio Foa, opportunamente, vi leggeva anche la persistenza di una visione “antica” della società politica pronta a un’azione paternalistica di conforto, ma decisamente ostile anche attingendo alle sue stesse fonti culturali a cogliere l’opportunità di governare la trasformazione e dunque scoprire l’aspetto altruistico della politica. Una città ancora culturalmente attratta dal paternalismo protettivo di Petitti di Roreto e sorda alle sollecitazioni anche dei propri riformatori, un partito cui potevano iscriversi Cavour, Giolitti e Valletta.
A questo livello si propone la questione dell’autoriforma della politica e del costume della politica a proposito del modello culturale della politica nel costume italiano, per cui anziché essere un inveramento il fascismo si propone come continuità/compimento di quel meccanismo di regolarità secondo quanto scrive levi nel 1932 [ora qui a pp. 52-61]. “Il potere non esiste se non è accettato da chi lo subisce”, commenta Foa [p. 51].
Al fondo dunque la risposta al dominio della politica è ancora politica e si accredita come rottura del vincolo del dominio, magari anche attraverso la risorsa dell’ironia, laddove non sia ancora data una forma cosciente di risposta politica, soprattutto laddove il dominio politico risulti totalmente nullificante nei confronti dell’individuo.




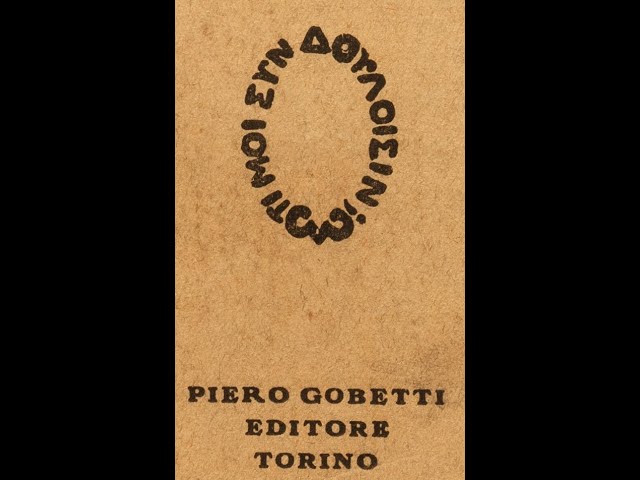
Devi fare login per commentare
Accedi