Musica
Ricordo di Alice e Nikolaus Harnoncourt
Che dolore immenso, inconsolabile, non fosse che le registrazioni su vinile e poi su cd ne abbiano fissato anche fisicamente la memoria, il vuoto che lascia la scomparsa di un grande interprete, anzi di uno che ha rivoluzionato l’idea stessa d’interpretazione, sarebbe incolmabile! Con la scomparsa, infatti, il 20 luglio scorso, di Alice Harnoncourt, moglie di Johann Nicolaus Graf de la Fontaine und d’Harnoncourt-Unverzagt, morto, prima di lei, nel 2016, scompare un mito del ripensamento di come si debba interpretare la musica preclassica, anzi di come si debba impostare qualsiasi tentativo d’interpretare il passato, e non soltanto il passato musicale. Nikolaus e Alice avevano additato al mondo, non solo musicale, ripeto, un nuovo modo di confrontarsi con il passato. Non a caso negli stessi anni in cui la filologia classica, ma anche quella romanza, ripensa il rapporto con la cultura greca e latina, per esempio nella lettura di tracce di altre civiltà nel solco del grande alveo greco-latino, e con la fioritura della poesia moderna europea, in Francia, in Spagna, in Germania, in Italia, quanto per esempio, di quella poesia continua ancora nella poesia di oggi, se non altro nell’individuare la collocazione intellettuale del poeta: ecco quindi che scavalcata la distanza temporale un Bernard de Ventadorn o i Dictats di Ausiàs March ci additano un modo di essere consapevoli dell’oggi e di confrontarsi con la tradizione, magari sbriciolandola. O ristrutturandola, come fa Shakespeare quando assume la forma del sonetto proponendo un nuovo equilibrio tra le strofe. Uomo di profonda cultura, di aristocraticissima famiglia, imparentata addirittura con gli Asburgo, Nikolaus Harnoncourt, e poi sua moglie Alice, hanno riproposto, quindi, problematicamente, come sempre si dive riproporre, il rapporto dell’oggi con il passato. Senza tuttavia cadere nei feticismi di chi crede possibile un recupero integrale di un mondo scomparso da secoli: se non altro i secoli hanno depositato nelle nostre orecchie, nella memoria della nostre orecchie, una più complessa esperienza del suono: ascoltare il violino di Vivaldi o di Bach su strumenti storici ottiene, indubbiamente, la restituzione di un suono verosimilmente simile al suono immaginato da Vivaldi e da Bach, ma proprio per questo ce lo distanzia, ce lo fa apparire quasi esotico, temporalmente esotico. È in qualche modo ciò che accadde agli umanisti quando riscoprirono la voce dei poeti greci e latini, che per secoli fu intesa come voce immutata nel tempo: un romanzo in versi, com’è il Filostrato di Giovanni Boccaccio, ci rappresenta ancora gli eroi della guerra troiana come cavalieri del ciclo arturiano, se non addirittura come personaggi del Decameron. Eppure proprio Boccaccio si pone sul crinale che divide la continuità medievale dallo iato umanistico e rinascimentale. Ecco: di questa inestricabile complessità, che ci avvicina e insieme ci distanzia il passato, Nikolaus Harnoncourt non solo è consapevole, ma ha cercato di districarne l’intrico. Harnoncourt ha mai nascosto, infatti, che il passato, qualunque passato, anche quello di ieri, è sempre comunque letto da un presente che ne deriva, ma che è diverso: si come suona oggi diverso dal nostro il Debussy di un Gieseking o di un Michelangeli, perfetto nella sua cristallina immagine di perfezione, eppure ormai lontano nell’attenuazione, se non addirittura nell’appiattimento, delle incrinature che attraversano la musica di Debussy. E sono passati solo pochi decenni (anche un secolo è un battito di ciglia nella durata millenaria della nostra cultura europea: un conductus di Perotin può accendere il corto circuito che la fa sembrare bartokiano). Allora bisogna intendersi: la fedeltà, la ricerca di prassi esecutive interrotte non è solo il tentativo di restituire una musica come non l’avevamo ascoltata e come, forse – importante il forse – era suonata, e cantata, nell’epoca in cui è stata concepita. Tra l’altro, il problema si poneva non solo per la musica antica. Da Haydn a Beethoven trascorrono circa 80 anni, un secolo se si comincia il computo temporale dalla data di nascita di Haydn. Non è pertanto immaginabile che in quel lungo lasso di tempo – lungo per chi viveva al suo interno, brevissimo per chi oggi lo considera dalla distanza di due secoli – non è pensabile, dico, che la prassi esecutiva rimaneste sempre la stessa dovunque: sia Mozart sia Beethoven esplosero a Vienna come pianisti eccezionali, ma certamente non suonavano allo stesso modo, e non solo perché erano due persone distinte. Il Flauto magico è del 1791, il Fidelio, inscenato come Leonore, già del 1805 e sono due opere profondamente diverse. Eppure sono passati appena 14 anni. Ma è cambiato un intero mondo. E non solo perché c’è stata la deflagrazione della Rivoluzione Francese, e Napoleone ha invaso l’Europa, ma anche per quello. Mozart muore che Robespierre instaura il regime del Terrore, Beethoven assiste, impotente, alla Restaurazione. Anzi, ne prevede già i nefasti bavagli, lui idealmente giacobino, quando Napoleone si fa incoronare Imperatore. La rivoluzione di quei decenni non fu solo politica e militare, ma fu anche culturale. Ecco perché poi gli Harnoncourt, una volta affrontata l’immensa fatica di ripensare la musica barocca, hanno voluto indagare anche la musica dell’Illuminismo e poi – perché no? -anche quella del Romanticismo. Il Concerto in la minore di Schumann diretto da Nikolaus Harnoncourt e al pianoforte una imprevedibile Martha Argerich è sublime, proprio per questa sua imprevedibilità anche emotiva, ed è forse l’interpretazione più schumanniana, mi si perdoni l’ardire dell’affermazione, che si possa ancora oggi ascoltare. Come del resto non conosco Sonata a Kreutzer più beethoveniana di quella che vede insieme come interpreti sempre Martha Argerich, al pianoforte, e Gidon Kremer, al violino. Credo, quindi, che il più grande insegnamento di Harnoncourt sia stato di liberare la mente dal feticcio dello strumento “originale”, dall’idea che bastasse usare uno strumento d’epoca per suonare bene la musica dell’epoca. Un’idea assurda e irreale quanto pensare che basti dare a un giovane diplomato di conservatorio un Bechstein o uno Steinway, perché ci riesca a suonare un Beethoven, uno Chopin, un Brahms impeccabili. Il lavoro da farsi, non è solo strumentale, ma è soprattutto mentale, prima ancora che manuale o ideologicamente “autentico” (Adorno scrive però giustamente che niente è più inautentico che la ricerca dell’autentico). Si tratta, insomma, di appropriarsi di una cultura dalla quale certo deriviamo e dipendiamo ma che è altra dalla nostra. Al solito il problema dell’interpretazione, di qualsiasi interpretazione, richiede prima di tutto non già d’interpretare la pagina, ma la cultura che ha creato le condizioni perché quella pagina fosse scritta. Che si andasse proprio in quegli anni approfondendo l’analisi matematica del mondo (basti pensare a Newton e a Leibniz) non è estraneo alla passione contrappuntistica di un Bach e di uno Handel, o alla ricerca armonica di un Rameau, ma sta anzi a indicare un comune denominatore: l’idea, utopistica quanto si vuole, ma professata, di razionalizzare l’irrazionale, dare forma geometrica al sentimento – agli affetti, si diceva – in una parola di dare senso all’insensatezza del reale. L’Etica di Spinoza da una parte, come l’Arte della fuga dall’altrta, e, soprattutto quel capolavoro d’intelligenza matematica che costruisce un mondo che è il trattato scientifico di Newton, non a caso intitolato Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, scritti, sia l’Ethica spinoziana sia i Principia newtoniani, anche qui non a caso, entrambi in latino, sono i pilastri di questa volontà da capire il mondo, e di capirlo razionalmente, razionalmente anche con la musica. Ed è proprio questa volontà di capire razionalmente l’irrazionale che muove tutta la ricerca interpretativa di Harnoncourt. Certo, se si hanno gli strumenti dell’epoca o costruiti come erano costruiti nell’epoca, il suono è probabilmente più vicino al suono immaginato dal compositore, ma se poi, come si è detto, lo strumento d’epoca capita nelle mani di un incompetente che lo suona male o non si conoscono gli elementi fondamentali della prassi esecutiva, e prima ancora, non si conoscono i fondamenti culturali che costruiscono gli elementi della prassi esecutiva, siamo davvero fuori strada. Oggi è di moda pensare che tutti possano, anzi debbano capire tutto, che l’arte è democratica, e quindi una musica che non tocca la sensibilità di tutti gli ascoltatori non è vera musica, non è democratica. Ma chi l’ha detto che l’arte è democratica? Che la musica è musica per tutti? Couperin è democratico? Lo capiscono subito tutti al primo impatto? Se non conosco la cultura che ha permesso Couperin non conosco Couperin. Democratico non è l’impatto, ma che tutti, informandosi, studiando, possano avere l’impatto che la musica di Couperin richiede. Sta qui il nodo dell’insegnamento di Harnoncourt: l’informazione, lo studio, la disciplina. E si deve a lui se ormai giustamente l’interpretazione della musica antica non si chiama più “filologica” (la filologia ricostruisce i testi, non la prassi esecutiva), ma si chiama interpretazione “storicamente informata”. L’uso di strumenti originali o costruiti secondo i modelli d’epoca è solo uno dei presupposti per impostare una interpretazione storicamente informata. Insufficiente a realizzarla se è l’unico presupposto. Ma ecco, allora, che se invece si conoscono questi elementi, questi presupposti, e si sanno adoperare, la musica antica si può suonare anche con strumenti moderni. Harnoncourt ha insegnato, pazientemente, a molte orchestre “tradizionali” a suonare la musica del Settecento in maniera più appropriata, più pertinente, a non suonare Handel come se fosse Mozart, a non suonare Mozart come se fosse già Schubert. Con risultati splendidi. Indimenticabili. Ma questo fatto spiega anche un altro aspetto dell’interpretazione. Non basta, infatti, si è detto, suonare Bach sul clavicembalo per essere sicuri di suonare veramente Bach. Bisogna capire perché Bach scrive in un modo e non in un altro. Ci sono pianisti che penetrano per esempio la libertà di fraseggio bachiana assai meglio di certi rigidi e metronomici clavicembalisti. Ma peggio ancora fanno, d’altra parte, certi pianisti che s’illudono di suonare Bach se riducono le possibilità del pianoforte in modo da farlo assomigliare a un clavicembalo: si azzera la dinamica, si rinuncia alla flessibilità del fraseggio, e si attua una scansione noiosamente metronomica, si applica una digitazione fastidiosamente percussiva. Non è Bach, questo, ma è la caricatura di Bach. Non si allude al clavicembalo, come ci si propone, ma si strapazza, anzi si castra un pianoforte senza farlo per questo sembrare un clavicembalo. Se decido, infatti, di suonare Bach o Scarlatti o Rameau, sul pianoforte, che pianoforte sia. Il pianoforte ha un ventaglio dinamico assai ampio, il tocco può modificare il suono, possiede i pedali per esaltare gli armonici o per attutirli. Non sono pratiche ignote ai musicisti antichi e barocchi. Il violino e tutti gli strumenti ad arco, per esempio, possiedono anch’essi un ventaglio dinamico amplissimo, li possiede la voce umana. Il piano e forte non è un’esclusiva dello strumento di Cristofori. Ovvio, però, che non debba essere, quando si suona Bach o Rameau, non dico un pianoforte romantico, ma nemmeno un pianoforte classico, alla Haydn, o alla Mozart. Anzi, suonare la musica del settecento destinata al clavicembalo sul pianoforte può regalare perfino delle vere e proprie illuminazioni. Per esempio l’Allemanda della quarta partita di Bach acquista un carattere stranamente familiare, e ci si accorge alla fine che vi sta racchiuso il nucleo del pensiero musicale di uno Schumann. Cioè, per chiarirci, non è Bach che prefigura Schumann, ma Schumann che ne trae ispirazione, Schumann, del resto, probabilmente, Bach lo suonava così. E forse anche Chopin. Naturalmente, per apprezzarlo, bisogna liberarsi dal feticcio della riproduzione fedele – impossibile, del resto, l’orecchio di oggi non è quello del 700, pertanto ogni restituzione è sempre ipotetica. Ma non bisogna nemmeno trascurare la storia dell’interpretazione, storcere il naso all’ascolto delle interpretazioni del passato. Chi sa che cosa diranno, infatti, delle nostre interpretazioni tra un secolo! Non storciamo dunque il naso per come un Edwin Fischer suonava Bach. Oggi, certo, non si suonerebbe più così. Ma allora questo era Bach, per l’orecchio di un secolo fa. Ma – va ribadito – d’altra parte, il ricorso a strumenti d’epoca o agli strumenti previsti dal compositore è un’esperienza fondamentale, ineliminabile, dell’interpretazione musicale di oggi. È anzi una vera e propria esperienza intellettuale, oltre che emotiva, un’esperienza decisiva per capire la molteplicità dei mondi musicali possibili, nessuno nemico dell’altro, alternativo dell’altro, ma complementari, come era probabilmente anche nel passato. Non è che a Parigi si suonasse come a Berlino o come a Venezia. Ma i musicisti di Parigi, di Berlino e di Venezia s’incontravano e si scambiavano le idee interpretative. Così Bach e Handel sono entrambi tedeschi, ma non credo che suonassero allo stesso modo. È ciò che si perde in un’esecuzione piatta, monotona, su strumento originale: l’individualità dell’interpretazione. Un Bach certo non era Chopin, ma sentiva, si emozionava, anche musicalmente, come sentirà, come si emozionerà Chopin. Perfino nel melodramma ottocentesco italiano c’è molto da ripensare, da riformulare. Nella scena della pazzia della Lucia di Lammermoor, per esempio, è generalmente adoperato come strumento solista un flauto. Ma Donizetti non aveva previsto un flauto, bensì una glassarmonica. Il suono gelido, astrale dello strumento acquista una funzione drammaturgica rilevante di estraniamento. Il flauto sostituiva la glassarmonica nei teatri che non ne avevano una a disposizione. C’era molta libertà, insomma, nello scambiare gli strumenti, a seconda delle esigenze di un teatro o di una sala da concerto, o della “camera” di un palazzo nobiliare: una sonata per violino e basso poteva essere suonata anche dal flauto o dall’oboe; non dobbiamo dunque scandalizzarci, fare inopportunamente i puristi, se sentiamo Bach suonato sul pianoforte, invece che sul clavicembalo: diciamo che è una libertà che la cultura del settecento barocco prevedeva, la scelta ad libitum dello strumento. Ed è una bufala che Bach detestasse i primi pianoforti. Detestava quelli di Cristofori. Ma quando a Berlino ascoltò quelli di Silbermann, se ne fece venire quattro a casa, a Lipsia. Da parte mia, c’è un solo tipo di composizione per il quale la sostituzione del clavicembalo con il pianoforte mi disturba. Ed è quando lo strumento a tastiera non è solo, ma prevede la collaborazione di un altro strumento o di più strumenti. Le sonate per clavicembalo e violino di Bach – e la precedenza data nel titolo al clavicembalo è significativa – mi suonano distorte se il clavicembalo è sostituito da un pianoforte: l’equilibrio sonoro degli strumenti è stravolto. Ciò vale non solo per Bach, anche se Bach attribuisce al clavicembalo un ruolo di protagonista che gli altri compositori non conducono a un tale livello d’indipendenza. Lo stesso disagio, infatti, mi accade di provarlo per le sonate a tre, di qualunque compositore, se la tastiera è un pianoforte. Quei meravigliosi capolavori che sono i quattro libri di sonate a tre di Corelli mi appaiono sfigurati se il clavicembalo è sostituito da un pianoforte. La causa della percezione di una distorsione sonora è sempre lo squilibrio sonoro che si viene a formare tra gli strumenti.
Nikolaus Harnoncourt
Tutto ciò premesso, Liszt diceva che ci sono musicisti che si ammirano e musicisti che si amano: Harnoncourt, anzi gli Harnoncourt, io li amavo, e li amo, come si può amare un Radu Lupu, uno Sviatoslav Richter, un Kirill Petrovič Kondrašin. Anche quando sbagliano. Per esempio, nel tentativo di restituirci Monteverdi, Harnoncourt non compie l’ultimo passo, che è quello della dizione espressiva della poesia italiana rinascimentale e barocca. Monteverdi non sovrappone quasi mai una melodia al testo, ma estrae sempre la melodia dal testo, e se dunque la dizione italiana è approssimativa o sbagliata, risulta approssimativa o sbagliata anche la melodia. L cose non cambianoquando il testo è in latino. Un esempio, tra tanti possibili. Puramente indicativo, non mi riferisco a nessun luogo preciso i particolare. Il confronto tra la partitura e l’esecuzione avrebbe richiesto maggior tempo di quello offertomi dal tempo di scrittura di queste riflessioni. Si faccia dunque la tara sulla genericità delle osservazioni. Talora Monteverdi su una parola piana, che so, la parola “dolore”, fa cadere la cadenza della melodia (il gioco di parole è voluto): per esempio, mi re, nel primo modo. Harnoncourt, o piuttosto gli interpreti vocali messi in campo. fa cadere l’accento sull’ultima sillaba di dolore, perché la seconda o intona il mi e la e il re: si ascolta, perciò, un orripilante “doloré”. La parola, invece, deve mantenere l’accento grammaticale italiano sulla seconda o: dolòre. Gli accenti melodici sono infatti dettati dagli accenti grammaticali e non dalla percezione moderna dell’andamento melodico. Tra l’altro la differenza di accentazione tra musica e testo funziona in questo caso come una dissonanza. Ma in realtà per Monteverdi non c’è una vera differenza, perché a dettare gli accenti della melodia, come si è detto, sono gli accenti delle parole. Certo che è difficile. Ma quale musica non lo è? e, soprattutto, quale musica non è complessa? Eppure per la Messaggera, nell’Orfeo, Harnoncourt usa niente meno che la voce, splendida, di Cathy Berberian, addestratissima a dire e cantare ogni lingua. Ma qui sembra dimenticare la lezione che tuttavia, al clavicembalo lo stesso Harnoncourt, ci regala con l’interpretazione della lettera amorosa:
In margine, anzi, a proposito del rapporto tra lingua e musica, si potrebbe quasi individuare un certo influsso della lingua natale sulla musica dei musicisti. Il fraseggiare dei compositori francesi sembra ubbidire a una segreta prosodia della lingua francese, che non è come molti pensano, una lingua che colloca l’accento sulla sillaba finale delle parole, ma ha anche parole con una sillaba finale muta – come nel napoletano!! o nell’inglese – e l’accento principale non è quello della singola parola, come in italiano o in tedesco, ma quello dell’intera frase. Da qui il respiro lungo, ampio, meraviglioso del melodizzare francese, da Machaut al divino Rameau o a Charpentier, a Berlioz, a Fauré, a Debussy. All’origine, e qui cade una lezione di Bruno Walter, la musica va pensata sempre come canto. E il canto ubbidisce ai respiri: se lo ficchino in testa certi dattilografici pianisti che anche la musica strumentale respira!





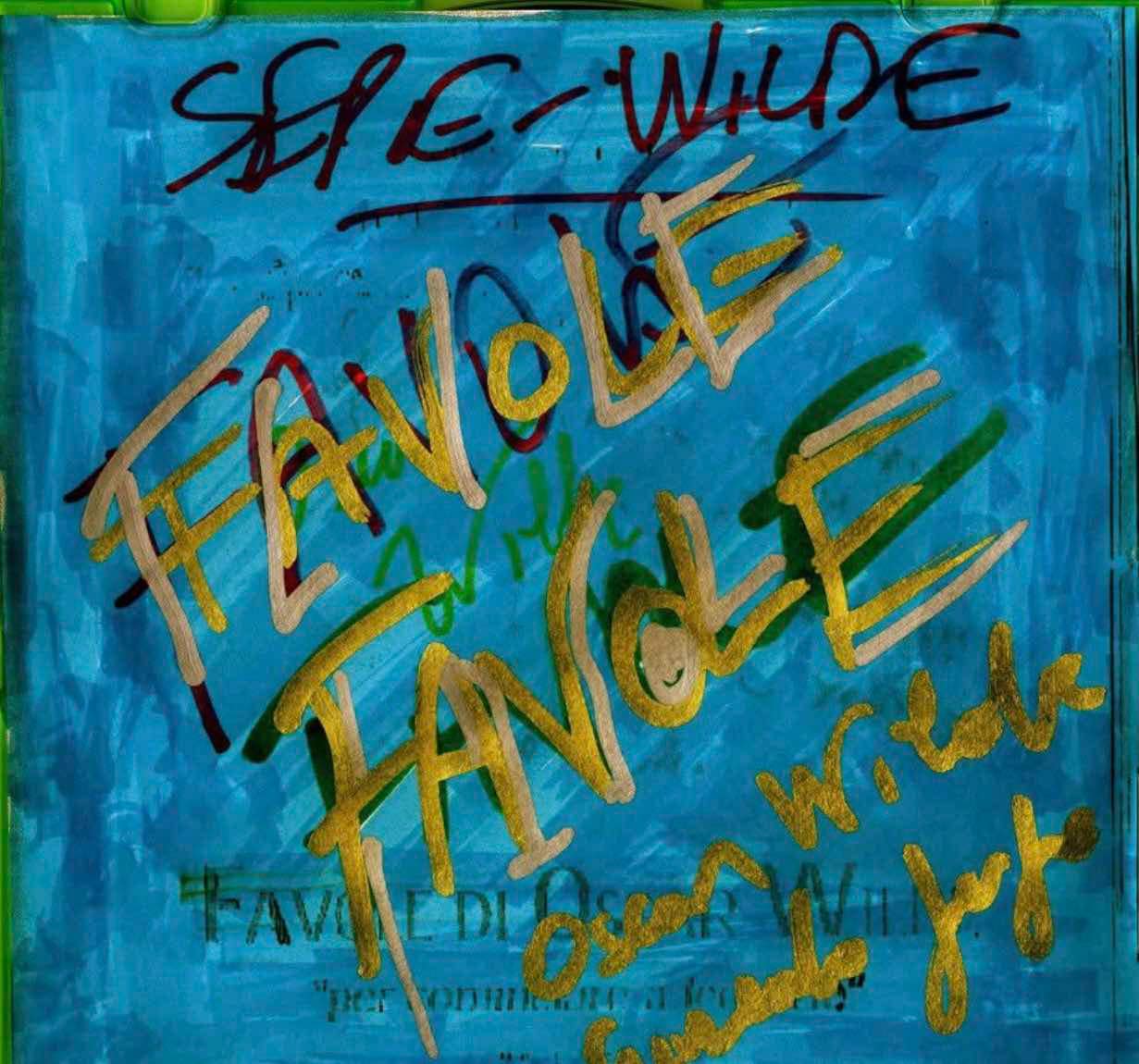
Devi fare login per commentare
Accedi