
Musica
La sfida della Nuova Musica
Scrive Gabrio Taglietti, presentando il suo pezzo: “Mi domando spesso se e quanto sia ancora valido quel tacito patto che da secoli lega compositori, interpreti e ascoltatori: incontrarsi per proporre, suonare, ascoltare musica nuova, disponibili a lasciarsi interrogare dal silenzio dei suoni. E il compositore è ancora in grado di parlare al mondo con voce autorevole, capace di mettere in crisi false certezze e comode abitudini?” Parole che toccano il nodo del fare musica, oggi, quando fare musica significa allacciarsi a una tradizione che da sempre è la minoranza di chi fa musica, e forse già quando Vitry teorizzava l’Ars Nova, una sorta di anteprima di tutte le avanguardie, in Europa erano sì e no cento musicisti che lo seguirono. Ma oggi, in un epoca nella quale è attuato un globale livellamento di qualunque forma di comunicazione – e la musica è comunicazione, nasce come comunicazione (se sia anche linguaggio è un altro discorso: non lo è, e ci sono valide argomentazioni per sostenerlo, o lo è solo per metafora, come per metafotra ne scrivono Agostino, Boezio, Oddone di Cluny, Jacopo di Liegi, Francone di Colonia, Giovanni di Garlandia). Ma nella sua icasticità è perfetto Leibniz, non a caso oltre che filosofo, anche, o soprattutto, matematico. “Musica est exercitium aritmeticae occultum nescientis se numerare animi”. La musica è un eserizio nascosto di aritmetica di un animo che ignora di stare facendo calcoli. Amplificazione e precisazione della definizione agostiniana che la musica sia una “scientia bene modulandi”, una scionza/arte di modulare bene. Ma la differenza tra gli antichi, i teorici medievali, la speculazione illuministica e noi è che oggi a nessuno interessa veramente – tranne forse che ai compositori – la giustezza di una modulazione, mentre ciò che anche nella musica, come in tutto il resto, e dappertutto allo stesso modo, ciò che si cerca è un messaggio, preferebilmente interpretabile con immediatezza, con la facilità e la semplicità di uno slogan. Ora, che messaggio propone oggi una musica che già all’ascolto per molti appare non sempre come musica e in ogni caso indecifrabile? Ambiziosamente la serie di concerti del festival attuale di Nuova Consonanza si propone di smentire questa indecifrabilità: il messaggio è addirittura esplicitato nel titolo della rassegna: Politiké, musica per il domani. Una maniera più gentile di riproporre il modello novecentesco di musica impegnata. Che lo era in due modi, non sempre convergenti: o formale o politico. In Luigi Nono, per esempio, l’impegno della sfida politica si sposava con quello di una ricerca formale radicale.
Il radicalismo politico non poteva essere espresso che da un radicalismo formale. E fu, anche aspramente, criticato proprio questo impossibile – a dire dei più – matrimonio. Che invece, proprio in Nono, un senso lo aveva, e lo significava. Taglietti scrive per il 15° goal – traguardo – di 17 propositi indicati dall’ONU come linee per lo “sviluppo sostenibile”. Due compositrici, Rossella Spinosa (Affordable Energy) e Gaia Aloisi (For all, sconfiggere la fame), e 15 compositori, Marco Taralli (Onus nostra virtus nostra erit, partnership per gli obiettivi), Marco Quagliarini (… en passant, pace, giustizia), Gabrio Taglietti (Life on Land), Federico Gon (La vita negli oceani, la vita sott’acqua), Piero Niro (Without change, cambiamento climatico), Matteo Tundo (Diatomee, consumo e produzione rponsabili), Michele Sanna (Sustainable Cities (just words in the wind), Fabrizio Festa (Disuguaglianze), Lorenzo Marino (Towards resilient innovations, imprese, innovazione, infrastrutture), Daniele Corsi (Decent work and economic growth), Fabrizio Rossi Re (Acqua pulita (Clean water)), Claudio Perugini (Breaking news for Goal 5, parità di genere), Antonio Bellandi (A tought arising, Umaberto Pedraglio (S I L (salvation in love), salute e benessere), Giorgio Colombo Taccani (No Poverty), costruiscono una sorta di sinfonia o, meglio, di suite in 17 quadri. Non che, pur nel campo di una certa affinità, le musiche si asomiglino, ma tutte cercando di intraprendere una nuovva via che non sia la continuazione sterile e accademica delle avanguardie noveentesche, ma nemmeno la restaurazione di moduli armoni ormai logorati, che appartengano o a una rinnovata modulazione tonale o a tic espressivi, formule ripetitive che hanno eaurito la loro carica propulsiva. Ma ciononostante che cosa comunica al pubblico di oggi una simile musica? La scommessa di Nuova Consonanza è coraggiosa, ma c’è chi oggi voglia giocarla? Una riflessione s’impone, prima di tutto linguistica, perché possiamo capirci tra musicisti, ma anche tra musicisti e non musicisti.
Temo, infatti, che si continui ancora a mescolare cose non mescolabili. A confondere musica e comunicazione, così come nella poesia italiana di oggi si confonde poesia e significato. Certo che fa piacere sentirsi applauditi da un pubblico numeroso ed entusiasta. Ma chi non lo trova questo pubblico? è sempre colpa del pubblico o di una musica che non sa comunicare ciò che vuole comunicare? Con questo criterio uno Schubert sarebbe un compositore fallito. Non ci fosse stato uno Schumann a spiegare – proprio così: a spiegare – la grandezza del sinfonista, l’innovazione del compositoe di musica da camera, chi sa, Schubert avrebbe aspettato forse addirittura il novecento a essere compreso, o quanto meno un Bruckner e un Brahms che ne penetrassero il segreto costruttivo. Non è certo la quantità di consenso che fa grande una musica. Ma nemmeno la danneggia. Il successo strepitoso del suo contemporaneo Rossini non voleva mica dire che la musica di Rossini fosse mediocre. Ecco, oggi, invece, mi pare che i compositori rimpiangano e lamentino la mancanza di corrispondenza tra la loro opera e un pubblico che voglia ascoltarla, anzi più: che la senta propria, come quella dell’ultimo rapper o della rockstar che riempiono gli stadi. Tipica, una simile aspettativa, di una società che ambisce livellare ogni livello di comunicazione, dalla facile e seduttiva muzak di un supermercato o di un centro commerciale al quartetto classico rivisitato. Invece la diversità, la differenziazione dei livelli di comunicazione è necessaria proprio a preservare la qualità dei livelli più alti – alti non perché migliori, tutti i livelli sono necessari, ma perché si propongono scopi diversi dal solo intrattenimento – Debussy non deve piacere alle folle, ma nemmeno il musicista solitario e sperimentale deve storcere il naso o strapparsi le vesti perché una canzonetta senza ritmo né melodia, ma azzeccatissima nel cogliere ciò che chiede la massa, ottenga un plauso plebiscitario. Piaccia o no, sono queste le regole di una società di massa. E se non ce ne siamo accorti, anche l’Italia è ormai diventata una società di massa. Allora, che fine fa la definizione di Leibniz? È valida anche per la canzonetta che piace a tutti. Che, anche se qualcuno pensa il contrario, è difficile comporla come un quartetto visionario e inudito – inudito, non inaudito. Perfino per un’Intelligenza Artificiale: le crepe della mancanza d’invenzione, infatti, saltano sempre fuori, anche per la più furba, per la più sofisticata. Allo stesso modo come un notturno di Field non riuscirà mai a essere un notturno di Chopin (basterebbe l’elaborazione contrapuntistica dell’ “accompagnamento” armonico, tipica della scrittura chopiniana, a distinguerli). “Bene modulandi” scrive Agostino. “Exercitium aritmeticae” Leibniz. E resta tale sia il quertetto sia la canzonetta. Ma, allora, che cosa li distingue, e perché entrambi, la canzonetta e il quarteto, sono necessari? Perché rispondono a diverse esigenze, soddisfano diverse richieste. Non esiste un criterio unico del bello o, se questa parola disturba, dell’oggetto ben fatto, riuscito. A una automobile utiltaria non chiederò le prestazioni di una macchina sportiva. Perché dovrei dunque uguagliare l’ascolto di un quartetto e quello di una canzonetta? Ma attenzione!
La differenza di livello non implica una differenza di qualtà, di valore. È vizio tradizionale degli italiani giudicare come differenza di valore la differenza di genere. Accade ancora per le donne, pagate meno degli uomini anche quando compiono gli stessi lavori. Sono dati degli ultimi accertamenti ISTAT. Così l’operetta, per gli italiani, non potrà mai toccare i vertici dell’opera, fosse pure il Pipistrello di Strauss. E una canzone di Luigi Tenco non è un Lied di Schubert. Curioso che in francese, tedesco, inglese, spagnolo si chiamino canzone entrambi: chanson, Lied, song, canción. Sia Britten che i Beatles, sia Falla che Iglesias, sia Ravel che Brassens, sia Schubert che Marlene Dietrich. Ora, assolvono a questo compito di comunicare l’oggi, le esigenze, le attese dell’oggi, le musiche che si sono ascoltate al concerto inaugurale del Festival di Nuova Consonanza? Certo che sì, ma in maniera contraddittoria. Da una parte, a chi questa sperimentazione musicale è familiare, dicono in modo musicale proprio ciò che le parole vogliodo comunicare. E bravissimi i musicisti del New Made Ensemble (Birgit Nolte flauto, Edoardo Lega clarinetto, Enzo Filippetti sassofono, Andrea Stringhetti violoncello, Elisa Netzer arpa) diretti da Alessandro Calcagnile a far trasparire i complessi intrecci delle loro parti, le combinazioni calcolatissime di timbri. Così come i due attori usciti dall’Accademia Silvio D’Amico, Stefano Poeta e Alessandro Pocek, a dire – e non a recitare, dire, bravissimi! – e il soprano Arianna Lanci, a cantare, interpretare, i testi. Una breve dissertazione sul fatto che si voglia o no, qualunque cosa si faccia, e dunque anche i musicisti, si è sempre cittadini, di Guido Barbieri, letta dagli attori introduceva il concerto. Il pubblico, numeroso, nel Teatro Studio Gianni Bogna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, ha seguito con intensa partecipazione il concerto, applaudendo la fine di ogni pezzo – e chi sa che invece un ascolto di tutti i brani non interrotto dagli applausi non avrebbe fatto cogliere meglio il senso del messaggio musicale – e rimanendo, dopo la fine, a salutare tutti i compositori e gli interpreti. Ma qualcosa come d’inattuato, d’inesplicato, resta, quando si esce dalla sala.
Intanto, presi alla lettera, i “goal” che l’ONU vorrebbe vedere raggiunti entro il 2030, cioè fra meno di sei anni, temo che siano poco più di una generosa speranza. Meno male comunque che anche i musicisti se ne augurino il compimento. Ma soprattutto, la domanda di Taglietti, provocatoria, ma quanto mai indispensabile, reale, resta senza risposta. E chi sa che una risposta non ci sia. In fondo, deposto l’ultimo Imperatore Romano fantoccio, Romolo Augustolo, in Occidente, per mille anni la cultura è andata da una parte, si è chiusa nei monasteri o in qualche corte ducale, principesca, perfino regale, con Carlo Magno, ma il popolo è vissuto sviluppandone un’altra, che non ci è arrivata o ci è arrivata per testimonianze terze, fino alla cosiddetta rinascita che ancora oggi chiamiamo Rinascimento. Una visione della storia tutt’altro che fedele a quanto è realmente avvenuto, basterebbe pensare all’esplosione culturale della Francia da Carlo Magno in poi e, soprattutto, nei secoli XI-XIV, Francia che già da quel punto si pone come modello di tutta l’Europa. Ma in ogni caso una rinascita, francese o italiana che fosse, che di nuovo non riguardava il popolo. E non lo riguarda almeno fino al 14 luglio 1789. Qualche anno prima negli USA. Tuttavia, ancora nel 1915, quando l’Italia entra in guerra, dei soldati che vanno al fronte 9 su dieci firmano con una croce. A quale pubblico, dunque, a quale popolo, si rivolgeva la musica degli Schoenberg, dei Debussy, e dello stesso Puccini? E oggi, che piaccia o no, la musica che da loro deriva, a chi si rivolge? La domanda di Taglietti c’interroga proprio su questo. E, credo, nemmeno una sfera magica, di nessuna maga, ha oggi una risposta, o prevede che se ne possa dare una.
Questa, però, è la comunicazione. Ma la musica, la poesia sono solo comunicazione? O qualcosa d’altro che addirittura mette in discussione la stessa comunicazione? Émile Benveniste negli appunti per un libro su Baudelaire sostiene che Baudelaire non vuole “vedere” il mondo, vuole stringerlo, possederlo. Il che è il gesto dei solitari. E per ottenere questa stretta, questo possesso, “a differenza del linguaggio ordinario”, il suo, che è invece un “linguaggio poetico” fa “vedere le cose facendo vedere sé stesso”. La cosa, nella poesia, è il linguaggio stesso. Non la sua descrizione o rappresentazione. Come se, nella poesia, il linguaggio recuperasse l’atto originario con cui Adamo nomina le cose. “il poeta è un uomo che fa uno sforzo disperato per attingere e comunicare la realtà stessa delle cose”. Non la loro apparenza. Walter Benjamin, anche lui. come Benveniste, negli appunti per un libro su Baudelaire mai terminato, dice le stesse cose, e, in aggiunta, che proprio perché il linguaggio si fa protagonista della comunicazione, Baudelaire ne annuncia la crisi in una società in cui predominante non è la prouzione del singolo, bensì dell’industria. Più pervasiva di altre, l’industria culturale.
Ecco perché il singolo, a difendersi dall’omologazione di massa, non possiede altra arma che ridiscutere il linguaggio della comunicazione, smontare a pezzo a pezzo il linguaggio quotidiano, il linguaggio dell’abitudine, il linguaggio immediatamente comprensibile, che non fa domande, non pone problemi, impone oggetti, per obbligare invece a riflettere su un linguaggio che a essere compreso richiede sforzo, fa riflettere sul significato, interroga sul suo uso, un linguaggio che il singolo, l’artista, inventa da capo insieme all’ascoltatore, ma chiedendogli la collaborazione di fare lo stesso sforzo inventivo, di seguirlo nella costruzione di uno strukento nuovo della comunicazione, per una comunicazione che non sia piatta accettazione dell’esistente. La musica non è linguaggio. Ma è costruzione di modelli uditivi. E la nuova musica, se vuole davvero toccare la realtà, proporre modelli che corripondano alla realtà e non siano invece copia rassicurante di reltà passate o finite, o comunque abituali, deve obbligare l’ascoltatore a compiere lo stesso sforzo inventivo che fa il compositore. È uno che rema contro, che non segue la corrente. Quando anche il pubblico gli chiede invece di seguirla, la corrente che trascina tutti, così che non ci pensa, si abbandona all’ascolto e gode, bisognerebbe avere il coraggio di negargli ciò che chiede. Il musicista non dovrebbe volere che l’ascoltatore goda l’abbraccio di un fantoccio che si logora presto, e sarà presto sostituito da un nuovo fantoccio, che lo abbraccerà più stretto, gli toglierà il respiro, e lo farà sentire felice di perdere il respiro.
La nuova musica, al contrario, vuole ricostituire il respiro che respira con la musica, ricondurre l’ascoltatore a sentire una musica come se l’ascoltasse per la prima volta, e ne riscoprisse di nuovo la forza d’inebriare, il fascino della scoperta di qualcosa che non c’era. Questa comunicazione che rigenera la costruzione dell’oggetto musicale, fa penetrare all’ascoltatore per quali vie possa costruirsi e rivelargli ciò che prima non conosceva, questa capacità di attrarre l’intelligenza oltre che il sentimento, è ancora possibile? Ne abbiamo udita, l’altra sera, almeno una predisposizione? Non lo so. Talora mi sembrava che sì, talora che no. Il messaggio è ancora troppo costringente, prevale sulla costruzione del messaggio. Ancora troppo simile a uno slogan. O a una promessa. Nietzsche lo aveva previsto. E ci sfida. Ma non abbiamo ancora risposto alla sua richiesta, alla sua sfida.
“Si è artisti solo al prezzo di sentire ciò che tutti i non artisti chiamano “forma” come contenuto, come ‘la cosa stessa’. Con ciò ci si ritrova certo in un mondo capovolto: perché ormai il contenuto diventa qualcosa di meramente formale – compresa la nostra vita”.
Nietzsche, Frammenti Postumi Novembre 1887 – Marzo 1888, 11, 3, Nizza 14 novembre 1887. Traduzione di Sossio Giametta, Milano, Adelphi, 1970.
E si badi: “compresa la nostra vita”. Ma qui si aprirebbe un lungo discorso sulla disposizione a rischiarla degli artisti italiani. La nostra tradizione, salvo casi eccezionali, come Dante, Michelangelo, Caravaggio, Verdi, Pasolini, Nono, l’arte italiana cerca un equilibrio, un’equidistanza tra la follia e la ragione, cerca l’ordine, l ‘armonia, come bene intuisce Benedetto Croce nel saggio sull’Ariosto. Esperienze estreme come l’espressionismo ci sono estranee, tutt’al più si cerca l’effetto realistico, truculento, che suscita l’applauso. Rappresentare il disordine non ci appartiene, sembra. I brani ascoltati nel concerto inaugurale del festival di Nuova Consonanza non smentiscono questa tradizione. Evitano, giustamente, gli eccessi delle avanguardie, ma non osano proporre nuovi gesti di rottura, nuove esasperazioni, che pure, forse, i “goal” avrebbero preteso. E finiscono pertanto con assomigliarsi tutti, scorrendo sui binari della moderazione. È qualcosa di più di un’impressione. Sembra anzi lo specchio musicale di un ritorno all’ordine al quale oggi sembra aspirare tutto il paese. Come se i venti di guerra, le trasformazioni brutali che sconvolgono il mondo non lo toccassero. L’aiuola che ci fa tanto feroci non deve essere scomposta, che resti un’aiuola, che fioriscano le rose. Se la Romagna e, peggio ancora, la Comunità di Valenzia sono devastate da catastrofiche alluvioni, e via! poi si ricostruisce tutto e si torna a vivere come prima.





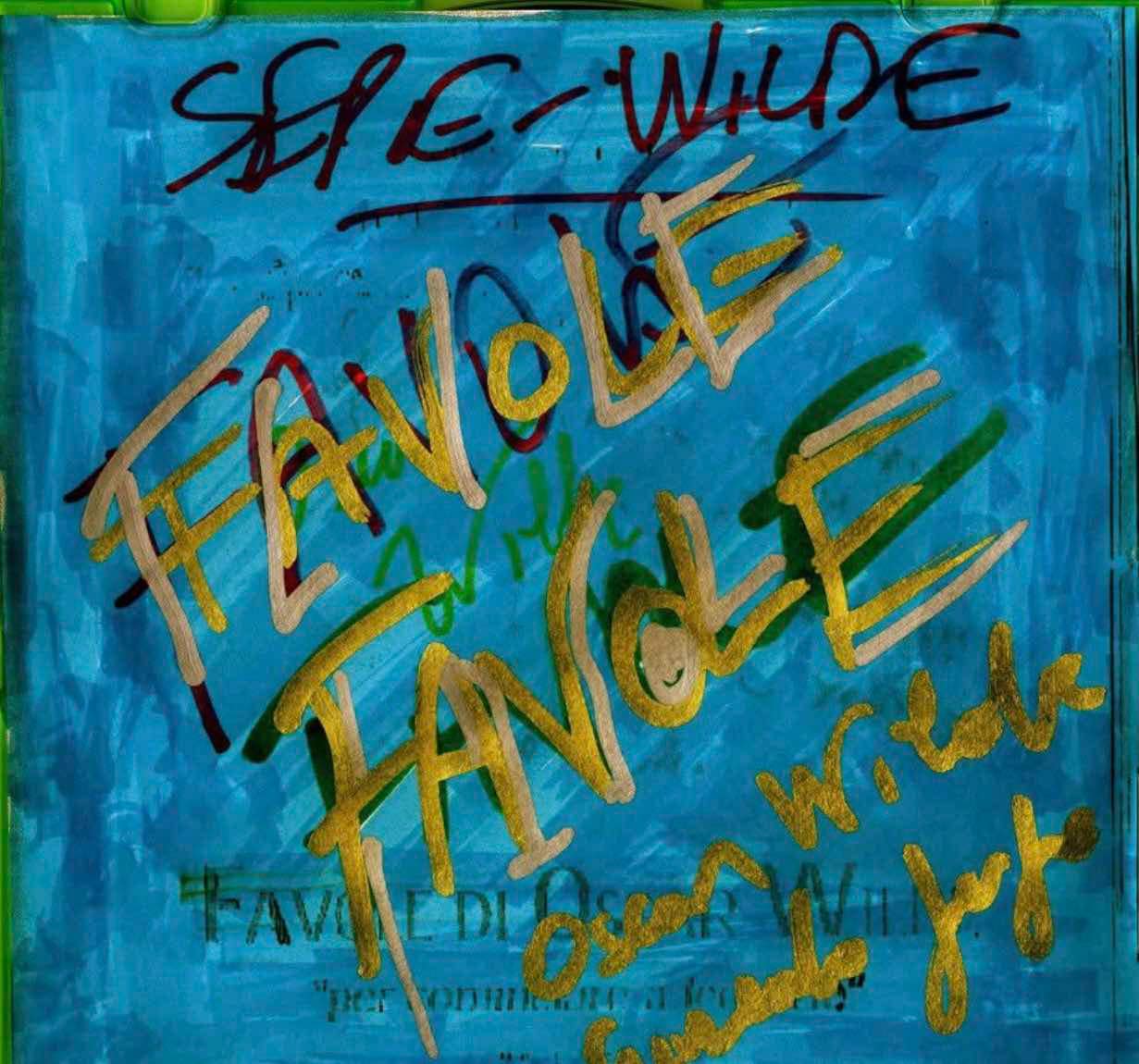


Devi fare login per commentare
Accedi