Musica
Di quale passato e di quale futuro vogliamo essere il presente?
Cento anni fa Alfredo Casella fondava la Società Italiana di Musica Contemporanea, SIMC e l’attuale presidente, Andrea Talmelli, ha perciò voluto celebrare il centenario con un convegno tenutosi a Firenze nei giorni 9 e 10 settembre scorsi, dal titolo La musica contemporanea tra presente e futuro. Numerosa la partecipazione di compositori, e appassionati della musica di oggi, o del “presente”, come a qualcuno è piaciuto chiamarla. Poiché anche io vi ho partecipato, non mi è parso corretto stendere una cronaca e una critica dell’avvenimento, e perciò qui non voglio fare un vero resoconto delle giornate, ma mi limito solo a riflettere su alcuni punti, quelli che mi sono sembrati l’oggetto principale della riflessione, anzi della preoccupazione, di molti.
Alessandro Melchiorre, nella sua relazione, dal titolo Ritorno al moderno, ha posto subito la domanda: di quale passato e di quale futuro vogliamo essere il presente? Probabile che il rigore utopistico ed esclusivo delle avanguardie del secondo novecento sia oggi impraticabile, almeno con il senso identitario esclusivo che lo contraddistingueva. Il primo novecento c’indirizzava invece verso una più complessa complementarietà delle sperimentazioni, molteplici le direzioni teoriche e pratiche, che a molti, allora, apparvero opposte, e a noi oggi paiono invece complementari. Soprattutto la situazione attuale, non solo della musica, sembra chiederci ancora di realizzare una mai avvenuta convergenza tra il lavoro intellettuale del compositore, dello scrittore, del poeta, del teatrante e le relazioni individuali e collettive di una società che non è più distintamente divisa in gruppi d’interesse culturale chiusi e definiti, ma scivola tra un consumo e l’altro di ogni genere musicale, dall’esercizio di nicchia alla muzak che rompe tutti i possibili spazi di silenzio dei più diversi luoghi pubblici, dalla stazione ferroviaria e dagli aeroporti al bar di quartiere, dal grande magazzino al negozietto della merciaia di un borgo, così come è diventato difficile distinguere uno slogn pubblicitario da una poesia di kitchen poetry o un romanzo di ricerca da un poliziesco o addirittura da un romanzo d’evasione. In una società liquida, com’è stato detto, è liquido anche il consumo culturale.
In quest’ambito le polemiche tra chi difende un’avanguardia ormai sterile o che in ogni caso ha del tutto perduto la sua carica provocatoria e aggressiva, e chi le contrappone, per compenso, un ritorno a pratiche sorpassate, è sterile quanto la musica che vorrebbero proporre come adeguata all’oggi. Ha ragione Stefano Taglietti quando fa osservare che non esiste più un solo modo di fare musica, alto, e altri, meno nobili, che attraggono l’adesione della maggioranza degli ascoltatori. Esistono diversi tipi di scrittura musicale, anzi la stessa registrazione in studio è anch’essa un tipo di scrittura. Come lo è la pratica dell’improvvisazione. Il punto è conoscere in che ambito si sta attuando e a chi ci si rivolge.
Ma il problema non è solo strettamente musicale, sembra, se come suggerisce Andrea Mannucci, il lavoro del compositore appare ancora staccato dalla vita sociale della collettività, ha smesso di essere un’istituzione, non importa se nobile o servile, comunque non è più sentito come un’attività inserita nel contesto sociale. La crisi della figura del compositore non è certo solo italiana, ma in Italia è più grave, più isolante, mortificante, umiliante. Come mai ai Proms di Londra, in ogni concerto si può ascoltare una musica nuova che il pubblico gradisce e applaude, e a un concerto di musica contemporanea italiano salvo le occasioni di festival e soprattutto della Biennale di Venezia, partecipano quattro gatti? Il punto è che non solo la musica, ma qualunque attività culturale non è sentita in Italia come parte integrante della vita del paese. Anzi, a dire il vero, è il paese stesso che non è più sentito come una paese, ma come un’azienda, un mercato, dove chiunque pretende di consumare ciò che più gli piace.
Il disinteresse, però, non è solo del pubblico, Ma anche o soprattutto della politica, dell’organizzazione culturale. Ci sarà pure un motivo per il quale, tra i paesi europei, l’Italia è il paese che investe di meno nell’istruzione e nella ricerca (in realtà è il paese che investe di meno anche nella sanità, ma questo è un altro discorso: l’Italia è il paese che investe di meno nella integrazione sociale della popolazione, a tutti i livelli, dalla mancanza di asili nido all’inefficienza dell’assistenza a disabili e anziani, dall’incapacità di controllare il territorio, di intervenire nella manutenzione dei servizi, per esempio degli acquedotti, all’obbligo di riconoscere la cittadinanza italiana a chi è nato in Italia o a chi lavora da molti anni in Italia, dal rifiuto ideologico di riconoscere diversi modi di vivere la sessualità alla sostanziale inerzia con cui si affronta la disparità di diritti – reale! – che ancora esiste tra uomini e donne: insomma l’Italia è una paese inefficiente in tutto ciò che riguarda la vita sociale del paese). La musica, il museo, il teatro non sono sentiti dalla politica come impegno sociale, necessità collettiva, ma se mai, visto che siamo un paese che attira molti turisti, come un’occasione di profitto. Anche il cinema, del resto, il più strombazzato, tra i tipi di spettacolo, non gode in realtà di buona salute, perché non si affronta con decisione la formazione dell’attore, del regista, degli sceneggiatori, e di tutti i necessari collaboratori tecnici, ma ci si limita a finanziare singole iniziative, senza un criterio di scelta e di programmazione. Non ci si lamenti poi che, salvo eccezioni, il cinema italiano non piace fuori dell’Italia. Perché come per la letteratura, per il teatro, per la stessa musica, ci si rinchiude nel cerchio di progetti autoreferenziali. Non siamo europei, anzi litighiamo con l’Europa. Ma poi, chi sa perché, alcuni tra i nostri migliori musicisti si trasferiscono a Parigi, a Berlino e perfino a Boston. Il quaderno delle doglianze è lungo. Ma piangersi addosso non risolve i problemi. Non mancano, del resto, situazioni che fanno sperare un cambiamento, un’uscita da questa soffocante inerzia. Ma certo a poco serviranno se non si cambia radicalmente la gestione dei teatri, delle istituzioni concertistiche, se non si modifica integralmente la conformazione dei conservatori, e non li si adegua alle reali necessità del paese. Tanto per cominciare sono troppi, ma troppi perché pretendono di essere tutti istituti d’istruzione universitaria. Non lo sarebbero se svolgesse l’intero arco della formazione di un musicista, da quello primario a quello universitario.
Una vera riforma della formazione musicale in Italia non c’è ancora stata, quella che si è fatta è un obbrobrio. Al solito, dove le cose funzionano, e ci sono luoghi dove accade, è per l’iniziativa dei singoli, non certo per la conformazione dell’istituzione. L’Italia sembra avere devoluto all’iniziativa singola – non privata: singola – i problemi che lo Stato non sa risolvere o di cui non vuole occuparsi: l’assistenza agli anziani, l’istruzione dell’infanzia, l’assistenza ai disabili, la formazione culturale del cittadino. L’Italia non ha bisogno di più badanti, ma di un’assistenza capillare, efficace, della sanità pubblica, nelle case, ad anziani e disabili, Non ha bisogno di migliaia di professori universitari che insegnino a leggere un pentagramma, ma di musicisti che sappiano trasfondere in chi vuole diventare musicista le competenze e la passione di un musicista. Spero che uscirà un volume in cui siano raccolti i contributi dei relatori del convegno (Stefano Taglietti, Francesco Paradiso, Lamberto Lugli, Gilberto Bosco, Vincenzo Saldarelli, Giuseppe Fagnocchi , Claudio Ambrosini, Biagio Putignano, Andrea Mannucci, Alessandro Melchiorre, Piero Niro, Alessandro Solbiati e i numerosi interventi di altri). La lettura, chi sa, più che delle lamentele, dei progetti, potrebbe, forse, destare l’assonnata pigrizia della politica italiana per quanto riguarda la vita culturale del paese. Ma una considerazione va fatta. Ed è che se la musica, oggi, conosce molti e diversi livelli di scrittura e di fruizione, e, si badi, tutti legittimi, anche quello del semplice consumo ambientale, è però pretesa assurda pretendere che il livello di ricerca più complesso, più difficile debba riscontrare un immediato gradimento del pubblico, così come pura idiozia è immaginarsi che una canzonetta sbrigativamente risolta in oggetto d’immediato piacere possa toccare i vertici del capolavoro indimenticabile. Legittimo il piacere dell’effimero. Ma ugualmente legittimo, anzi necessario il lavoro solitario, faticoso, magari incompreso sul momento, della ricerca, della voglia di sfida, piacere dell’inusitato, voluttà dell’inudito. Potrebbe diventare l’abitudine, l’usuale, il riconoscibile di domani. Un paese che rinuncia alla ricerca – in qualsiasi campo, e dunque anche nella musica, anche nell’arte, anche nella letteratura – è un paese muto, morto, dal cardiogramma piatto. Aristotele scrive nella sua Etica a Nicomaco che una vita felice non è quella che abbia accontentato tutti i bisogni essenziali alla vita, ma che il senso della vita si conosce e dunque si vive solo quando si ottiene anche il superfluo, ciò che non serve a niente, secondo un’ottica del guadagno, ma che serve invece appunto a liberarsi dalla fatica di vivere, per godere, ormai liberi da costrizioni contigenti, della consapevolezza di vivere. E tra le cose superflue – che non procurano guadagno – Aristotele colloca al sommo l’amicizia, e cioè i rapporti interpersonali, e per sé stessi il pensiero, cioè l’arte, la poesia, la musica, il teatro, la filosofia. Anzi è solo il pensiero che rende davvero fruibili anche le cose necessarie, non superflue, le quali, altrimenti, godute inconsapevolmente, non sono diverse dal sonno, dalla digestione, dal respirare, tutte azioni che compiamo senza bisogno di pensare. E aggiunge: se è bene vivere felicemente, per un singolo, è tuttavia bene più alto, Aristotele lo chiama “divino”, il bene che contribuisce al bene di tutti, al bene della collettività (della polis): il “superfluo” dell’amicizia, della poesia, del teatro, della musica, della filosofia. In un altro trattato specifica che il godimento del superfluo è reso possibile dal raggiungimento di ciò ch’è indispensabile alla vita: la certezza di possedere i beni necessari a vivere.
Ci riflettano gli amministratori che conteggiano il costo di un asilo nido, i centesimi di una messa in scena, gli spiccioli chiesti da un cantante, da un regista. Come se l’asilo nido, il teatro, siano cose secondarie, evitabili, risparmiabili, e il necessario stia altrove, nel profitto: di un’azienda, di una scuola, di un ospedale. Dal momento , cioè, che hanno deciso che un paese sia un’azienda, e non un paese. Per scrivere una partitura come il Quartetto op. 130 di Beethoven è necessario che il compositore possa sentirsi libero di pensare solo al quartetto e a non essere travolto dalla preoccupazione di che cosa mangerà a cena. Nella realtà accade di rado e non accadde a Beethoven. Che tuttavia compose il sublime quartetto, e la Grande Fuga che avrebbe dovuto concluderlo. Ma perché la Necessità lo aveva costretto. Ecco: è questa necessità che Aristotele vorrebbe eliminata perché una vita possa dirsi veramente felice, εὐδαίμων (pronunciare eudáimon). Il démone (δαἰμων) della felicità è quello che ristabilisce la condizione di natura: l’uomo, secondo Aristotele, è “l’animale bipede che possiede il linguaggio”, l’unico tra gli animali, come conferma l’anatomia – la laringe abbassata – e anche la moderna neurologia, confermata dalla linguistica (Noam Chomsky – Robert C. Berwick, Perché solo noi. Linguaggio ed evoluzione, Torino, Bollati Boringhieri, 2016). Chiudo con pochi versi, nati proprio dall’ascolto delle relazioni dei convegnisti. M’illudo se mi auspico che la poesia infonda voglia di poesia – e di musica, dunque – in chi regge le sorti dell’Italia? La poesia è dedicata ad Andrea Talmelli.
Il punto, se puoi definirlo, dove
si coagula il sangue del distacco,
non è la storia che vivemmo incauti,
attenti a non oltrepassarlo, quanto
il fiato che mancava nella gola,
ma la linea interminata e ancora
intracciata dei fragili domani
che si aprivano al gioco dei rimbalzi.




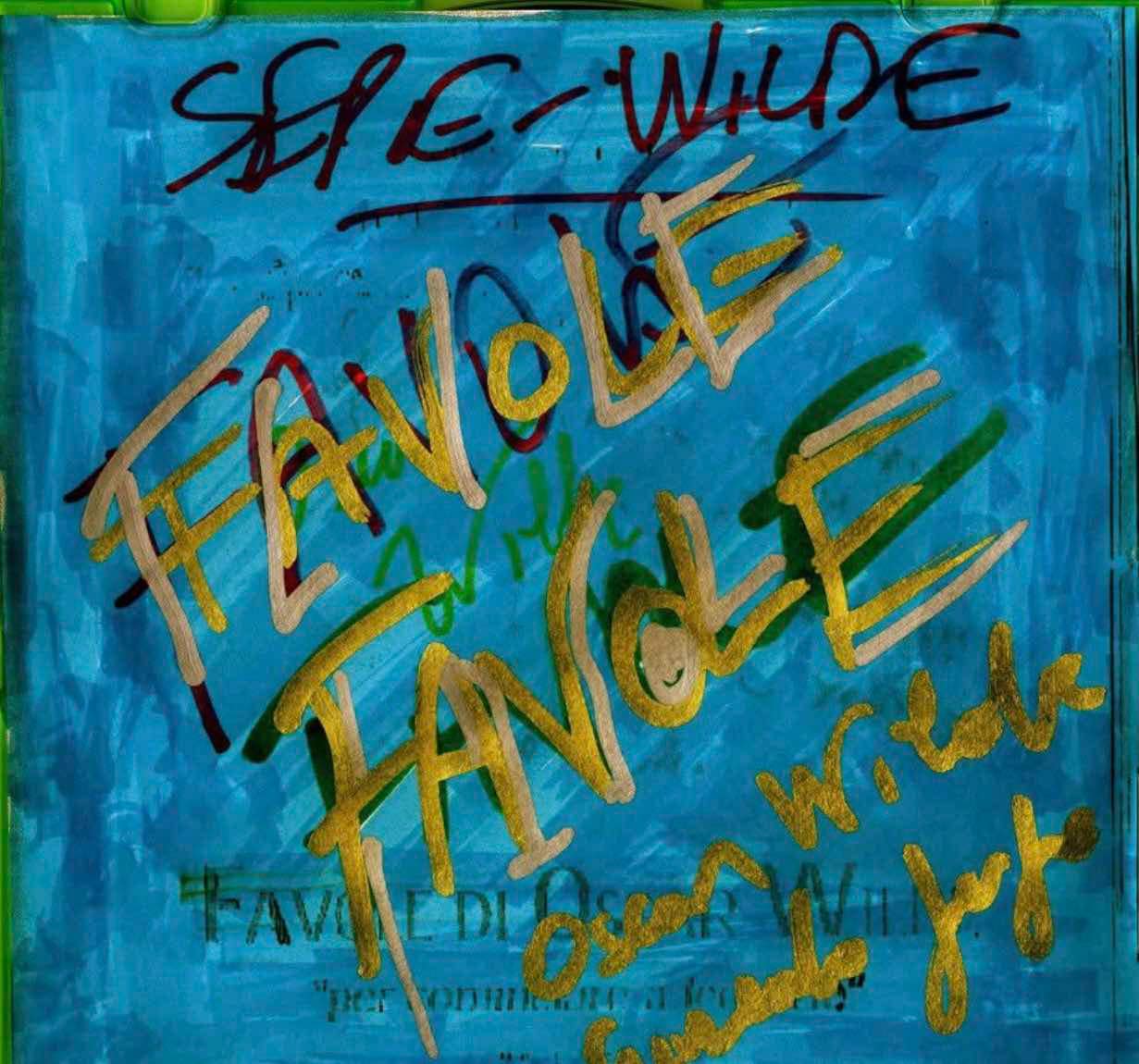
Caro Massimo – evito il cognome, così il correttore resta inoperoso – , grazie del giudizio lusinghiero. Se mai, c’è da piangere perché si concorda una visione assai cupa del paese. Oggi più che mai. Evidemente i lamenti dei poeti non servono, troppe “Italia mia” sono andate inascoltate. Ma – chiedo, impotente, perché non so la risposta – come facciamo a liberarci di questa mediocrissima e indegna classe politica – da destra a sinistra inadeguati al ruolo che ricoprono, e non è qualunquismo, ma constatazione. Meno male che almeno in qualche modo riusciamo a fare leggere la nostra voce. Ma è davvero letta? davvero ascoltata?