Letteratura
Un Petrarca malinconico e inquieto

Di Marco Santagata (Zocca 1947), illustre e versatile accademico (insegna Letteratura Italiana all’Università di Pisa), l’editore Guanda ha ripubblicato un romanzo, Il copista, già uscito in forma meno ampia da Sellerio nel 2000 e nel 2007.
L’attività di studioso di Santagata, che lo ha reso nome noto a livello internazionale, è rivolta soprattutto alla poesia di Dante e Petrarca (delle cui opere ha curato il commento nei Meridiani Mondadori), di Leopardi e dell’800-900. A questa sua principale occupazione, ha affiancato nel corso degli ultimi vent’anni quella, altrettanto rilevante, di narratore (Premio Campiello nel 2003, Premio Stresa nel 2006), cimentandosi in ricostruzioni narrative di ambienti letterari, in rielaborazioni di materiale scientifico, nella giallistica.


Proprio nella nota finale al romanzo di cui parliamo, Santagata afferma di aver intuito, a partire da quando lo ha iniziato nell’estate del 1999, la possibilità di ricomporre le sue due anime di scrittore, indagando in particolare “i nessi profondi, e perciò nascosti, che legano ispirazione e biografia”, e l’investimento emozionale da cui nasce un’opera creativa.
Ne Il copista viene raccontata una giornata autunnale di Francesco Petrarca: autunnale non solo perché si svolge in un nebbioso venerdì ottobrino del 1368, nella Padova (“Città schifosa!”) che ospitava i suoi ultimi malinconici anni di vita, ma perché l’intera atmosfera che avvolge il racconto è permeata di una sottile e grigia angoscia, di abbattuta rassegnazione e di disillusa inquietudine intellettuale.
L’illustre poeta sessantaquattrenne si alza, dunque, prima dell’alba, pressato da una serie di malanni fisici (ulcera, artrosi, disturbi intestinali e urinari), ma soprattutto afflitto da “neghittosità e accidia” che lo inducono allo sconforto e a frequenti, immotivati scoppi d’ira. Colpito negli ultimi anni da dolorosi lutti (il figlio Giovanni morto di peste, come l’adorato nipotino Francesco in cui aveva riposto la speranza di una discendenza), e dalla fuga improvvisa del suo fedele copista, Giovanni Malpaghini (“Giovanni aveva assorbito il suo pensiero fin quasi al punto da identificarsi con lui stesso… copiava e nello stesso tempo mentalmente analizzava le pieghe più riposte del testo”), Francesco Petrarca si rifugia ora nei ricordi gloriosi della sua carriera letteraria e diplomatica, conscio di aver rappresentato per la cultura europea e per la Chiesa un luminoso esempio e un vanto ineguagliabile. Ma è tormentato dalla consapevolezza di non riuscire più a scrivere con l’entusiasmo e la grazia ispirata degli anni giovanili (si ripete “tu petrarcheggi, sei la scimmia di te stesso”), e di godere nel presente solo dell’eco di una fama leggendaria acquisita in passato.
Rimpiange i viaggi e la frequentazione delle corti, le molte donne avute e la virilità perduta, la meditazione raccolta che gli offriva lo studio dei classici a Valchiusa, la privazione dell’affetto di una famiglia, impostagli dal voto di celibato ecclesiastico e dalla sua missione culturale. Con rimorso, ma sempre assolvendosi, rilegge i tormentosi rapporti con i due figli Giovanni e Francesca, nutrendo tacitamente il dubbio che anche il giovane e dotatissimo copista sia nato da una sua fugace relazione. Nella solitudine in cui è immerso, fedele compagnia è quella dell’anziana servetta analfabeta e deforme, che si muove nelle stanze ronzando leggera come un insetto, e poi quella offertagli da rari visitatori: l’amico Boccaccio, che lo implora di ricordarlo nelle opere che scrive, e il Signore di Padova, il colto Francesco da Carrara, suo fervido ammiratore e protettore.
Marco Santagata, in una scrittura elegante e controllata, si rivela molto attento alla ricostruzione dell’ambiente medievale (dalle suppellettili all’abbigliamento), e puntuale nelle citazioni dei versi del poeta aretino. Il suo romanzo assume un ritmo più coinvolgente quando affronta la crisi intellettuale attraversata dal protagonista, nel momento in cui decide di riprendere una canzone in sei quadri, in precedenza solo abbozzata e poi dimenticata, per raccontare la morte di Laura, musa ispiratrice di tutto il Canzoniere.
Nel corso della rielaborazione, Petrarca non solo prende coscienza della falsità della raffigurazione mitica della donna angelicata (“la nostra matrona sfiancata dalle gravidanze? … quel culone ballonzolante e quella pancia gonfia che neppure si distingue dalle tette?”), e quindi della propria passione illusoria e artificiosa, ma si scopre tormentato da ben più angosciosi rovelli spirituali, che lo inducono a interrogarsi sull’immortalità dell’anima e persino a rinnegare la fede cristiana.
Santagata ripercorre la composizione della canzone per Laura (la 323 dei Rerum vulgarium fragmenta) nelle varianti, commentandone le figure retoriche e intrecciandola con episodi e personaggi, spesso di fantasia, dell’intera esistenza del poeta.
Arrivato alle soglie della morte, Petrarca scopre, in una disperazione fredda ma serena, “che l’anima non esiste, che la vita non avrà né premio né castigo”. Nemmeno il riconoscimento di una fama dichiarata universalmente riesce a riscattare la sua intera esistenza dall’insignificanza: la stessa poesia è “labile consolazione”, favola, inganno che allontana dal vero, e l’amore è una costruzione della mente, un abbaglio della fantasia. L’ultimo verso vergato a conclusione della canzone per Laura suona dunque sconfortato e disilluso: “o mondo rio, nulla in te dura!”
Ma sarebbe opportuno sconfessare la propria opera, sacrificare la celebrità raggiunta per proclamare al mondo con assoluta sincerità quel suo nuovo orientamento intellettuale, scettico e irreligioso? “Sessant’anni di fatica, di lavoro, di sopportazione, una vita passata a sgusciare tra cardinali, signorotti, papi e imperatori, essere diventato Francesco Petrarca, conte Palatino per merito dell’ingegno, e poi distruggere tutto così, stupidamente, per quattro versi nati dalla fantasia di un ubriaco”.
La decisione del poeta è umanamente comprensibile, anche se non eticamente giustificabile: “Salviamo la gloria, che è l’unica via per sopravvivere”. I versi finali della canzone a Laura vanno modificati, in ossequio all’onore del mondo e alla fede cristiana.
MARCO SANTAGATA, IL COPISTA
Guanda, Milano 2020, p. 144







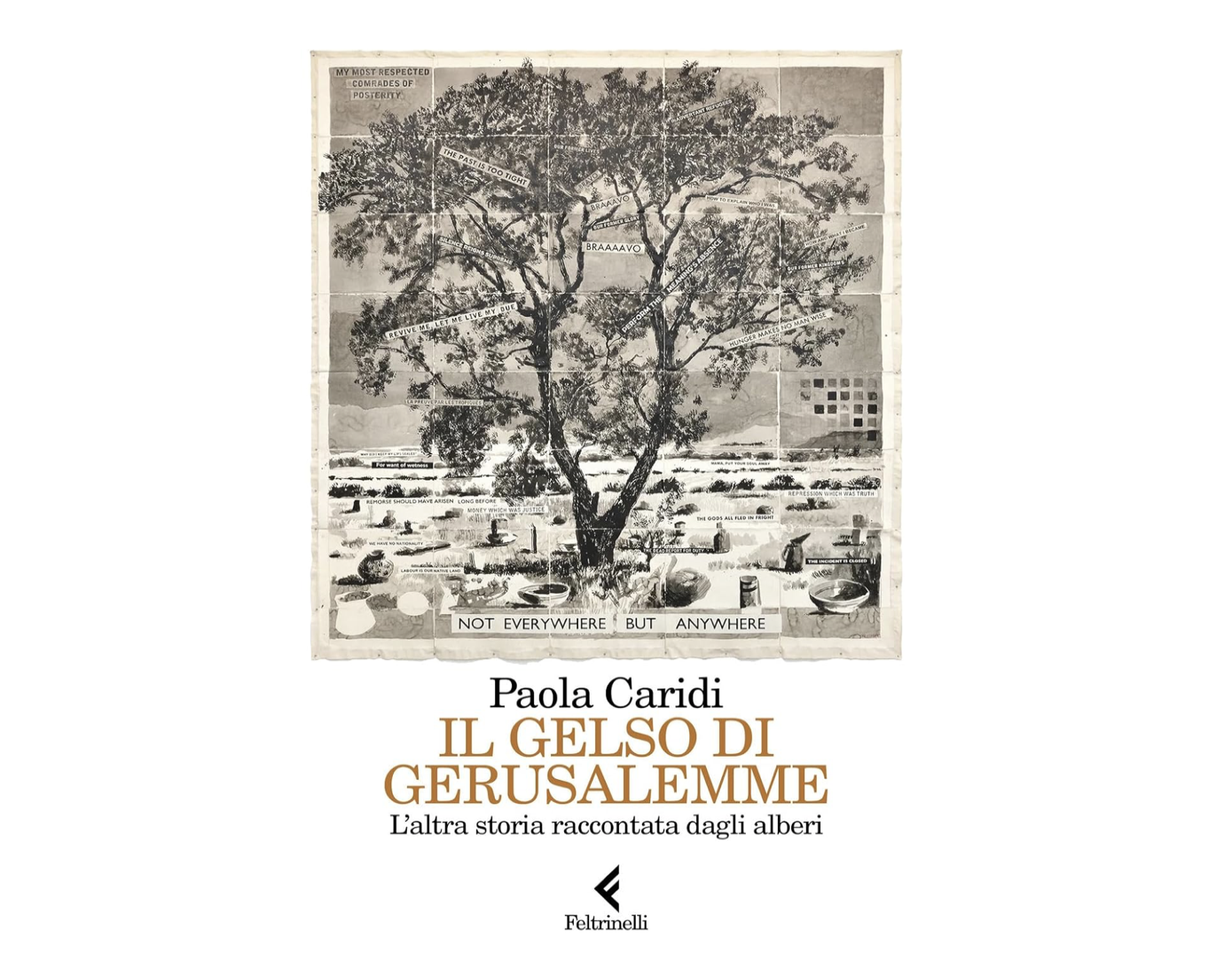

Devi fare login per commentare
Accedi