Letteratura
Scrivere il dolore
Nei quattro capitoli che compongono il volume “Le parole per scriverlo. La ferita e la parola”, la filosofa Wanda Tommasi (che per decenni ha indagato il pensiero della differenza sessuale, sia come docente all’Università di Verona, sia all’interno della comunità filosofica di Diotima) affronta da un punto di vista poco esplorato la produzione narrativa di cinque famose scrittrici, analizzando il tema della sofferenza e della trasformazione messa in atto per superarla, rendendola fruttifera e vitale.
Già nell’introduzione l’autrice esplicita la sua intenzionalità: “Questo libro nasce dalla convinzione che ci sia una grande capacità femminile di accogliere il dolore, di ospitarlo e di elaborarlo… Tuttavia, prima dell’elaborazione del dolore, dev’esserci la sua accoglienza, la sua accettazione a livello esistenziale”. Ascoltando attentamente il proprio sentire, percependolo inconsciamente e affettivamente prima ancora di comprenderlo razionalmente, e mantenendosi recettivi rispetto all’accadere, si può convertire anche la ferita più penosa in un varco, in un’apertura all’alterità: processo di crescita percorribile solo attraverso l’espressione della parola.
Il primo tema preso in esame è tra i più dolentemente complessi da dipanare, perché archetipico e ineludibile: quello della relazione che lega madre e figlia, spesso conflittuale, colpevolizzante, ricattatoria. Tommasi ne approfondisce le dinamiche studiando le pagine di Irène Némirowsky e Marie Cardinal. “L’oscuro materno”, il nodo “enigmatico, inquietante e intrattabile” che lega ogni figlia alla madre viene reso da Némirowsky con rancorosa e irrimediabile ostilità. “L’odio senza riparazione” nutrito dalla scrittrice ebrea russa, l’aveva indotta a tratteggiare un ritratto “abominevole” della genitrice: “affettivamente arida, avida di denaro, di gioielli e di amanti, preoccupata solo della propria bellezza”. Nel 1992, cinquant’anni dopo la morte di Irène avvenuta ad Auschwitz, è stata la figlia secondogenita di lei Élisabeth Gille ad assumersi il pesante compito di rielaborare il rapporto di sua madre con la nonna, attraverso il romanzo biografico Mirador, con una coraggiosa operazione che, rimuovendo il rimosso, non solo offriva una riparazione postuma a un irrisolto conflitto generazionale, ma riconciliava lei stessa con l’ingombrante figura materna.
A differenza della Némirowsky, Marie Cardinal riesce a superare l’avversità verso la madre (colpevole di aver tentato di abortirla e di non averla mai amata), non solo grazie a un lungo percorso di scavo psicanalitico, ma soprattutto servendosi della scrittura. “La carognata” di sua madre (non solo i ripetuti tentativi di aborto, ma soprattutto la sadica rivelazione fattane alla figlia adolescente), colpevole di averle procurato una serie di gravi malattie fisiche e psichiche, viene infine perdonata dopo la morte di lei, dapprima vissuta con sollievo, e in seguito accettata pietosamente, in una riconciliazione ottenuta riattraversando il nucleo più profondo della sofferenza.
La battaglia combattuta da Cardinal non si situa solo all’interno della sua storia personale, ma agita coraggiosamente le acque immobili del linguaggio patriarcale: “Se vinceremo questa battaglia […], potremo anche inventare delle parole per tappare gli spazi lasciati vuoti nella nostra lingua da quegli immensi dominii dell’inespresso, ed essenziale, che, guarda caso, sono dei dominii femminili. Dominii che appartengono da sempre all’umanità, e il fatto di arricchirli, e di occuparli, deve poter arricchire tutti, uomini e donne”. Parlare e scrivere, quindi, per rimarginare ferite, inventando spazi simbolici da occupare, nella fantasia e nel sogno, nella pratica politica, filosofica, artistica.
Lo ha fatto egregiamente Ágota Kristóf, ungherese riparata in Svizzera, che attraverso la scrittura ha trovato modo di esprimere il dramma dello sradicamento dal paese nativo e dalla lingua materna (“Al di fuori della scrittura io non vivo”, diceva). A lei Wanda Tommasi, e al dolore di un sopruso “inassumibile”, dedica la seconda tappa della sua riflessione. Kristóf scrisse i suoi capolavori narrativi in francese, “una lingua nemica” imparata con sforzo e avversione, perché la allontanava inesorabilmente dall’infanzia, dai ricordi, dal modo con cui aveva imparato a nominare il mondo. Tornando sempre nei romanzi al trauma fondamentale dell’esilio, la scrittrice costeggiava la sofferenza senza mai liberarsene, facendo assumere ai suoi personaggi la propria solitudine, lo spaesamento, la rabbia.
Dalla scrittura esplorativa e mai catartica di Ágota Kristóf, Tommasi passa a raccontare l’esperienza esistenziale e intellettuale completamente diversa dell’americana Flannery O’Connor, “fiera claudicante”, costretta all’invalidità da una grave malattia reumatica, capace di accettare la menomazione fisica e la sofferenza che ne derivava in nome di un cattolicesimo in cui l’irruzione violenta e inaspettata della grazia riesce a sconfiggere l’agire malefico del diavolo. In questo senso, la malattia si rivela come evento salvifico, che non sminuisce il valore della persona, ma accentuandone la fragilità aiuta a condividere con gli altri il limite insito in ogni condizione creaturale. O’Connor fa dell’imperfezione e della propria dolorosa claudicanza un punto di forza, uno stimolo a partecipare al processo creativo di Dio attraverso la scrittura: “Non sono mai stata altrove che malata. In un certo senso la malattia è un luogo, più istruttivo di un viaggio in Europa, e un luogo dove non trovi mai compagnia, dove nessuno ti può seguire. La malattia prima della morte è cosa quanto mai opportuna e chi non ci passa perde una benedizione del Signore”.
L’ultimo capitolo del volume, dedicato ad Anna Maria Ortese, “pensatrice del negativo”, invita a riflettere sulla possibilità di trasformare il rancore per la sofferenza innocente (l’indigenza, le ingiustizie sociali, l’abbandono, il lutto) in un sentimento di solidarietà e compassione universale e inclusiva verso ogni aspetto della vita. L’angoscia provata per la morte di un fratello amato poteva essere lenita dalla Ortese solamente utilizzando “parole di luce”: “Queste espressività, e solo queste espressività, mi calmavano. Dicendo la pena, la pena se ne andava. Perciò sentivo lo scrivere come una benedizione”. “L’autrice si fa carico di una pietas femminile, sorretta da una ragione visionaria, capace di penetrare al di là dello schermo del visibile per scorgere i segni di una realtà altra, più vera”. La sua “teologia della perdita” apriva all’interno della negazione spiragli di consapevolezza responsabile, incoraggiando in lei l’amore partecipe per tutti gli esseri umani, gli animali e la natura sfregiata da interessi economici miopi e distruttivi. Solo accogliendo fino in fondo il patire comune a tutti, con umiltà, tenerezza, empatia, si può riuscire a stemperare il male patito, a renderlo più sopportabile,
Ciascuna delle autrici trattate in Le parole per scriverlo “percorre un itinerario personale, che attraversa il negativo elaborandolo e offrendogli uno sbocco nella scrittura”. Wanda Tommasi commenta i testi citati con puntuale competenza e sensibilità, proponendo in conclusione del volume una ricca bibliografia di riferimento.
WANDA TOMMASI, LE PAROLE PER SCRIVERLO – MIMESIS, MILANO 2020, p. 144


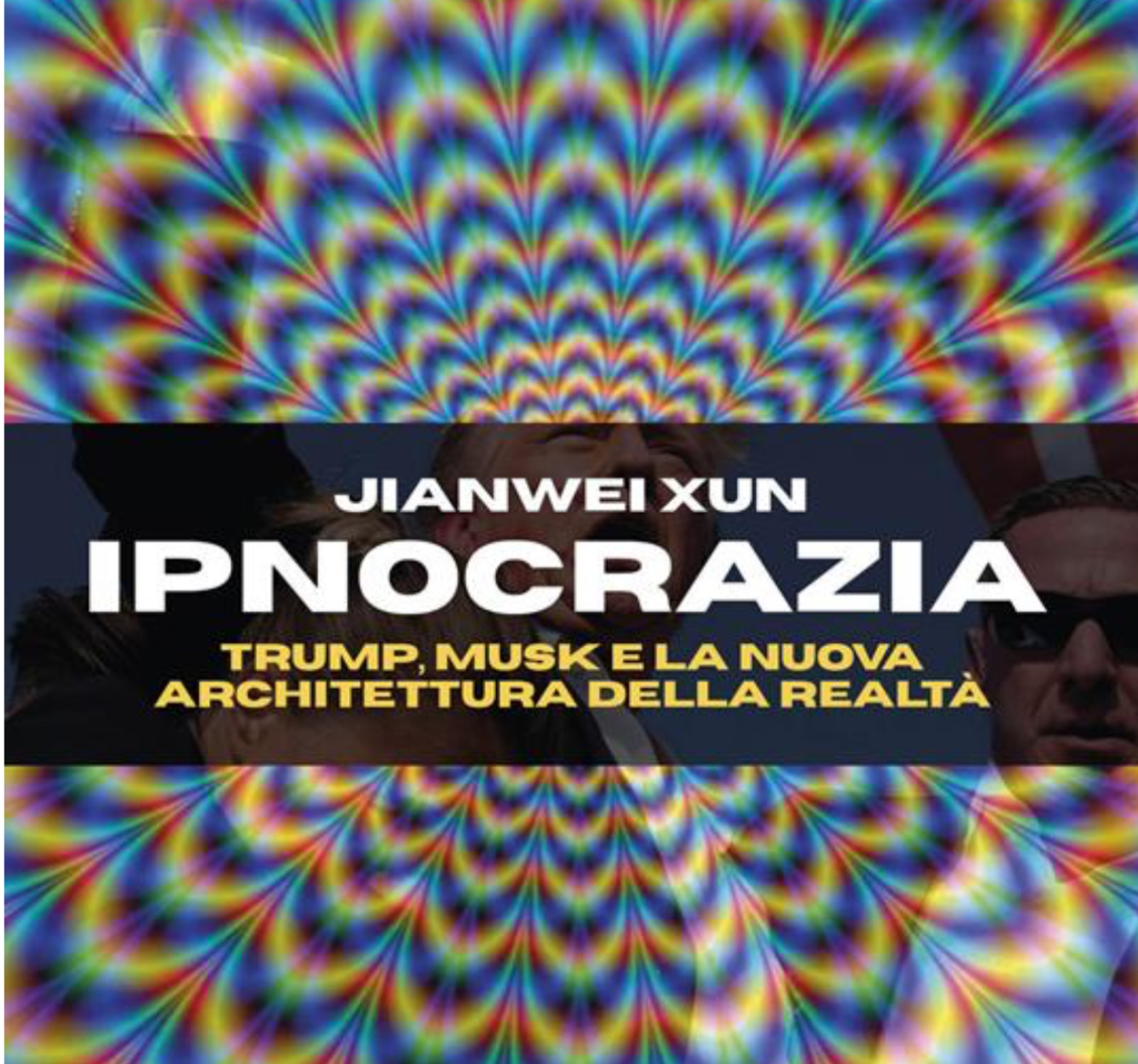

Devi fare login per commentare
Accedi