Letteratura
Rileggere conviene. Eugenio Montale, per esempio
Ogni anno, riprendo in mano Finisterre una piccola raccolta di composizioni di Eugenio Montale. Vorrei raccontare perché.
Finisterre comprende quindici liriche che Eugenio Montale compone tra il 1940 e il 1942, pubblicate in una plaquette autonoma nel 1943 in Svizzera (nel 2003 il filologo Dante Isella ne ha curato una riedizione autonoma) e poi poste in apertura de La bufera e altro (1940-1954) che Montale pubblica nel 1956 e ora ricompresa in Tutte le poesie (Mondadori)
Ho incontrato per la prima volta i versi della raccolta Finisterre tra la fine del 1976 e i primi mesi del 1977. Li ho incontrati per obbligo, non per interesse, né per vocazione. Erano parte del programma di uno degli ultimi esami del mio corso di studi all’Università. Montale era stato appena insignito del Nobel per la letteratura, ma quell’evento non lo avevo registrato. Quell’incontro con Montale avvenne senza passione e produsse molti fastidi.
Mi disturbava la condizione dell’indifferenza, del ritirarsi, di non sapere dove collocarsi in una stagione di drammatiche scelte – quella, coeva alla scrittura di Montale – e di forti passioni – quella presente a metà degli anni ’70. Tutto questo mi teneva lontano da quei versi e, al tempo stesso, me li faceva apparire falsi e “freddi”. Quelle parole, lette allora, mi sembravano facilmente indugiare sul presente, spendibili con furbizia e con ammiccamento da chi proponeva l’avvento del “privato” come luogo di rifugio, come terreno di verità, prima ancora che di libertà.
Più che la disperazione che avevo letto nella meditazione di Carlo Levi in Paura della libertà, o nelle note ultime di Walter Benjamin nella terra di nessuno di Port Bou, l’evocazione di un territorio del nulla che Montale descrive nei versi di chiusura di Su una lettera non scritta mi sembrava trasmettere solo autocompiacimento. E anche la condizione di essere vittime di una forza totalitaria che solo apparentemente lascia la sensazione di esercitare la propria libertà presente negli ultimi versi di Serenata indiana mi sembrava rappresentare solo un gioco di sottrazione. Un gioco dove l’auspicio era il farsi “chiocciola” de Il giglio rosso. Un invito a sottrarsi al presente.
Allora salvavo solo i versi di Persoane separatae. Percepivo, istintivamente, che avevano altra fibra, presentavano la condizione di sentire il senso della tragedia, del vuoto. Tuttavia, mi parevano solo un esercizio.
Dunque, una lettura delusa se non fallimentare.
Dovevo reincontrare quei versi in altra condizione e in un altro tempo. Ancora una volta la scelta era fredda. Eravamo agli inizi degli anni ’80 e dovevo tenere un corso di letteratura italiana contemporanea in una università fuori dall’Italia. Montale era un autore obbligato. Tuttavia, la condizione di guerra nel luogo in cui mi trovavo a vivere in quel momento, improvvisamente conferiva a quei versi una forza che non sarei stato in grado di controllare e che mi avrebbe costretto a ripensare non solo che cosa significhi leggere poesia, ma anche scavare nelle sensibilità che la guerra suscita.
Non dipendeva da me ma dagli studenti con cui mi trovavo a lavorare.
In quella condizione di guerra non più vista al cinema o intravista come esperienza lontana (se non nel tempo, nello spazio) allora improvvisamente quei versi divennero un alfabeto per provare a comprendere il senso di una condizione che mi era estranea. L’ho appresa attraverso le figure di donne e uomini che vivevano la guerra senza avere la forza di opporvisi, o di persone provate da quell’evento, ma che non riuscivano a trovare le parole per esprimere le loro sensazioni o di comunicare il loro smarrimento. Quei versi per quelle persone avevano la funzione di far emergere con pudore alcune loro condizioni o di dare parole ad alcune emozioni. In alcuni casi erano un viatico per dare spessore a cose che non riuscivano più a sentire proprie. In mezzo la disperazione o la sensazione di non avere un domani, di sentirsi attanagliati in un eterno presente senza possibilità di futuro e senza speranza (sono i versi di Giorno e notte).
Ma questa improvvisa condizione, ovvero quella di assistere a una funzione «maieutica» della poesia, mi indusse allora anche a ripensare sui testi scritti in tempo di guerra e su come poi, dopo, una generazione digiuna di quelle emozioni (la mia) era in grado o meno di percepire il significato di quelle fonti per l’indagine storica.
Che cosa significa provare emozioni dentro una guerra che non senti tua, o in una condizione di opinione pubblica che ti isola o ti marginalizza, ma nei confronti della quale non hai la forza di opporti? Come si sopravvive non tradendo se stessi e, allo stesso tempo, cercando di oltrepassare quella condizione di terrore? Quali sono le emozioni che si cercano? Quali le cose per le quali si trepida o ci si indigna? Dove e come si esprime il controllo sulle proprie reazioni? In che forme si controlla la propria doppiezza? Cosa significa provare la sconfitta? Come si selezionano i ricordi? A che cosa si dà valore? Quali le parole che si usano con maggior frequenza?
Gran parte di ciò che chiamiamo consenso si comprende anche vedendo ciò che non è opposizione, o dissenso, ma che tuttavia non è acquiescenza. Talora è non saper trovare un proprio luogo e dunque paralizzarsi o smarrirsi. Due condizioni che hanno trovato le parole rispettivamente nel Kafka dei diari alla data dell’ottobre 1921 o nelle note che Georges Bernanos scrive nella primavera 1940, nei mesi della sconfitta della Francia, nel suo Les enfants humiliés (Gallimard).
Vale nei sistemi totalitari, nella guerra o nella semiclandestinità, nella condizione incerta quotidianità delle minoranze culturali. Vale soprattutto nella esperienza della sconfitta o in quella della solitudine.
È una condizione che ho vissuto e che ho incontrato molte volte anche dentro i contesti culturali e storici che ho scelto di studiare. In quei momenti, quando mi accorgo che sale la temperatura della mia insensibilità o che le mie convinzioni personali fanno velo sulla capacità di scavare tra le parole, allora riapro Finisterre.




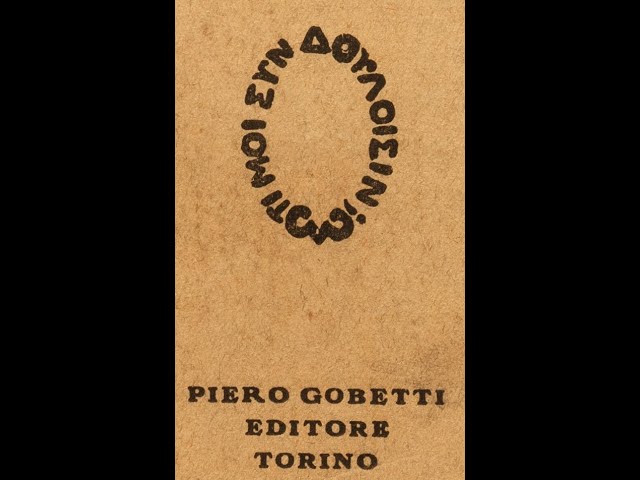
Stimolata da questo bell’articolo, ho trascorso alcune ore e rileggere Finisterre con l’approfondito commento di Campeggiani e Scaffai nella preziosa edizione mondadoriana de La bufera (2019). Perché a inizio del nuovo anno “il tenue bagliore” della poesia continui a rischiararci (nel “buio rotto a squarci”): anche se oggi come ieri “Ben altro è sulla terra”.