Letteratura
Quale pubblico per la poesia? Conversazione con Julian Zhara
Era da un po’ che avevo voglia di fermare qualche riflessione condivisa sulla poesia, l’editoria, l’oralità, la performance, il testo. Me ne ha data occasione un giovane poeta e performer, Julian Zhara, albanese di nascita ma attualmente residente a Venezia.
Recentemente Julian ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Gestione della Arti con un’interessantissima – e un po’ sorprendentemente anche “nuova”, senza troppi precedenti – tesi sulla storia della poesia italiana attraverso l’editoria.

Un lavoro non a caso intitolato “Poesia in cerca di pubblico”, che mi ha offerto lo spunto per una lunga chiacchierata con Zhara su alcuni dei temi che emergono dalle sue pagine e anche molto altro.
La prima domanda che ti pongo è anche la prima che tu stesso ti poni nell’introduzione della tua tesi. Perché oggi si legge così poca poesia in Italia? Ovviamente la domanda è complessa e articolata, ma se dovessi provare a sintetizzare le principali cause, quali evidenzieresti?
Sintetizzo molto, troppo, ma se dovessi – pistola alla tempia – definire le cause in maniera grossolana direi: insegnamento scolastico come prima.
I ragazzi escono dalle superiori pensando che la poesia sia materia da custodi di cimiteri. Come seconda causa invece la struttura mancante tra lettore e libro di poesia.
L’editoria sembra davvero non curarsi di quello che Genette chiama l’epitesto.
Terza causa, e vado ancora più a fondo nella cristallizzazione di una materia a tratti liquida, a tratti nebulosa: i poeti stessi. Un certo abuso immaginifico, lo sfondare porte aperte da altri, l’impossibilità del loro linguaggio ammuffito di farsi questione di vita per qualcun altro che scappa e si rifugia nei romanzi.
Questo processo inizia negli anni ’80 per lo più. Mentre Tondelli e Busi sfiorano le vette della prosa italiana facendo jazz con le parole (penso soprattutto al primo) e dagli Stati Uniti arrivano Roth, De Lillo ed Ellis, ad agire sull’immaginario collettivo attraverso la lingua, i poeti in gran parte, si trovano totalmente inadeguati e si rifugiano nelle riviste specializzate, nelle accademie. Non tutti ma un gruppetto di rondini sparse, come gli esordi di Magrelli, Buffoni e Fiori, non hanno fatto primavera sul campo letterario, illuminato dal sole del romanzo. In Seminario sulla gioventù di Busi, volendo fare un cut up, potremmo ricavare almeno venti libri di poesia da vittoria del Viareggio.
Un altro passaggio che mi ha colpito è quello in cui non solo citi il dato secondo cui solo 1 lettore “forte” su 2000 acquista un libro di poesia (e il numero diventa ancora più irrilevante se ci si concentra sulle case editrici minori), ma anche dici che non c’è aderenza tra i libri di poesia più venduti e quelli preferiti dalla comunità poetica. Da dove parte questo scollamento?
I libri di poesia più venduti riguardano le grandi case editrici, quelle a distribuzione diffusa in tutto il territorio italiano. La stessa grande editoria ritiene la poesia una collana kitsch della nonna che non si butta via solo per il valore affettivo passato, ma il disinteresse verso la promozione è evidente. Si arriva a pubblicare per queste case, come traguardo di un percorso travagliato e spesso poco chiaro e non c’è una persona nata negli anni ’80 che abbia una pubblicazione per Einaudi e Mondadori.
In questo l’offerta e già data in precedenza senza nessun interesse a creare la domanda e quando c’è, viene portata a decidere tra le declinazioni più scemocratiche dell’amore, vedi voce Alda Merini et similia.

Un outsider come Guido Catalano che ha fatto 18 anni di gavetta per “strada”, tra circoli, bar, teatrini e slam, e che non ha la critica dalla sua, viene osteggiato dalla comunità poetica perché mette in crisi un percorso tracciato su binari stabiliti in precedenza ma ormai inservibili, e a cui si continua a credere con fede cieca. Lui pubblica per Rizzoli; gli altri no.
Basta comunque confrontare le classifiche IBS dei libri di poesia più venduti negli anni Zero e le risposte al questionario di Pordenonelegge, non solo dei poeti under-40 ma anche quella dei lettori forti.
In fondo, un poeta è riconosciuto tale da due agenti: critica e pubblico. Pare che gli editori piccoli e medi di poesia, non si curino del secondo agente; quelli grandi più o meno e se va male ristampano Neruda e Bukowski.
Il discorso storico della tua tesi è particolarmente articolato, ma mi interessa in particolar modo concertarmi sui decenni più recenti, su questo passaggio dalla centralità, anche pubblica, di figure come Montale, Ungaretti, Pasolini (che però non è stata una figura pubblica solo in quanto poeta) all’irrilevanza quasi totale del discorso sulla poesia nei media generalisti (citavi il caso del boom delle vendite della Szymborska citata a “Che tempo che fa”).
Lo sbarco sulla luna è stato commentato da Ungaretti perché si voleva assegnare al poeta il compito di guidare il pubblico televisivo verso l’ignoto. La rivista “Officina” viene chiusa per una poesia di Pasolini dove si accusava il Papa di essere il più gran peccatore del mondo. La poesia sembra sparita dalla maggior parte dei programmi televisivi ma anche dalle terze pagine, dal discorso attorno alla letteratura: il suo dominio nel campo culturale, è simile a quello di un pulcino in una gabbia di leoni – lo si lascia sopravvivere solo per sentirlo cantare la sera basta che stia in disparte. I poeti poi sono spariti dalla scena televisiva per lo più anche perché incapaci di aggiornarsi alla prerogativa degli opinionisti tv, che Bourdieu giustamente chiama fast thinkers.
Pure Aldo Busi viene chiamato negli ultimi anni a dispensare opinioni su fatti di cronaca o di politica becera e confrontarsi con persone che intellettualmente potrebbero fargli solo da scendiletto.

Quanto il fenomeno dell’editoria a pagamento “influisce” secondo te sulla percezione di un mondo della poesia che non sia solo la messa su carta dell’intimità di dilettanti più o meno manchevoli di talento che “spacciano” i propri libri a parenti e amici?
Penso il problema più grosso non sia pagare un editore ma che quell’editore non venga definito tipografo e che lo si paghi solo per la stampa dei libri e un codice ISBN.
I tipografi a pagamento, chiamiamoli così, fanno inquinamento ma ogni sistema produttivo tiene conto dell’inquinamento (quanti musicisti, artisti visivi, registi allo sbaraglio conosciamo?). Il lato preoccupante riguarda la parte sana, gli editori seri, veri, che rischiano a ogni pubblicazione, i quali sembra che non si occupino o lo fanno davvero male, di asfaltare e rendere agibile la strada che dovrebbe portare il libro al lettore.
A volte ho l’impressione, ma potrei sbagliarmi, che la scarsa fortuna editoriale dei libri di poesia (o comunque una certa capillarità incontrollabile e numericamente non rilevante della loro diffusione) si deva – oltre che alla scarsa attitudine innovativa e comunicativa di tutta la filiera – anche alla percezione che la poesia sia qualcosa di intimo, personale, non facilmente condivisibile con altri. Mi spiego: magari per qualcuno è emozionante e significativo un poeta o un suo lavoro, ma magari lo tiene come cosa sua, mentre se legge un romanzo lo consiglia subito a tutti…
Sì, la poesia è ritenuta una produzione intima e personale ma quanto i grandi poeti ci hanno insegnato è che il personale portato all’estrema conseguenza si spersonalizza, particellizza, coglie altro dalla nostra struttura sociale e si attacca a una parte di noi di cui non sappiamo ancora il nome, diventando universale.
Penso a quando ho letto per la prima volta “La rabbia” di Pasolini, in particolar modo la terza strofa. Non ho letto descritti in maniera eccezionale i sintomi del suo dolore – era il mio, quello di chiunque. Non penso che un lettore possa appropriarsi di una poesia, tenendola stretta però come cosa sua, nella collezione della propria cassaforte.
Moltissimi libri letti e poi amati, sono il frutto di consigli spassionati di amici poeti.
Parliamo ora di poesia e musica. Nella tua tesi sintetizzi bene l’annoso dibattito su canzone vs poesia, recentemente ravvivato dal Nobel a Bob Dylan e, in un passaggio che mi sembra centrale, ricordi come, progressivamente, lungo tutto il ‘900, il bisogno di poesia sia soddisfatto dalla canzone. Possiamo dire, con una forzatura forse, che la poesia ha peccato di hybris per elevarsi a arte elitaria, perdendo il contatto con la sua natura primigenia di canto?
La poesia no, i poeti sì. Tutto lo scalpore per l’assegnazione del Nobel a Dylan ne è una prova. Guido Mazzoni, appoggiandosi a uno scritto di Tondelli, cerca di spiegare il passaggio della fame di poesia dei giovani, soddisfatta sempre di più dalla canzone. Sappiamo testi di canzoni a memoria senza averli mai letti e sono sicuro che i poeti, tutti, sanno più canzoni a memoria che poesie. Non penso però sia per un peccato di elitarismo ma una sindrome di amusìa pubblicizzata dal sistema letterario.

In un tuo recente intervento su Facebook chiudevi il post dicendo che gli ultimi nipoti di Omero sono oggi i rapper e non i poeti.
Ultimamente mi sono molto interessato all’ambito della poesia orale, della slam poetry e anche, ovviamente, del rapporto tra rapper e MCs con il testo poetico. Ho come impressione, perdonami se sbaglio, che forse il problema di fondo sia nella molteplicità delle possibilità dell’azione poetica, sia scritta (quindi letteraria) che orale (quindi legata al corpo, alla voce, al suono). Nel senso che a volte percepisco – ma è una percezione non voglio che suoni come una convinzione – come una scomodità di tutti nello stare nella propria sedia (tranne che per gli accademici che se ne fregano e per i musicisti hiphop più commerciali che magari non ne fanno nemmeno un discorso poetico). Che ne pensi?
Quanto il postmoderno ci ha insegnato è che le sedie sono tutte a due piedi: resistono nell’arredamento generale ormai per una forma di design, appoggiate magari al muro per stare su, ma incapaci di reggere un corpo pesante, a meno che non si tratti di insetti o zanzare.
Oggi tutta l’arte è transmediale e si può parlare benissimo di letteratura dopo Pulp Fiction, dopo Lynch tranne che per la poesia, dove si cerca di farla solo ed esclusivamente su parametri letterari. Più si va avanti più noto una vena reazionaria e simil-purista che ha del preoccupante. La poesia è la produzione più anarchica in assoluto e storicamente non è mai stata confinata nel ripostiglio nonostante lo sforzo dei poeti minori.
Mi spiego e lo faccio con nomi che ritengo tra i maggiori oggi in Italia: Giovanni Fontana, Franco Buffoni, Vivian Lamarque, Gabriele Frasca, Lello Voce, Gherardo Bortolotti non hanno nulla in comune a livello compositivo e di poetica e ma fanno tutti parte dell’universo poetico – universo appunto, composto da elementi diversissimi e da poetiche trasversali. Il poeta-poeta che fa poesia-poesia è un miraggio storico-letterario che serve solo per introdurre la poesia agli studenti in un corso scolastico. Anche quando si fa poesia-poesia, i dispositivi utilizzati sono totali, agiti da ogni produzione artistica, non prettamente ed esclusivamente letterari.

Qualche volta confrontandomi con te – ma anche con altri – percepisco da parte dei poeti della tua generazione da un lato una profonda – e del tutto giustificata – rabbia nei confronti di un mondo culturale bloccato e baronale, nei confronti di posizioni acquisite e delle manifestazioni più accomodanti della poesia. Dall’altro mi sembra a volte che questo tipo di contrapposizione rischi di portare a posizioni un po’ tranchant che forse in parte contraddicono la tensione a raggiungere un pubblico più ampio, che magari si trova a amare cose che all’ambiente poetico sembrano orribili o viete. Sbaglio?
Nel decennio che va dal Sessantotto all’Ottanta gli esordienti giovani, più o meno trentenni sono molti, moltissimi. Vi era un tentativo congiunto di poeti e intellettuali riconosciuti per far emergere una generazione e portarla subito alle luci della ribalta letteraria. Alcuni di quei grandi esordienti sono tra i più importanti poeti italiani contemporanei e i medesimi fanno cascare solo briciole dal tavolo per chiamare i giovani a raccoglierle. La rabbia intergenerazionale è giustificata. Non solo in poesia ma anche in politica.
Il fenomeno slam poetry sembra in grado di accendere interesse verso nuovi pubblici. I pericoli, ne parlavamo qualche tempo fa, sono quelli di una tendenza (più o meno consapevole) verso il cabarettismo – ovviamente il performer che più fa ridere piace – e alla facile presa. Quale secondo te la situazione attuale? Ritieni possibile che il mondo dell’oralità e della slam possa veicolare nuovi lettori e lettrici anche verso l’editoria di poesia?
Quando Lello Voce importa lo slam in Italia, si creano principalmente due assi: la prima che fa capo ad Absolute Poetry di Lello e un gruppo agguerrito di giovani poeti orientati alla ricerca e che utilizzano il format slam come palestra di oralità; la seconda, torinese, di Catalano/Racca/Bravuomo che creano una scena poetica fortissima, più attenta alla poetica del quotidiano. Poi entrambe queste assi convergono in molti punti ma osservando il panorama contemporaneo degli slammer, mi accorgo che il secondo asse, più orientato a dinamiche confinante col teatro/poesia e cabaret, è indubbiamente quello più numeroso. In Guida Liquida del Poetry Slam, Dome Bulfaro cerca di fare il punto e ripercorrere la storia del Poetry Slam in Italia dal 2001, anno in cui Lello lo introduce a Roma e la nascita della Lega Italiana del Poetry Slam. Nel cabaret, io sinceramente non ci vedo nessun rischio. Il rischio casomai è il cabaret fatto male accompagnato dall’assenza di una dimensione di ricerca e di coscienza dei propri strumenti, l’appiattimento dell’immaginario e la ricerca della poesia facile, che non provoca crisi o spostamenti nell’ascoltatore.
Ma non è il poetry slam che vive questo rischio. Tutta la poesia ne è oggetto – allargando il campo, ogni produzione artistica lo è. Lo slam è un format, come il libro, e se una poesia fa schifo non è colpa della sua struttura di trasmissione. Vero è anche che ogni media incide sul messaggio e piano piano, si sta creando una poesia “da slam” ma la vittoria per due anni consecutivi di Simone Savogin come campione nazionale e il suo piazzarsi al sesto posto nel campionato mondiale, porta tutte le accuse di cabarettismo a non coincidere con la vittoria della sua poesia: emotiva, musicale e con grande coscienza prosodica.
Parliamo del tuo lavoro come poeta e performer, legato all’ambito della spoken music. Come costruisci i tuoi testi e le tue performance?
Collaboro con un musicista veneziano, Ilich Molin. Lavorando con la musica per una composizione corale, cerco di creare uno sposalizio su una metrica quantitativo/accentuativa dei testi, senza però rappare né cantare. Mi piacerebbe che si parlasse di cantillazione, un termine preso in prestito dall’etnomusicologia.
In Italia, a portare a livello sistemico un’operazione simile, di studio e prassi tra poesia e musica, c’è in particolar modo Lello Voce assieme a Frank Nemola. Per il resto, nonostante molti progetti di sonorizzazione o di oratura fuori dal format-libro o inerente a, che studio e apprezzo e di cui mi nutro, la percezione che ho del nostro lavoro, si avvicina a quella del “servo lampadoforo”, un’immagine bellissima che Andrea Cortellessa usa per la poesia di Andrea Zanzotto: non sappiamo dove stiamo andando ma continuiamo a illuminare di poco il perimetro attorno, procedendo.
Quali sono, in ambito musicale, gli artisti che più ti hanno colpito e influenzato? Penso sia all’ambito black (da Gil Scott-Heron al rap), ma anche a esperienze quali gli Offlaga Disco Pax o i Massimo Volume.
Mi interessano molto di più i lamenti funebri del Sud, le cantillazioni della Bibbia e del Corano o le esperienze musicali di sonorizzazione che la componente testuale degli Offlaga o dei Massimo Volume, i loro esperimenti di spoken. Ultimamente sono molto interessato alla composizione formulaica dei rapper, gli stratagemmi prosodici che utilizzano, più dell’immaginario da strada o periferia: la strada è quello spazio che i rapper calcano per arrivare dalla casa al bar o al supermercato in macchina. Mi interessano di più gli strumenti, ecco.
Tre libri di poesia usciti negli ultimi 20 anni che chi legge questa intervista dovrebbe correre a comprare.
Più che correre a comprare, dovrebbe battere le dita sulla tastiera del pc e ricordarsi il codice della prepagata. Domanda difficile e risposta ancora più difficile ma penso di poter conservare la biodiversità rispondendo con: Parola Plurale. Sessantaquattro poeti italiani fra due secoli, a cura di Giancarlo Alfano, Alessandro Baldacci, Cecilia Bello Minciacchi, Andrea Cortellessa, Massimiliano Manganelli, Raffaella Scarpa, Fabio Zinelli, Paolo Zublena; Macello di Ivano Ferrari; Comedia di Rosaria Lo Russo.
Non per dire, ma i tre libri che citi sono tutti fuori catalogo attualmente… ma proseguiamo: tre poeti su cui scommetti per il domani. Tre performer su cui scommetti. Anche non italiani.
Rispondo con alcuni nomi di poeti non semplicemente poeti e non semplicemente performer, ma che sono sicuro tra trent’anni ci saranno ancora. In ognuno di loro vedo la poesia come morbo non trasmissibile e patologia con cui convivranno a vita, anche senza blog, riviste, libri, secondo me scriverebbero sempre. Faccio nomi di poeti sotto i quarant’anni: Luigi Nacci, Tiziana Cera Rosco, Giulia Rusconi, Alessandro Burbank, Silvia Salvagnini, Davide Nota, Manuel Micaletto, Gabriele Stera. Come mi diceva di fronte a un bicchiere di vino Roberto Deidier, in poesia vince chi ha il fiato lungo e i nomi citati hanno polmoni da triathlon. Ne manca uno comunque.
I tre poeti più sopravvalutati da editoria e pubblico? Perché?
Potrei surfare sulla domanda facendo i nomi dei morti: Merini, Penna e Bertolucci.
Ma se intendi i vivi e so che intendi i vivi, penso a Davide Rondoni, Claudio Damiani e Maurizio Cucchi. Tutti e tre soffrono di amusìa per citare un capitolo di Musicofilia di Sacks; gli strumenti poetici che utilizzano sono protonovecenteschi nella più abusata e sfiancata concezione del termine. Maurizio Cucchi però ha licenziato un capolavoro, il suo primo libro Il Disperso, una delle raccolte più libere, importanti e incisive degli ultimi 40 anni, ma da lì, non è più riuscito a superarsi. Quel libro, che si trova ancora in libreria, lo consiglio a tutti.
Quanto l’ambito teatrale può essere importante (e se lo è stato, in che misura) nello stabilire un rapporto diverso, performativo, con il pubblico della poesia?
Penso a Mariangela Gualtieri e al Teatro della Valdoca, al lavoro sulla phonè di Carmelo Bene, solo per dirne un paio…
Il teatro è fatto di un materiale altamente liquido e denso, sia sul piano compositivo che sulla messa in scena.
Mettendo in discussione il libro come unico medium di trasmissione del testo poetico, i poeti di ascendenza orale, devono per forza attingere a strutture preesistenti nel Secondo Novecento: il teatro e la canzone e in minima parte la performance art.
Quindi non è importante: è fondamentale.
Personalmente ho faticato non poco a uscire dal cono d’ombra della mia ossessione per Carmelo Bene, senza diventarne la macchietta che esegue i propri testi “alla Bene”.
Oggi mi interessa di più il suo lavoro di traduzione ritmica di Laforgue o di Byron più che il lavoro scenico, la lettura senza l’enfasi squallida dell’attore-tipo, che qui Bene aveva ragione ad accusare gli attori di non avere conoscenze metriche e di recitare dove sarebbe bastato seguire ed eseguire semplicemente lo spartito sillabico-accentuativo.
Il mio faro nella notte, resta – ed è così da anni – il Manfred. L’avrò ascoltato fino a farmi sanguinare le orecchie.
Tornando a quanto dicevi prima sulla cantillazione, mi chiedo quanto l’aspetto rituale influisce su questa scelta? Quanto la lingua influisce? Ti faccio l’esempio del compositore – immenso – Robert Ashley che, constatata l’inadeguatezza della lingua inglese al melodismo dell’opera, ha inventato un fenomenale cantato/parlato per i suoi lavori di teatro musicale…
Ma penso anche a Leos Janacèk, il compositore ceco, la cui freschezza del lavoro operistico si deve al fatto che le melodie – come emerge dai suoi taccuini – ricalcano il movimento del parlato quotidiano…
L’influenza della lingua è un fattore determinante, in particolar modo per me che provengo da un’altra madre-lingua, l’albanese, in una lingua adottiva: l’italiano.
Dylan Thomas scriveva “Contengo in me una bestia, un angelo e un pazzo. E la mia ricerca riguarda la loro azione, e la mia difficoltà consiste nel loro soggiogamento e nella loro vittoria, negli abbassamenti e nei sollevamenti, e il mio sforzo è la loro autoespressione”.
Oltre all’angelo, al pazzo e alla bestia, io percepisco prorompente il bambino che parla albanese, ancora, e il mio sforzo più grande non è solo gestirne l’autoaffermazione ma riuscire a incanalare tutto quello che dice in un’altra lingua. Forse è questo il motivo per cui mi trovo ancora a disagio con le forme canoniche della versificazione italiana, come l’endecasillabo e il settenario, trovandomi molto più aderente in altre metriche meno frequenti. Quando parlo nel sonno, mi si dice di parlare ancora in albanese, lingua che pur sapendo, praticamente non frequento più, e il sonno come la poesia, attingono a una dimensione senza nome, a un bacino immaginifico e sonoro che ha a che fare con la sfera dell’inconscio.



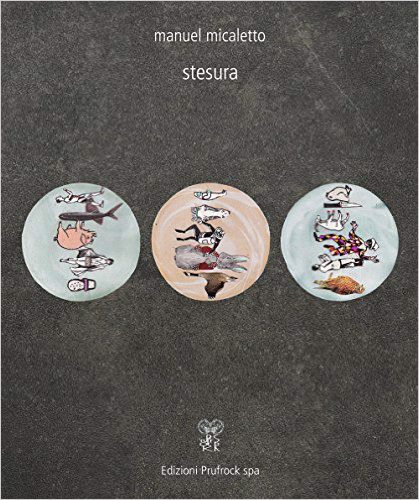
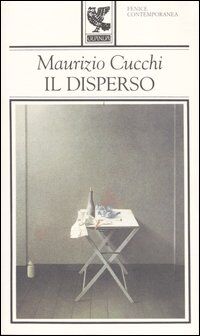
Devi fare login per commentare
Accedi