Letteratura
L’ultimo Enrigue: la conquista del Messico in diretta
Álvaro Enrigue è uno straordinario scrittore messicano, nato nel 1969. Nel 1996 vinse il premio di Primera Novela (Primo Romanzo) Joaquín Mortiz del Grupo Editorial Planeta con La muerte de un instalador (Random House Mondadori, 2008), tradotto in italiano con il titolo La morte di un artista (La Nuova Frontiera, 2018), perché – naturalmente – il lettore italiano ignora che cosa sia un’installazione ma sa che cosa è un artista. La stupidità degli editori italiani nel cambiare ridicolmente i titoli – alcuni titolo sono intraducibili, è vero, ma non è questo il caso e comunque questo è un altro discorso – è ormai talmente dilagante che è quasi inutile denunciarla. Né scusa gli editori il fatto che la distribuzione cinematografica fa peggio, Domicile conjugal, domicilio coniugale, di Truffaut, diventa Non drammatizziamo … è solo questione di corna! Non credo, infatti, che il lettore messicano o, comunque, un lettore di lingua spagnola, sia in genere più colto del lettore italiano (o sì?), ma certo l’editore che ha pubblicato il romanzo del titolo spagnolo dimostra maggiore fiducia nella cultura del lettore di lingua spagnola che non l’editore della traduzione italiana per la cultura del lettore di lingua italiana.
Enrigue affronta per lo più temi o di arte contemporanea, come nel romanzo sopra citato, o di storia del passato che illumini aspetti della storia di oggi. Prima del romanzo sul quale intendo qui riflettere, ha pubblicato Muerte súbita (2013, Premio Herralde, lo Strega spagnolo, ripubblicato da Anagrama nel 2020), tradotto in italiano con il titolo Morte improvvisa (Feltrinelli 2015), un incontro nella Roma nel 1599 tra il grande scrittore spagnolo Quevedo e Caravaggio, entrambi appassionati del gioco della pallacorda e famosi spadaccini; e Ahora me rindo y eso es todo (Anagrama, 2018), tradotto in italiano sempre da Feltrinelli nel 2021 con il titolo Adesso mi arrendo e questo è tutto: la storia di Geronimo, capo degli Apache, il quale non si adatta alla delimitazione dei confini nazionali tra USA e Messico perché impediscono il movimento tra le terre dei due confini per il pascolo del bestiame, una riflessione sull’assurdità di stabilire confini politici tra i popoli in un paesaggio che ignora i confini. Ha fatto bene Feltrinelli a tradurre il titolo originale dei due romanzi senza cambiarli.
Il lock down per la pandemia di covid ha recentemente costretto a casa anche Enrigue. che ha dedicato il tempo di reclusione forzata alla scrittura di un nuovo romanzo, È nato così Tu sueño imperios han sido, il tuo sogno imperi sono stati (Anagrama, 2022), non ancora tradotto in italiano. Il titolo cita un verso de La vida es sueño, la vita è sogno, di Calderón de la Barca. Giusto per restare nel clima tardorinascimentale e barocco del racconto. Soggetto del romanzo è, infatti, l’incontro tra l’imperatore azteco Moctezuma (traslitterazione di Enrigue dal nahuatl, in italiano diciamo Montezuma) e il conquistatore spagnolo Hernán (i suoi soldati lo chiamano Hernando) Cortés. Ma i due s’incontrano solo nelle pagine finali. Il racconto si svolge per 202 pagine senza che l’imperatore e il condottiero s’incontrino. Ma ci viene raccontata la vita quotidiana del palazzo imperiale in cui vivono, insieme ospitati e prigionieri, i conquistadores. Intorno la vita abituale, ligia a una rigida etichetta di comportamento, al rispetto di un linguaggio che di proposito minimizza la realtà dei messaggi – non capisco perché tu sia venuto e quali siano le tue intenzioni” diventa “l’insignificanza della mia persona è onorata di ricevere la tua grandezza in attesa che essa le spieghi le ragioni per cui le concede un così grande onore”. Ugualmente perifrastiche sono le denominazioni delle cariche: “el consejero que Abre las Lluvias de la Lengua y Administra los Cantos para que No Seamos como las Flores y las Abejas que Duran sólo unos días”, il consigliere che Apre le Piogge della Lingua e Amministra i Canti affinché Non Siamo come i Fiori e le Api che Durano solo alcuni Giorni. Le vicende restano sospese, come tutto il romanzo, ma più che altrove, tra realtà e sogno. Conosciamo a poco a poco le abitudini di ciascun personaggio, i suoi pensieri, le sue idiosincrasie, le sue predilezioni, senza che la vicenda avanzi di un solo passo. L’immobilità delle azioni corrisponde all’immutabilità dello spazio dentro cui agiscono: la città di Tenoxtitlan, costruita con geometrie regolari sopra un lago, i ponti che si alzano e si abbassano da un isolotto, “islote”, all’altro, e in mezzo la cittadella con i templi di Ehécatl, Huitzilopochtli (pronunciare: Huitzlilopočtli), Quetzalcóatl ( pron. Ketzalkóatl). Questa sospensione tra realtà e sogno rientra perfettamente nella tradizione letteraria spagnola. Anzi la letteratura dell’America Latina ha addirittura esasperato questo aspetto, si pensi solo a Borges o a García Márquez. Di quest’ultimo, Enrigue sembra esasperare la ricerca linguistica. Il cibo piccante degli aztechi procura ai conquistadores “attacchi ditirambici di flatulenza”. La lingua degli aztechi è il nahuatl. Lingua tuttora parlata da una notevole porzione del popolo messicano. Consiglio anzi il lettore italiano d’informarsi al riguardo, esistono pubblicazioni in lingua inglese sulla lingua e la letteratura nahuatl. Quanti sanno, per esempio, che la parola “coyote”, che denomina l’animale, è una parola della lingua nahuatl? Enrigue riempie le pagine di parole nahuatl, titoli imperiali, oggetti, edifici, città. L’imperatore è il heui tlatoani, il grande signore. Il suo ministro è un cihuacóatl (pronunciare sihuakóatl). La struttura di pali che regge i teschi, un’intelaiatura di geometria perfetta, si chiama tzompantli, anzi huei tzompantli, grande tzompantli. I teschi appesi alle pertiche, mossi dal vento, producono una musica celestiale, come di “cascabeles”, campanelle, emettono un tintinnio di campanelle, scrive Enrigue. “Occupava il centro stesso della cittadella ed era una piattaforma quadrangolare lunga circa trenta vare (misura azteca) – trentacinque metri – e larga dieci – dodici metri – chiusa a est e a ovest da due muri imbiancati. Avvicinandosi, curioso, quasi da turista, avrebbe ascoltato, prima, un rumore come di semi dentro una zucca secca. Poiavrebbe scoperto che i due muri erano collegati da un numero ossesivo di pertiche orizzontali e pali verticali su cui stavano infilati, come se galleggiassero, migliaia e migliaia di cranei – perforati alle tempie. Unendo ogni palo con il successivo c’era, da sopra a sotto, dodici pertiche occupata ciascuna da sei o sette cranei. Dietro di esse, una decina indentiche. A lato un’altra e un’altra e un’altra. Calcolò, a batter d’occhio, che ci dovevano essere circa quarantamila teschi, molti con qualche vertebra pendente per migliorare la loro funzione di sonagli – il suono, così come l’odore o il sapore, era una forma di preghiera per i mexichi (mexicas, nome nahuatl della popolazione)”.
L’apertura del romanzo è mozzafiato. C’è un pranzo al quale sono invitati i conquistadores spagnoli, è presente Atotoxtli (la x in nahuatl si pronuncia come il gruppo sh inglese), sorella e moglie dell’imperatore. Un ufficiale spagnolo non riesce a mangiare le prelibatezze che sono servite a tavola, tra cui un zuppa di cioccolata, perché gli siede accanto il grande sacerdote che per mantello indossa la pelle di un guerriero sacrificato e scorticato dopo morto, ma ormai passato qualche giorno la pelle comincia a imputridirsi e a puzzare. Il superiore gli ordina di non fare storie e di mangiare e Atotoxli lo fulmina con uno sguardo. Il disgraziato ingoia di malavoglia e con acuti conati di vomito la zuppa. Atotoxtli si alza da tavola ed esce infuriata. Poi si saprà che non per l’imbarazzo dell’ufficiale spagnolo, bensì per l’assenza del fratello e marito Moctezuma. Ecco qui di seguito un esempio della prosa di Enrigue, da me tradotto, come il brano sopra citato che descrive lo tzompantli. È un capitolo di vertiginosa fantasia. Enrigue fa scattare un corto circuito tra il secolo XVI e l’oggi, immagina che il conquistador spagnolo passeggi in mezzo ai templi della cittadella di Tenoxtitlan tenendo però presente l’attuale configurazione di Città del Messico, costruita appunto dove c’era Tenoxtitlan. Ciò induce lo scrittore a riflettere sulla diversa reazione tra il visitante spagnolo del XVI secolo, abituato all’esibizione davanti alle porte e sui ponti delle città europee dei cadaveri delle condannati a morte (oggi le vedrebbe in Iran) e gli auto de fe (e non auto da fé, come scrivono gli italiani), e il virtuale visitante di oggi se potesse vedere i templi come li si vedevano allora. La descrizione dello tzompantli e il passo seguente sono tratti dallo stesso capitolo.
“Visto dal secolo XXI, un secolo terrorizzato dalla finitudine del corpo, un tempio così risulta soprattutto sfrontato. Per uno spagnolo del secolo XVI, che aveva presenziato a guerre e auto de fe1, che aveva visto i ribelli del suo tempo morire, imputridire e seccarsi in gabbie sospese sulle porte delle città, dovette sembrare anche sorprendentemente igienico nella sua rappresentazione di ciò che la vita ha necessariamente di macabro. I pavimenti bianchi, i muri bianchi, i teschi ripuliti ormai bianchi, tutto santificato dalla geometria. Non era una rappresentazione esemplare del dolore al quale conduce un errore di condotta, bensì il disegno delle cose come sono: dentro abbiamo un teschio, è ciò che resterà quando ce ne andremo, grazie per partecipare.
“Se Caldera avesse fatto la sua passeggiata vestito alla castigliana e in compagnia degli altri capitani, avrebbe dovuto scuotere la testa con riprovazione per dare testimonianza del suo orrore, si sarebbe dovuto fare il segno della croce. Solo e travestito da colhua, avrebbe trovato il huei tzompantli intensamente cristiano – polvere siamo – soprattutto edificante, come forse lo sarebbe per noi se potessimo disfarci della nostra superiorità morale come parte di società che gli stermini li compiono di nascosto. Lo avrebbe visto come ciò che è: un trionfo del disegno”. pagg. 161.162.
“Colhua” è il nome della popolazione azteca, la cui lingua è il nahuatl.
Ogni pagina è da antologia, non solo per la finezza della scrittura, ma anche per la penetrazione della psicologia dei personaggi. La vita quotidiana degli aztechi e dei conquistadores è resa con visionaria fantasia. Ma anche con sovrano distacco, con continua ironia: il messaggio sottinteso è che la barbarie di cui accusiamo quelle popolazioni non sia poi così diversa dalla nostra di oggi. Solo che oggi, noi, gli orrori li facciamo di nascosto, li nascondiamo. Salvo poi a strapparci i capelli quando vengono alla luce. O credevamo che la guerra in Ucraina fosse un gioco di fioretti? che la Russia infranga un patto che noi invece rispettiamo, di non invadere un altro paese? La tragedia della guerra ucraina è che invece ci riporta proprio agli anni in cui tutti, chi di più chi di meno, ci siamo macchiati di atrocità invadendo un altro paese. Anche noi italiani: per esempio, in Etiopia. O in Slovenia. Le pagine finali ci ricordano proprio questo, il “sogno di Cortés” che chiude il romanzo arriva fino alle guerre del secolo XIX, XX, a Zapata, a tutto ciò che studiamo a scuola come cosa che non ci riguarda più, perché un orrore passato, finito. Enrigue ci avverte che invece non è passato, continua, continua ancora. E nessuno può dichiararsene innocente. Forse, le pagine finali, dopo il raffinatissimo ricamo delle pagine precedenti, la capillare narrazione di ogni atto e pensiero dei personaggi, possono apparire frettolose, sbrigative: 18 pagine contro 202. Ma potrebbe essere calcolato, essere l’esplosione di un fulmine. Ipocrita lettore, hai letto, e appreso, quanto sottile sia stata, nel passato, la preparazione del male. Impara a vedere quanto oggi possa essere fulminea. Giustamente, Stefano Tedeschi, sul “Manifesto” del 18 luglio 2021, recensendo la traduzione italiana di Ahora me rindo y eso es todo, il precedente romanzo sulla figura di Geronimo, scrive: “L’ampiezza degli spazi e la complessità della storia richiedono un intreccio di fili narrativi e di generi letterari diversi che si inseguono nelle pagine del romanzo: il viaggio dell’autore con la sua famiglia ha i tratti del saggio e il respiro della riflessione; il racconto del rapimento della donna bianca – tema cruciale di tanta narrativa americana – e della successiva ricerca da parte di uno sgangherato plotone guidato dal capitano Zuloaga, si svolge con il piglio dei migliori romanzi d’avventura, mentre nella parte chiamata «Album» una serie di testimoni ricorda gli incontri con Geronimo, con una focalizzazione dispersa in cui si inseguono ricordi e fantasmi. Il romanzo storico diventa così anche molto altro, un libro sulla frontiera quando quella frontiera ancora non esisteva: Álvaro Enrigue lo costruisce in modo da far specchiare i confini del passato con quelli contemporanei, permettendoci di capire come quella linea sia ancora una «ferita aperta» dove per sopravvivere, come diceva Gloria Anzaldúa, «you must live sin fronteras / be a crossroads”. Tedeschi tocca i due punti fondamentali della scrittura narrativa di Enrigue: l’intreccio di fili narrativi e il mescolamento di generi letterari diversi. Atteggiamento di scrittura che ha radici immediate nella tradizione narrativa latinoamericana, anche di lingua portoghese, oltre che “castellana”, castigliana, e affonda le radici nella fantasia sospesa tra realtà e sogno che è di tutta la letteratura spagnola, a cominciare dal Poema de mio Cid, il poema nazionale parallelo o gemello della francese Chanson de Rollant, ma che oltrepassa il realismo cavalleresco per inoltrarsi nelle regioni delle scelte individuali di vita. Proprio da questo inoltramento può nascere nel tardo rinascimento e primo barocco un capolavoro come il Don Quijote. La strumento che intreccia i fili e riannoda i percorsi labirintici della fantasia è l’invenzione di un prosa che sembra inventare passo passo la sua lingua. A cominciare dall’appartenenza dei conquistadores, castellanos, castigliani, dunque spagnoli, ma che con vocabolo nahuatl sono chiamati caxtiltecas, castiltechi. Lasciatevene conquistare, se conoscete la lingua spagnola. O attendete che anche questo romanzo di Enrigue sia tradotto in italiano. Vi troverete trasportati in una sfera fantastica di narrazione imprevedibile, non diversamente che se leggeste le pagine di altri grandi narratori (e qualcuno anche poeta) messicani, Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes. Enrigue, di nuovo, aggiunge il disincanto di chi non solo non si fida più degli strumenti del realismo, ma, dopo averli assimilati, scavalca anche i sotterfugi delle avanguardie.
Álvaro Enrigue, Tu sueño imperios han sido, Barcelona, Anagrama, 2022
1L’espressione corretta è “auto de fe”, con il “de” e senza accento su “fe”. In italiano ha finito con il prevalere l’italianizzazione equivoca di “auto da fé”, adottata anche da Montale.





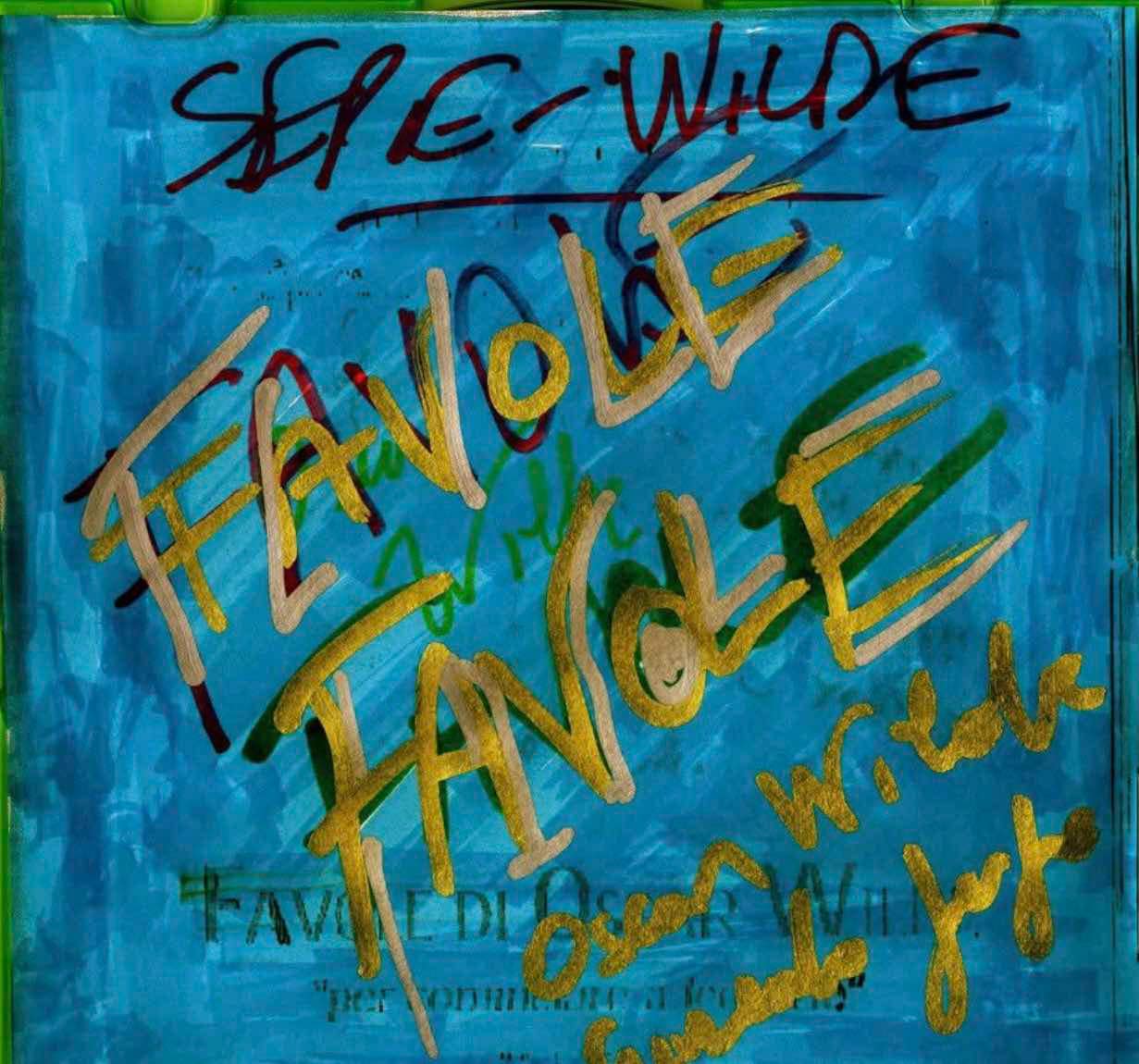

Devi fare login per commentare
Accedi