Letteratura
Libro dei Fulmini, l’esordio di Matteo Trevisani
Una Roma misteriosa ed esoterica. Questa la protagonista indiscussa dell’esordio di Matteo Trevisani, Libro dei Fulmini, di cui pubblichiamo il primo capitolo.
L’anno della mia morte era iniziato bene. Ero riuscito ad accomodare e a ripiegare certe ambizioni dolorose e mi ero messo diligentemente a seguire il flusso delle cose che capitavano. Lavoravo in una piccola casa editrice che pubblicava libri di spiritualità e filosofia. Il lavoro mi piaceva e pagava l’affitto di una camera in un appartamento pieno di libri a San Giovanni da cui, se mi sporgevo abbastanza dalla finestra del salotto rischiando di cadere nel giardino condominiale, riuscivo a vedere un pezzetto di cattedrale.
Da qualche tempo avevo cominciato ad andarmene in giro per Roma, da solo, a scoprire cose che la memoria di tutti aveva dimenticato. Da poco ne scrivevo per una rivista, amavo i musei abbandonati e le chiese senza più storia, i templi romani obliati e le scritte che si vedono sopra le mura della Domus Tiberiana, sul Palatino. Abitavo a Roma da più di dieci anni, ma come ci si innamora della migliore amica, che alla fine è quasi una sorella, io avevo preso a meravigliarmi di Roma quasi che al mondo non fosse mai esistita altra città che lei.
Non avrei mai potuto immaginare che, mentre per la prima volta mi pareva di vivere una vita tranquilla, senza bruschi stordimenti dell’animo, il destino preparava per me un viaggio. Un viaggio di ritorno attraverso il mondo dei morti.
Del posto in cui ero nato non mi rimanevano che vaghe allusioni alla sabbia fine di una spiaggia che si confonde con una palude, i ricordi di una giovinezza felice abbastanza e l’illusione provinciale che nessun luogo potrà mai andare bene a chi è stato abituato a lavare i suoi pensieri nel mare.
Me ne ero andato dalle Marche a diciotto anni per studiare filosofia a a Roma. La prima volta che la vidi ebbi l’impressione di conoscerla da sempre. Pensavo davvero che una città fosse la forma umana più elevata, lo spazio dove lo spirito dell’uomo si è espresso al suo meglio. E nei miei pensieri la città non era diversa dalla natura, ma qualcosa che procedeva da essa. Le colonne dei templi erano gli alberi dei boschi sacri, le sue piazze erano laghi, le sue vie stretti sentieri impervi di montagne incantate. Per questo, la sola città degna di tale nome non poteva che essere Roma.
Io e mio padre avevamo percorso in macchina l’autostrada per lasciarmi a vivere da solo in un luogo che non aveva porti sul mare, e pescherecci che dondolano sui suoi moli, né un faro che illumina la nebbia delle notti invernali.
Ero cresciuto rassegnandomi all’idea di non avere che poca storia e poco passato. Tutta la mia genealogia si risolveva consumandosi nelle vocali chiuse del dialetto di mia nonna, in una certa durezza del cuore, in vecchi pescatori stranieri che risalivano dal porto come anime perdute e nel viso che avevano i miei genitori e i miei fratelli quando guardavano il mare, lo stesso che provavo ad avere io, ma con un timore scomposto e affettato, come se non sapessi bene cosa aspettarmi e soprattutto se ne fossi degno.
Roma era tutto l’opposto, era la storia gloriosa, il passato influente, i cardini sui quali erano girate per quasi un millennio le porte che aprivano il futuro del mondo. Eppure non riuscivo a riconoscere una differenza netta tra quei due luoghi. Era come se, in una dialettica continua, riuscissero a dialogare dentro di me, parlando di quello che mancava loro, e dei popoli che avevano abitato quelle terre prima della storia.
Di quel primo viaggio ricordo il casello, immerso tra i pini ma- rittimi che circondano Roma e che crescono di fianco alle sue strade periferiche, quelle in cui passi distraendoti, guardando di sfuggita brutte chiese grigie in mezzo alla ghiaia di parcheggi abbandonati, negozi di lampade e stazioni di polizia, discariche abusive e sobborghi in cui di mattina presto uomini stanchi guidano vecchie auto per andare a lavorare fuori dal raccordo. Imparai a riconoscere quel primo paesaggio, e col tempo mi divenne familiare, e seppi che dei molti linguaggi che una città usa per comunicare con te i suoi desideri, le sue vacuità, le sue speranze, quello del paesaggio è il più immediato eppure il più difficile.
Mi chiedevo se Roma avesse ancora un destino che la riguardava, e se quel destino si sarebbe incrociato con il mio. Mi domandavo, passando lo sguardo sulle biforcazioni dei rami dei pini, se fosse una cosa che avrei dovuto desiderare o se facesse semplicemente parte della mia vocazione: ancora non conoscevo le leggende dei suoi parchi e i sotterranei delle sue ville, né gli altari di divinità perdute che a volte ingegneri timidi trovano e ricoprono subito sotto il fondaco dei palazzi del centro, come lapidi poste in silenzio su cose che devono essere taciute.
Mi sembrava di entrare dentro la città di soppiatto, alla stregua di un ladro. Appresi presto però che, quando ne fai parte, sfuggire al destino di Roma è impossibile.
Avevo capito dalle mie prime perlustrazioni, incantato e indispettito allo stesso tempo dalla prontezza con cui può rendersi indisponibile, che Roma è una città fatta di carne, di ordini sparsi, di congiunzioni disordinate che acquistano un senso solo quando impari ad avere un punto di vista. A Roma il punto di vista è tutto. Puoi limitarti per anni a scrutarne le prossimità, a tracciarne i contorni con il dito sui suoi belvedere e a meravigliarti dei colpi d’occhio, delle profondità estreme delle architetture, delle linee perfette che quartieri in espansione hanno frastagliato sui profili dei colli.
Ma poi qualcosa succede. Mentre stai passando per l’ennesima volta con un motorino per la solita strada, una diversa buca nel terreno, la luce che colpisce di sbieco certe facciate di chiese mai viste, gli uccelli che volteggiano a vortice ti fanno capire per un solo istante di non essere veramente nel posto in cui sei, ma di vivere quel tempo e un altro nello stesso momento.
Vagavo a caso, senza metodo, lasciandomi frastornare dalle quantità di cose che in tutti quegli anni mi era capitato di guardare e che non avevo mai visto. Le edicole alla Madonna, le guglie, i mascheroni terribili di certe biblioteche d’arte, i mattoni rossi in mezzo al cemento armato, il granito rosa degli obelischi. Gli articoli che scrivevo erano quasi una scusa, mi pareva che Roma fosse la sola cosa mi fosse dato di avere, continuavo a picchiettarne i fianchi, chiedendole il permesso di entrare, pregandola di lasciarmi vedere quello che ero sicuro venisse mostrato ai prescelti. Senza rendermene conto pregavo di essere ammesso a quel segreto di significati multipli, per arrivare al fondo della verità come si arriva al fondo del proprio essere, del proprio carattere o della propria sorte.
Era questo che rendeva chi vedeva davvero Roma una specie di iniziato degli antichi culti: sperimentava il passaggio da una condizione in cui la realtà è semplicemente quella che appare a uno in cui la realtà è doppia, e i cui significati sono come ancore che aiutano chi vuole perdersi a perdersi del tutto. Mi chiedevo come avrei fatto ad accorgermi di essere diventato uno di loro, una di quelle persone che camminano per le strade e hanno consapevolezza di quello che vedono.
Sarei stato in grado di riconoscere ciò che è invisibile, e quindi perdermi nei segreti di Roma senza inabissarmi per sempre, senza scomparire di fronte alla grandezza dell’assoluto, senza diventare pazzo?
Pubblichiamo un estratto di “Libro dei Fulmini” (Atlantide Edizioni, pp. 176) esordio di Matteo Trevisani. In “Libro dei Fulmini” Matteo Trevisani mette in scena un personaggio che porta il proprio nome e, insieme a lui, conduce il lettore in una immersione vertiginosa attraverso i tempi e i segreti di Roma, in un viaggio che lungo le tracce di un antichissimo culto dei fulmini e dei luoghi segnati dalle saette cadute sull’Urbe arriva al regno dell’oltretomba e di nuovo qui, nella terra dei vivi, o almeno di chi si crede tale. Scandito da uno stile aspro e ritmato idealmente basato sulla tradizione romana arcaica delle scienze augurali e interamente tramato su fonti latine antiche, il “Libro dei Fulmini” è allo stesso tempo una storia avvincente di morte e rinascita che si snoda tra due dimensioni e due mondi, e un originale e sorprendente romanzo di formazione tra storia, filosofia ed esoterismo.
Matteo Trevisani è nato a San Benedetto del Tronto nel 1986. Redattore di Nuovi Argomenti ed editor di Edizioni Tlon, si occupa di filosofia, storia delle religioni e boxe. Ha collaborato con diversi giornali e riviste. “Libro dei fulmini” è il suo primo romanzo.


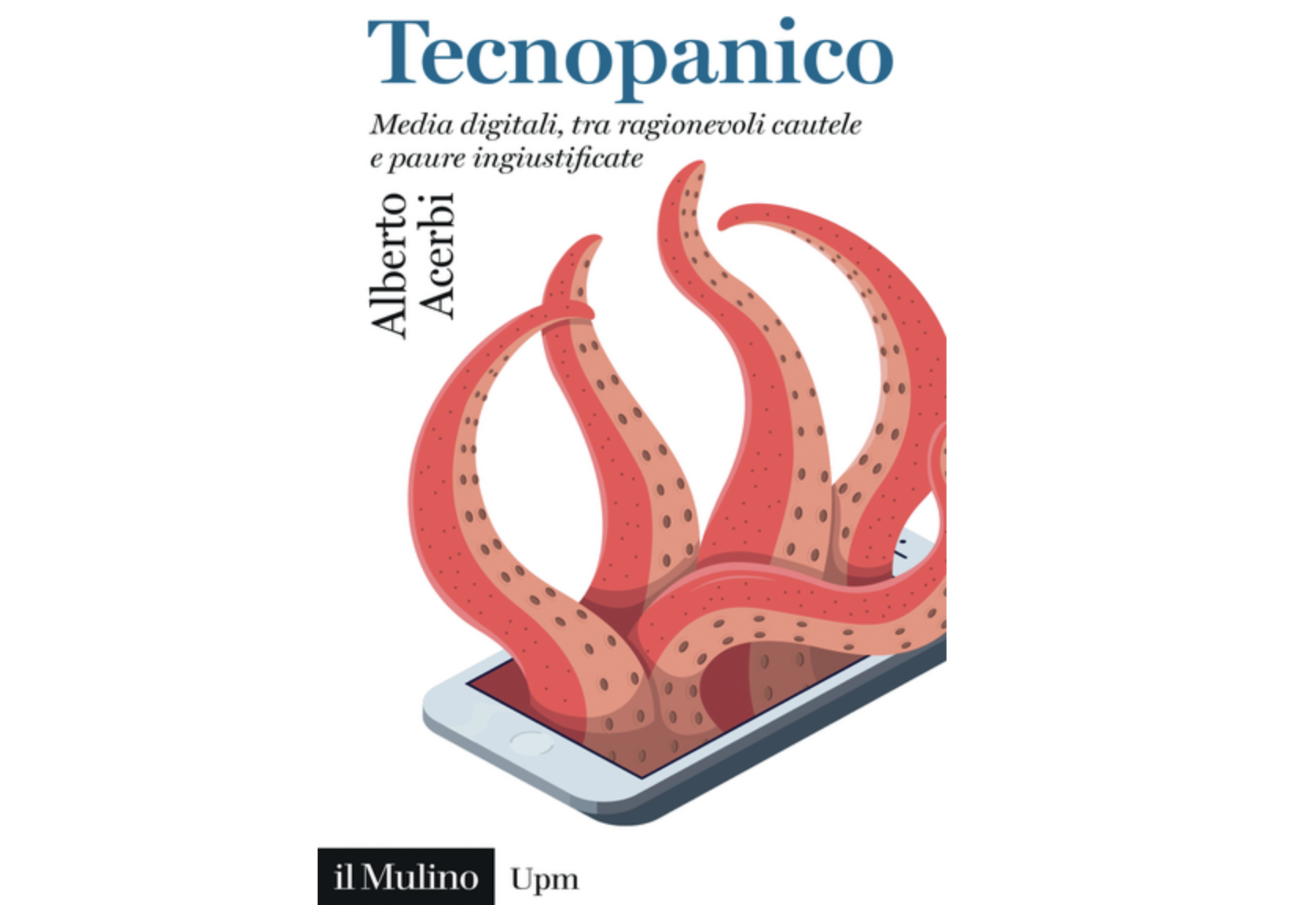
Devi fare login per commentare
Accedi