Letteratura
In guerra: il libro del fotoreporter Gabriele Micalizzi scritto con Moreno Pisto
Il fotoreporter Gabriele Micalizzi sopravvissuto a un razzo dell’Isis ha scritto un libro insieme al giornalista Moreno Pisto in cui racconta la sua vita, dalle case popolari di Cascina Gobba alla guerra in Siria.
Dal 2004 al 2005 Gabriele Micalizzi si occupa di cronaca per l’agenzia Newpress di Milano. Nel 2008 fonda, insieme ad altri colleghi, il collettivo fotografico indipendente CESURA, sotto la direzione artistica di Alex Majoli, fotografo della Magnum. Nel 2010 inizia la carriera come fotoreporter in zone di conflitto. L’11 febbraio 2019 sopravvive a un attacco di RPG da parte dello Stato Islamico. Testimonial Leica dal 2016 e primo vincitore del Master of Photography, collabora con quotidiani nazionali e internazionali tra cui «New York Times Magazine», «Herald Tribune», «New Yorker», «Newsweek», «Stern», «Corriere della Sera», «la Repubblica», «Internazionale», «Wall Street Journal».
https://www.youtube.com/watch?v=gdbLIS9MV3E
Moreno Pisto (1979) ha scritto Vasco per maestro. Tutto quello che ho imparato dalla vita e che spiegherò a mio figlio (Sonzogno 2011) e Motorcycle Rockstar (Ultra 2015). Direttore di «Riders» e «Urban», oggi è il brand and content manager di AM Network (Automoto.it e Moto.it). Insegna scrittura digitale in Accademia di Comunicazione. Scrive per writeandrollsociety.com, sito dedicato alla cattiva scrittura che ha fondato nel 2011.
Pubblichiamo volentieri un estratto (la prima parte dell’ottavo capitolo) del libro scritto a due mani, IN GUERRA, vita e battaglie del fotoreporter sopravvissuto a un razzo dell’Isis.
Sta andando tutto alla grande. Forse per la prima volta nella mia vita.
Un giovane trapper, Tedua, mi offre di diventare l’art director dei suoi lavori, la mia campagna per Nike viene premiata come la migliore in Europa, a Parigi, la coper- tina dell’ultimo numero su carta di «Rolling Stone Ita- lia», con Pierfrancesco Favino, è la mia. Va tutto alla grande, appunto, in tante cose. A parte i soliti casini della mia vita, intendo: la famiglia che non vedo mai perché sono sempre in giro, il fatto che sto poco con Tecla e Guenda, che Ester si incazza perché è stanca, e ora non ho più neanche un’auto, perché la mia Audi A4 cabrio del 2003 è stata rubata. In quei giorni mi chiama Fausto Biloslavo: è final-mente riuscito ad avere i permessi per fare un’intervista a un terrorista italiano in Siria. Ci aveva messo sei mesi per averli mi spiega e sarebbe stata trasmessa da Porta a Porta. Poi sempre in quei giorni anche Francesco Semprini della «Stampa» mi ingaggia per fare un reportage e decidiamo di partire io, Biloslavo e Semprini. Un terzetto niente male. Una cosa tranquilla. Vado, faccio l’inter- vista, ritorno.
Prima di partire, vado da Lù-po.
Parlo di progetti futuri.
Trovo la carta per terra tra due sedie: il joker a figura intera.
La metto nel portafoglio con il due di picche.
Con Fausto e Francesco decidiamo di passare dal Cairo per non essere controllati a Istanbul. Non portiamo i nostri giubbetti antiproiettile, li affitteremo lì. La mattina, appena arrivati, andiamo subito dai curdi. Il capo dell’intelligence è un nostro amico, conosciuto ai tempi dell’assedio a Kobane. Nessun problema, ci fa i lasciapassare per l’intervista e per andare in giro. Ci indiriz- ziamo verso la base in cui i curdi tengono il terrorista italiano: un tipo piuttosto anonimo, che probabilmente aveva trovato nella lotta un senso della vita. Veniva da Brescia, si era affiliato all’Isis in Germania ed era stato addestrato da uno dei gruppi più feroci, quello dei ceceni, proprio in Siria. Ci racconta che i peggiori sono i russi, i più duri, i più cattivi, senza misericordia. Dice che non ha mai fatto niente a nessuno e che non ha mai partecipato a niente di grave, ma mentre lo riprendo per il video penso che non è vero, sta mentendo, fa tut- to il bravo ragazzo ma in realtà è un figlio di puttana. Spiega che in Siria ha pure fatto tre figli e che la vita nello Stato islamico alla fine è semplice ti danno 150 dollari al mese se non hai famiglia, 400 se hai famiglia più macchina e fucile, stai quasi sempre a casa e quando esci ci sono i mega schermi in piazza su cui passano le immagini della propaganda e i video delle decapitazioni degli infedeli. Una specie di Disneyland del terrore. Lui nella causa ci ha creduto fino alla fine. Dopo la caduta di Raqqa era pronto a consegnarsi all’ambasciata italiana a Istanbul – sì, come no, penso – ma è stato venduto ai curdi da un contrabbandiere che gli aveva promesso di portarlo in Turchia. Il sistema, ricordava, funziona così: i contrabbandieri locali si accordano con i jihadisti che vogliono scappare dopo la caduta del Califfato per portarli in Turchia; in realtà, li consegnano agli americani come prigionieri. Così hanno un doppio guadagno. Una combo perfetta. Bingo.
Dopo l’intervista decidiamo di andare al fronte solo per due giorni: uno con i profughi, l’altro sulla front line. Ma quella sera succede una cosa che mi cambia l’umore. Qualcosa comincia a non tornarmi, a mettermi a disagio.
Quella sera succede che sto montando il video del terrorista italiano per Biloslavo e altri tre brevi video per Semprini. Proprio a Semprini chiedo una chiavetta per passargli il materiale, mi risponde che non ne ha nemmeno una ma che mi può dare un hard disk. Ok. Il problema però è che il suo hard disk è difettoso, non posso aggiungerci niente. Quindi decido di inizializzarlo, solo che al posto del suo, per un errore inizializzo il mio. E perdo tutto, tutto il mio materiale.
Dramma totale.
Guardo la data e leggo: 8 febbraio 2019. Il giorno in cui due anni prima è morto mio padre. Mi tornano su insicurezze, rabbie, tarli che mi porto dietro nella mia vita privata, ma quando sei in guerra non puoi permetterti pensieri negativi; quando sei in guerra per assurdo è meglio non sentire nessuno per non farsi distrarre da notizie superflue, al massimo qualche WhatsApp, devi essere presente lì e solo lì, più hai pensieri e più sei a rischio errore, devi restare sempre con- centrato, anche se non succede niente per giorni interi, perché magari, all’improvviso, attaccano esattamente dove sei tu e la distrazione o un pensiero in più ti fanno perdere l’occasione di sopravvivere. Provo a recuperare i file ma non ce la faccio. Per fortuna anche Biloslavo aveva girato del materiale e impacchetto tutto lo stesso.
Quella notte però sto male, non riesco a dormire. Qualcosa, appunto, non mi torna.
Il giorno dopo andiamo subito in frontline ma non c’è molto da fare. Stiamo sui tetti a riprendere e a cinquecento-seicento metri di distanza vediamo quelli dell’Isis che camminano per strada. Sono vicinissimi, li vedo bene a occhio nudo. Ci bombardano all’improvviso ma con poca convinzione. La sera torniamo alla base e ci muoviamo sui mezzi blindati dei curdi. Mi presentano il team della CNN, tra cui Adam, il security advisor arrivato un mese prima, e Gabriel, un video re- porter brasiliano, lì già da sei mesi. Adam è sulla cinquantina, molto secco, esperto, super accessoriato, con un kit di primo soccorso professionale, pronto per le peggiori evenienze; Gabriel molto alto, fisico da surfista, sprezzante del pericolo.
Il giorno dopo mentre siamo nel campo profughi i curdi ci dicono che l’indomani saremmo potuti andare più avanti, su una collina dove l’Isis sparava di brutto.
Francesco e Fausto decidono di ripartire.
Io fino a quel momento avevo lavorato solo per i loro video e non avevo fatto nemmeno una foto, quindi preferisco fermarmi ancora qualche giorno, e resto a Baghuz con la troupe della CNN e l’esercito curdo. I curdi sono tutti giovanissimi e la guerra la combattono in ciabatte, le ciabatte con la fibiona: sono piuttosto avventati e io continuo ad avvertire che non sono a mio agio, non è una bella situazione.
Quella notte dormo meglio, ma a un certo punto Gabriel mi sveglia dicendomi: «Oh, siamo sotto attacco». Quelli della CNN erano provati, l’Isis gli aveva tirato un razzo veramente vicino. Adam ci consiglia di andarcene, ma un plotone di trecento curdi si prepara per proseguire l’avanzata e io e Gabriel decidiamo di aggregarci. Chiedo a Adam di tenermi lo zaino perché almeno posso camminare più leggero, visto che ho già l’attrezzatura, l’elmetto e il giubbotto antiproiettile, che messi insieme fanno più di trenta chili. Adam mi dice: «State attenti, è veramente pericoloso». Lo ripete un paio di volte e poi va via. Noi proseguiamo per un chilometro e troviamo un buon punto dove lavorare. Non siamo in prima linea ma da lì abbiamo una buona visuale per fare video e scattare foto. Ci restiamo circa una mezzoretta, poi il bisogno di andare in bagno si fa troppo insistente, allora vado in una casa e cerco un posto dove appartarmi. È una casa occupata, completamente distrutta, trovo un quaderno di un bambino scritto in arabo di matematica lo prendo e lo porto con me, scelgo un angolo con il pavimento sfondato, cago e mi pulisco con le pagine scritte da quel bambino. Quante volte mi sono trovato a fare cose che non avrei mai immaginato, ma la guerra è così: ti mette alla prova in continuazione. «Parlami di soluzioni, non di problemi»: questa è la frase che era affissa sulla scrivania dell’ambasciatore italiano in Ucraina. That’s it.
Quando esco Gabriel mi dice che conosce il capitano curdo che sta proprio in primissima linea e mi fa segno di andare avanti. Lo seguo. Corriamo tra i campi abbandonati, le strade vuote, i mattoni delle case caduti in queste vie polverose che separano costruzioni lasciate marcire, chissà chi ha mai avuto il coraggio di viverci qui, penso, e a un certo punto in strada ci siamo solo io e lui. Gabriel mi dice di non stare a sinistra mentre camminiamo, vicino ai muri degli edifici, perché potrebbe esserci qualche esplosivo. Gli rispondo che non possiamo neanche stare in mezzo alla strada, saremmo troppo esposti. Lì mi accorgo che non sapeva muoversi benissimo, era poco cauto. Perché camminare così, da soli, è una follia. Corriamo e arriviamo vera- mente avanti, quasi alla fine della front line, e quando vediamo l’avamposto ci fiondiamo dentro. Io tossisco, mi manca il fiato, pago tutte le sigarette fumate in quei giorni, avrei voglia di liberarmi dei dodici chili di giubbetto ed elmetto che ho addosso ma non lo faccio, anche perché tutte le volte che mi viene in mente di togliermeli sento la voce di Fausto Biloslavo che mi dice «testa di cazzo mettiti le protezioni», con quello stesso modo di fare che aveva mio padre, perché se le hai te le devi mettere.
L’avamposto è una palazzina diroccata a due piani e il capitano – si chiama Baghuz, come la città – ci fa segno di salire. Approdiamo su una classica terrazza sul tetto. Baghuz ha un fucile M60, il giubbetto anche lui come noi e una tipica sciarpa curda, leggera, come una bandana. Faccio un video ai blindati curdi ma il mitra si inceppa due volte. Bestemmio. Dopo circa tre minuti il capitano mi prende per mano e mi indica la bandiera dell’Isis. Guardo il territorio: è un postaccio, un villaggio nella piana, tutto piatto, con piccole colline di sab- bia dura e poi un dislivello, un crostone desertico che prosegue verso il fiume. Intorno ci sono un paio di casette arabe basse, distrutte.
Strade di fango.
Vegetazione rara.
C’è il sole, ci sono le palme, un clima umido, la polvere che ti si appiccica addosso.
Fotografo la bandiera dell’Isis.
E dove c’è la bandiera, al primo piano di un palazzo, li vedo: i nemici.
Sotto quel palazzo c’è un camion per il trasporto della benzina o un camion rimorchio, non lo so, intorno al camion tre uomini.
Dentro al camion altri uomini.
Saranno neanche a cento metri di distanza.
Penso che lì dove sto sono troppo esposto, perché se vedi degli uomini a cento metri significa che altri sono più vicini.
Penso che l’ideale sarebbe ripararmi dietro la porticina alle mie spalle. O almeno contro il muretto.
Mi giro.
Vedo un ragazzo curdo con una macchia in faccia, proprio dietro a quella porticina sul tetto. Lo guardo, incuriosito dalla sua ferita, e gli chiedo se gliela posso fotografare. Lui mi dice di no, io ci penso un attimo, mi giro da un’altra parte e faccio una foto ai mezzi blindati parcheggiati sotto di noi.
Poi sento quel cazzo di fischio.
Il rumore è un po’ come quello che si sente nei padiglioni o nelle palestre, quando tiri forte e la pallonata colpisce il telone di plastica. Prima fa spench e poi èèèèèèèèèèè.
Sento il rumore e sono per terra.
Vedo il capitano e un altro ragazzo per terra. Soffro- no.
Il capitano aveva un giubbetto super serio, deve essere stato colpito al collo, l’unico punto scoperto.
Il soldato accanto a me è esploso. Si è disgregato.
Non sento più niente.
Primo pensiero: porco il demonio, è esploso l’RPG.
Due: dovevo stare dietro al muretto, lo sapevo. Mi dovevo spostare. Volevo farlo. Perché non l’ho fatto.
Tre: penso, ora torno indietro come succede nei videogame e riparto dal momento prima che mi colpissero, solo che mi sposto, mi metto da un’altra parte, scendo giù da questa palazzina maledetta e il razzo se ne va affanculo.
Quattro, connetto: e invece no non è un videogame. Non è possibile un’altra vita. Non si torna indietro, questa è la vita.
Cinque: va be’ è il mio momento, muoio così, alla fine dai non ho avuto una brutta vita, sono morto facendo quello che amo e basta. Mi dispiace per Ester e per le mie bimbe, però le avevo preparate. Come sono preparato io.
Bushido.
Hagakure.
Il samurai accetta la pioggia, sa che non ha scelta. Sei: a terra c’è pieno di polvere.
Mi sento il braccio sinistro maciullato. E pieno di polvere. L’elmetto pieno di polvere, i capelli pieni di polvere, la polvere è persino dentro l’occhio. Ma non sopra, dentro. L’occhio sinistro me lo sento molle, la sensazione più brutta del mondo. Dentro quest’occhio mi sento qualcosa. Con l’occhio destro vedo il cielo. Il mio ultimo spicchio di cielo.
Porca puttana.
Capisco che sono grave perché non avverto più il corpo.
Forse sono a pezzi. Forse si è staccato qualcosa. Non riesco a muovere la testa.
Mi sforzo e muovo il braccio destro, mi tocco, controllo le gambe, il petto, mi tasto il giubbetto, tasto il braccio sinistro e sento che è spappolato ma attaccato.
Morirò con tutte le parti attaccate, almeno questo.
Sette: frappongo la mia mano tra l’occhio destro e il cielo, perché sento che le mie dita hanno qualcosa che non va. Guardo la mano e dico: vabbe’.
L’indice destro è fottuto aperto mozzato il medio è conciato di brutto, moncherino, senza più l’unghia. È strano, è girato, è pieno di sangue.
Con l’anulare cerco di capire come sta messo l’occhio.
Me lo tocco e l’anulare ci affonda dentro, l’occhio fa flosh.
Una cosa così schifosa non l’ho mai sentita.
Ritocco l’occhio un’altra volta, perché non ci credo.
Flosh.
Non urlo.
I signori non urlano.
Otto: veramente in un postaccio mi è successo. Sono stato uno stronzo.
Guardo il cielo e aspetto di morire dissanguato. Nove: non passa più.
Dieci: visto che non passa più, prima di morire fumo l’ultima sigaretta.
Cerco di prendere pacchetto e accendino nella tasca destra dei pantaloni, ma la mano monca non entra e non fa presa.
Undici: non posso nemmeno fumarmi l’ultima sigaretta. Vaffanculo.
Vedo il cielo, il mio ultimo cielo.
Vedo i boschi di Pianello, dove facevo il taglialegna: buttavo giù gli alberi, li tagliavo a pezzi, una fatica cane. Vedo Berlusconi in camice.
Vedo la casa di mia nonna, periferia nord di Milano, e tutto quel cemento triste che sa di degrado, di disperazione, di mancanza di prospettiva, cemento da cui desideravo solo andarmene ma più lo guardavo e più mi entrava dentro.
Vedo la finestra di casa mia che affaccia sulla stazione di Monza Sobborghi, dove ho fatto i miei primi tag, dove ho visto i treni che partivano mentre io re- stavo lì.
Vedo un ragazzo, giovane come me, mentre gli stecco una gamba.
Vedo la vestizione di una bambina morta, una delle poche cose che mi ha fatto effetto in tutte le guerre che ho vissuto, ma forse solo perché mi era appena nata la mia seconda figlia.
Vedo un uomo morire di infarto da quanto sta urlando.
Vedo uno sterno atterrare accanto a me mentre sto riprendendo i disordini.
Vedo un ragazzo cercare il corpo di qualche parente aprendo a caso un muro di cassetti, richiudendoli e ria- prendoli con calma, come se fosse un rituale, come se fosse un gioco a premi.
Vedo Andy, vedo sua madre che lo riconosce sul lettino dell’obitorio.
Ora come Andy anche io diventerò un corpo e un volto che qualcuno dovrà riconoscere.
Peccato, stavo andando benissimo con il lavoro.
Sento mio padre che mi dice: vai avanti Gabriele, vai avanti. Fottitene di quello che dicono. Vai avanti e vedrai…
Nemmeno l’ultima sigaretta. Vaffanculo.
Vaffanculo a me e a quello che sono.

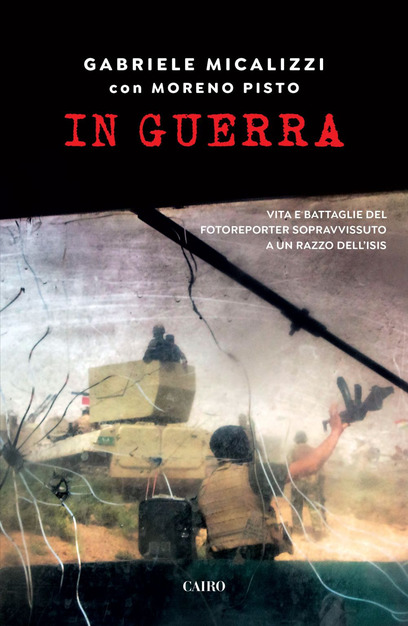
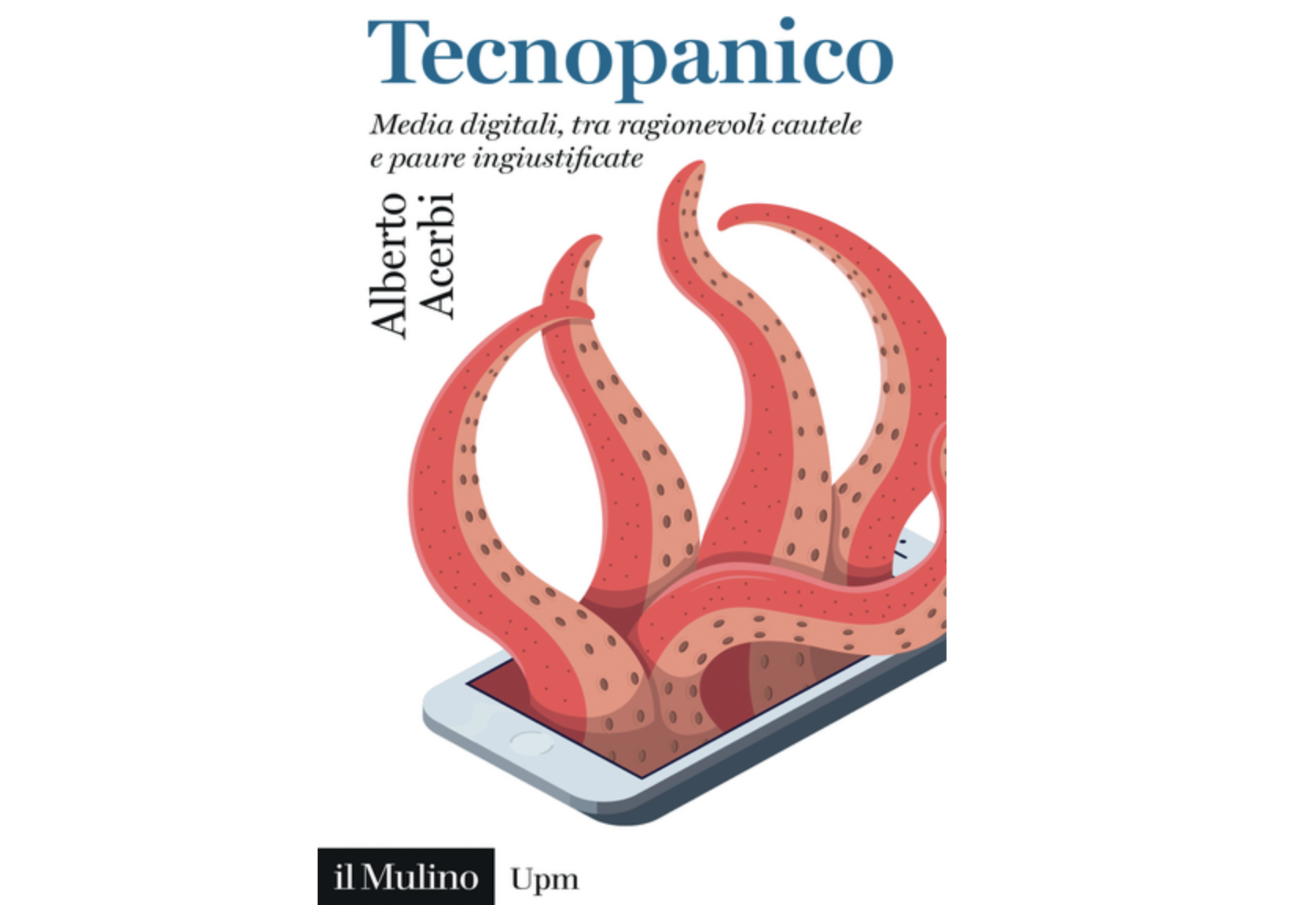
Devi fare login per commentare
Accedi