Letteratura
Il microcosmo austroungarico di Joseph Roth
Ho voluto riprendere in questi giorni la lettura dei romanzi di Joseph Roth, che mi avevano incuriosito e coinvolto più di trent’anni fa, con il proposito di dedicarmici fino all’estate, proprio per verificare se l’impressione positiva di allora permaneva anche dopo tanto tempo, successivi approfondimenti letterari, e l’inevitabile affinamento o, al contrario, inaridimento emotivo. Prendendo spunto dalla recente riproposta delle edizioni Passigli, ho iniziato il mio percorso rothiano da un romanzo che mi aveva colpito per il suo disegno caleidoscopico, un vero e proprio microcosmo di caratteri particolari: Hotel Savoy. Di un altro libro di poco successivo, Fuga senza fine, si stagliava ancora nella mia memoria la sagoma del protagonista, il tenente dell’esercito austriaco Franz Tunda, uomo futile e inane, che la lapidaria frase conclusiva condannava a un inesorabile fallimento: “Superfluo come lui non c’era nessuno al mondo”.
Di Hotel Savoy, invece, non ricordavo tanto la figura del personaggio principale, quanto la struttura rutilante dell’affresco. Apparso per la prima volta nel 1924, è la seconda prova narrativa di Roth e segna già il suo approdo a una piena maturità stilistica. Narra le vicende del giovane reduce Gabriel Dan, che dopo essere stato prigioniero e aver vagato nella Russia rivoluzionaria per tre anni, arriva in una cittadina dell’Impero asburgico, Lodz – oggi polacca – dove vivono alcuni membri della sua famiglia di origine ebraica. Si presenta, sporco e denutrito, alla reception del raffinato e austero Hotel Savoy, un edificio di sette piani, chiedendo di occupare una stanza, “Sono contento di togliermi di dosso una vecchia vita, come ho già fatto tante volte in questi anni. Vedo il soldato, l’omicida, il quasi ucciso, il risorto, l’incatenato, il viandante”. Gli assegnano una camera al sesto piano, e da subito comprende che il livello dei piani corrisponde al ruolo sociale ed economico degli ospiti. In basso la clientela più ricca e rispettabile, in alto i più poveri e screditati. Il proprietario dell’albergo è Kaleguropulos, un misterioso signore greco che sorveglia dal suo ufficio gli affari e il comportamento di tutti, senza mai farsi vedere, circondato da una fama di terribile severità. Factotum e addetto all’ascensore è il vecchio Ignatz, individuo losco e ambiguo, che ricatta gli ospiti debitori spogliandoli dei loro miseri averi in cambio di prestiti e dilazioni sul conto mensile. Intorno tutto un brulicare di esistenze e figuranti incredibili: ballerine, clown, ipnotizzatori, caricaturisti, ma anche medici, notai e affaristi, tutti “trattenuti da qualche sfortuna”, accomunati da un destino di sofferenza e umiliazione, con vite spezzate dalla guerra, fallimenti economici, malattie e voglia rabbiosa di riscatto.
Tra loro, Phöbus Böhlaug, lo zio di Gabriel ricco e avaro che gli rifiuta qualsiasi appoggio, con atteggiamenti di farisaico paternalismo, e il figlio di lui Alexander, vanesio e libertino, pago di umiliare gli altri vantando le sue conquiste sentimentali e finanziarie. Poi alcuni equivoci industriali e commercianti che la sera si riuniscono in una saletta sotterranea dell’albergo a bere e a godersi le esibizioni di spogliarelliste. E il plutocrate Bloomfield, tornato dall’America per rivedere la città natale e visitare la tomba del padre, ormai del tutto indifferente alle sorti politiche dell’Europa.
Esiste infine il sostanzioso gruppo dei falliti infelici, tra cui spicca la giovane e delicata Stasia, artista in varietà di terz’ordine, di cui il protagonista si innamora senza trovare mai il coraggio di dichiararsi. Il vecchio e mite pagliaccio Vladimir Sancin, che muore di tisi e viene sepolto in una fossa comune, accompagnato dal fedele asino con cui si esibiva negli avanspettacoli. Hirsch Fisch, che avendo perso il suo patrimonio, vende i numeri del lotto sognati di notte, e gira nei corridoi in mutande con il pitale in mano in cerca del gabinetto. L’amico croato Zvonimir, compagno d’armi di Gabriel Dan e come lui reduce dalla Russia, coraggioso fomentatore di scioperi e ribellioni sindacali. Intorno a questa variopinta umanità di senza Dio e senza patria, gravitante nell’albergo, cresce lo scontento e il rancore degli esclusi, dei disoccupati, degli emigrati dall’est, degli ex-combattenti, che infine esplode in una rivolta sanguinosa, culminata nell’incendio e nel successivo saccheggio del Savoy, simbolo di un mondo in disfacimento.
Joseph Roth (Brody 1894 – Parigi 1939) non è certo Thomas Mann, non è Schnitzler o Musil o Broch: non eccelle quanto i maestri novecenteschi della narrativa germanica, pur respirando la stessa atmosfera malinconica della finis Austriae: ma, forte della sua difficile esperienza esistenziale (esule dalla nativa Galizia a Leopoli, da Vienna a Berlino, da Francoforte a Parigi; volontario nella prima guerra mondiale e prigioniero in Russia; affascinato sia dall’ideale monarchico sia da quello rivoluzionario; fiero delle radici ebraiche eppure fedele al messaggio evangelico), il mondo che amava ritrarre non è quello intellettuale e alto-borghese celebrato dai massimi letterati di lingua tedesca. Giornalista curioso e polemico, inquieto viaggiatore, incostante negli amori e nelle amicizie, tormentato dalle malattie mentali dei parenti, irrecuperabile alcolista, finì i suoi giorni a Parigi nell’ospizio dei poveri, in preda a una crisi di delirium tremens. Quello era il suo mondo, descritto con onestà e pudore in tutti i romanzi maggiori (La marcia di Radetzky, La cripta dei cappuccini, Giobbe, La leggenda del santo bevitore): le periferie delle grandi città europee e i villaggi orientali ebraici, le basiliche gotiche e le sinagoghe, le bettole e palazzi imperiali. I suoi affreschi narrativi hanno tratti corali e fiabeschi, sarcastici e disperati; i suoi personaggi sono criminali e santi, gran dame e prostitute, usurai e banchieri: tutti umanamente dolenti, sopraffatti da un destino di morte e sofferenza. Come scrive in un’appassionata pagina di Hotel Savoy: “Stanno male gli uomini, il dolore si erge di fronte a loro come una grande muraglia. Se ne stanno avviluppati nel grigiore polveroso dei loro affanni e si dibattono come mosche prigioniere”.
JOSEPH ROTH, HOTEL SAVOY – PASSIGLI, FIRENZE 2020, p. 143

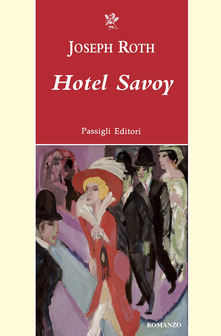


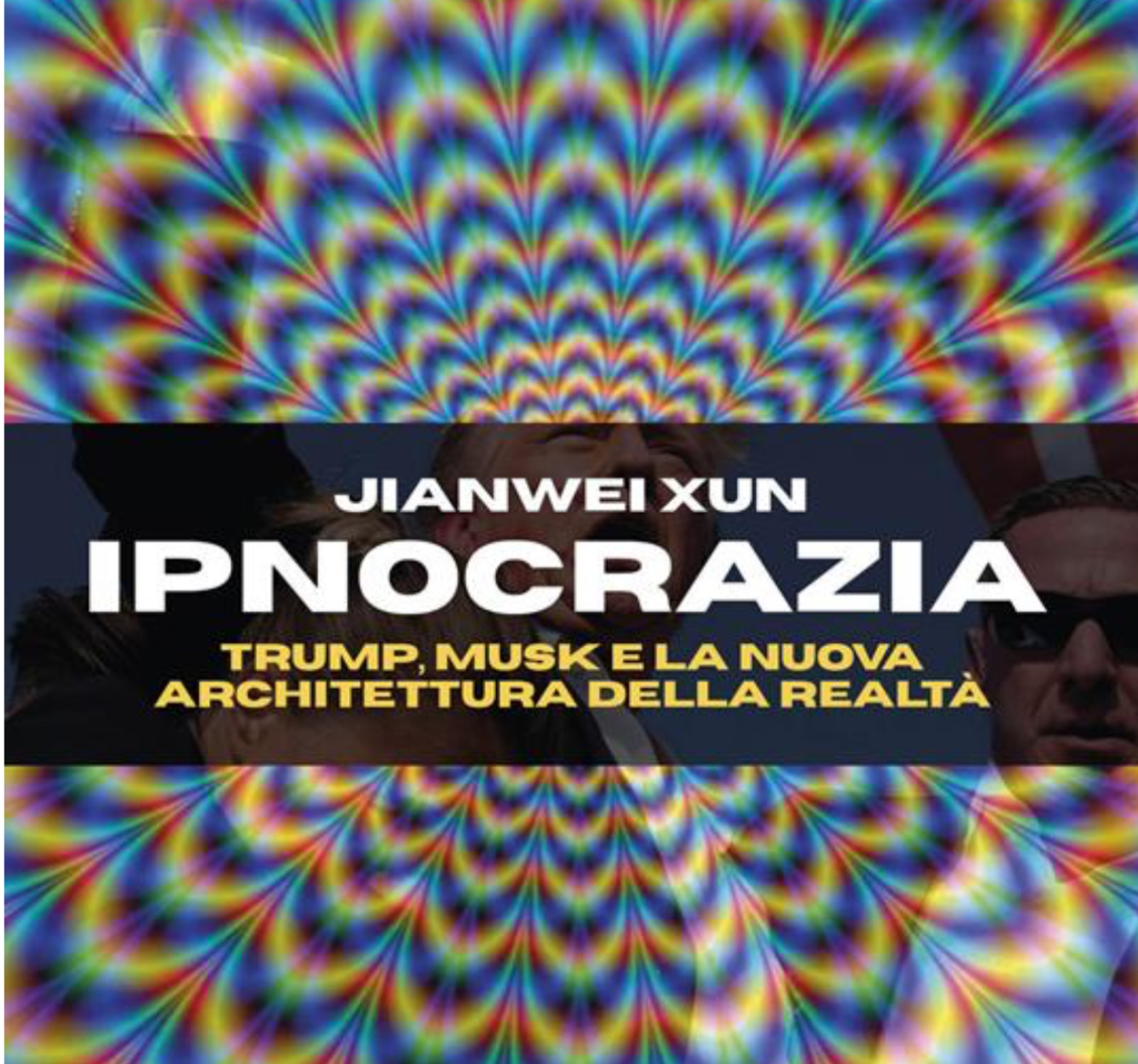
Devi fare login per commentare
Accedi