Letteratura
Hani
di Pier Paolo Giusti. Hani arrivò in azienda accompagnata dalla sua tutor, una donna sui quaranta dall’aria ansiosa e guardinga, con un pesante strato di fondotinta sul viso. Marta Righini, la nostra capo reparto, ce le presentò velocemente per condurle subito nella sua stanza per il colloquio di ingresso. Eravamo pochi a quella scena, ma quando Hani fu scomparsa alle nostre viste dietro quella porta maledetta, ebbi la sensazione che stessimo giocando ad un gioco di statue. Vincevo io, che ero il più ebete, il più fermo e quello sorretto dalle gambe più tremanti. E anche gli altri se ne accorsero, ovviamente. Sembrava che avessi disegnato sul viso qualcosa di storto, di maledettamente scioccante e palese. Hani, il suo volto e il resto di lei, mi avevano quasi stordito. L’avevo notata solo io? «Oh, ma che avete da guardare?» dissi per scrollarmi di dosso un’orda di sguardi.
Mi risero in faccia, i miei colleghi, ma furono innocui.
Sembravamo un gruppo di alunni che beccano un compagno che non sa dove nascondere una cotta colossale. Avevo fatto loro una certa tenerezza, credo. Finita la pausa di metà mattina tornammo di sopra mentre il terzetto con Hani usciva dalla stanza di Marta. La tutor, che poi non ho più visto, lanciava sguardi luminosi verso tutto e tutti accompagnati da sorrisi di fiducia. L’ansia era sparita dal suo volto, molto più disteso di quando era entrata. Marta stringeva mani, con l’ammiccare energico del leader che non è mai stata. Hani uscì dalla stanza e in un attimo fu in strada, come una piuma che vola via da una finestra.
Fino al lunedì successivo la ebbi in mente come una febbre insistente. Poi Marta mi si fece vicina.
«Le hai fatto i raggi ragazzo. Te ne sei accorto?» Assunsi svariate tonalità di rosso.
«No, non me ne sono accorto». Lei continuò a fissarmi. «Non è mica molto carino, sai?» continuò «Potresti mettere in difficoltà qualcuno». Facendo finta di non capire, cercai informazioni. «Perché è qua?» «Perché ha bisogno di noi e noi di lei, come sempre, fatti bastare questo».
Tra colleghi questo lo chiamiamo attacco armato. Si verifica almeno una volta alla settimana. Gli obiettivi su cui Marta sgancia le sue tonnellate di gelosia esplosiva sono nell’ordine: il sottoscritto, ovviamente, e tutte le mie iniziative di farmi piacere qualcuno che non sia lei. E chiunque abbia la doppia peculiarità di non essere Marta e di piacermi, per i più svariati motivi, almeno un po’.
«Ah, dimenticavo, la sua tutor interna sono io, ok?»
Ecco, fine dell’attacco armato. Alla fine di ogni attacco Marta strizzava sempre un occhio e sul campo rimanevano i resti fumanti della mia voglia di lavorare, i tentativi dei miei colleghi di capire come fosse andata con Marta e il mio mutismo per il resto della giornata.
Arrivò anche il lunedì che portò con sé novità e sensazioni, ma in silenzio. Hani prese posto alla sua scrivania e vi rimase immersa nella bellezza che aveva addosso, senza mai essere eccessiva. La novità fu proprio la sua bellezza che addirittura mi sembrava ancora più abbacinante. Mi trovai a gestire con qualche difficoltà la compulsione che avevo nel cercarne lo sguardo e il volto.
Scoprii che senza mai misurarsi in niente, Hani si mostrò intelligente e completamente all’altezza di ciò che le veniva affidato. Era gentile con tutti, generosa. Era più alta di me e di noi, in tutto. Lo era in maniera generale. Di lei sapevo il nome e il suo invio dal tribunale per un percorso di messa alla prova. Ne ignoravo i motivi, non li chiedevo a nessuno. Mi accorsi presto che il mio interesse silenzioso destava curiosità, ma se qualcuno provava adarmi notizie di lei, del suo passato o del motivo per cui aveva una pena da scontare, cambiavo discorso e mi affannavo con lo scopo di non saperlo. Come se non volessi inquinare l’immagine che di lei mi ero costruito, piuttosto in fretta, forse. Aveva alle spalle studi che la rendevano adatta ad un mucchio di mansioni dentro a un’azienda che si occupa prevalentemente di formazione in ambito sociale, progetti di prevenzione del disagio scolastico, reclutamento di risorse umane per vari ambiti di intervento sui minori. Io la cercavo continuamente tentando di non farmene accorgere. Oggi posso dire che lei faceva altrettanto, ma era molto più abile di me. L’ho scoperto solo perché un giorno me l’ha detto, sputtanandomi sui miei tic e i miei vizietti da scrivania. Io alzavo lo sguardo per cercarla, lei lo abbassava. Fu uno strazio indicibile il non affrontarsi. Quando uscivo per lavori e consulenze all’esterno mi trovavo a soffrire per averla lasciata lì perché si faceva strada in me la paura che qualcun altro la vedesse coi miei occhi e potesse sottrarmela. Si chiama gelosia, giusto?
Arrivò la primavera, che a me piove addosso tutti gli anni come una tempesta di meteoriti. Significa solo che il mondo continua a girare, come la mia testa, mi dico sempre. Significa che io continuo a soffrire l’alternanza di caldo e freddo, luce e buio. E ad ogni primavera si tiene la cena della BTP, l’azienda in cui lavoro. Pensai fosse una buona occasione per conoscere Hani. Ci saremmo finalmente conosciuti? Lo avrei scoperto. Quella sera durante la cena, io e Hani eravamo in posizioni strategicamente invisibili l’uno all’altra. Quella sera ci fu pure qualcuno che aveva fatto i segnaposto, mettendoci dentro pure un gran gusto. Io e Hani non ci scambiammo una sola parola. Io non sono uno di quelli che si alzano e vanno in giro per il tavolo a far battute ai commensali. Semplicemente, non ho battute da fare. Senza neanche poterla guardare mi annoiavo a morte. Il cibo era buonissimo, la serata fu insipida. Soffrivo abbastanza per non chiamare amore quello che mi succedeva. Dopo il caffè fui il primo ad alzarmi. Salutai in fretta e mi avviai nel parcheggio, immergendomi nel silenzio della disfatta, dentro l’odore di un fine aprile dal caldo smodato. «Marco!» Era lei. Mi voltai e la vidi sulla porta del ristorante. La sua sagoma in controluce era senza colori ma fu la visione più vitale che avrebbe potuto cadere sui miei occhi. «Mi dai un passaggio?» Questa volta urlò quasi, fino a guardarsi pure intorno per accertarsi di non aver esagerato con la voce. Poi sorrise e tutto mi fu chiaro. Ero felice, in un modo commovente che non ricordavo di aver mai sentito.
Il suo volto era impagabile e mi detti a delle pagliacciate per celebrare la sua scelta di avermi chiamato. Le pagliacciate furono roba come aprirle lo sportello, inchini vari e galanti inviti a salire in auto usando il voi. Volevo ancora il bianco accecante del suo sorriso, non me ne sarei mai stancato. «Perché te ne andavi già?» mi chiese mentre provavo per la terza volta la manovra per uscire dal parcheggio. Scherzi dell’emozione. «A quanto pare eravamo in due ad annoiarci». Il trovarci d’accordo ci sorprese a ridercela di gusto. Lei giocava con le mani, sembrava che le muovesse per confermare le mie parole. Averla in auto mi sembrò, per un attimo fugace, un progetto con cui qualche divinità mi stava dicendo qualcosa, o affollando la mente di misteri. Oltre che bellissima, Hani era enigmatica. Sapevo che sicuramente avrebbe avuto tutte le risposte alle domande che non le facevo. Come al lavoro, rimanevo a bagnomaria nell’ansia di non piacerle, di sbagliare qualcosa. Di cadere in un errore con cui lei si sentisse autorizzata ad allontanarsi. A volte sono così ridicolo che mi sento come un arbusto sfinito dall’arsura, senza rami, sbattuto dal vento. Credevo fosse l’incertezza e invece mi ero innamorato incredibilmente di lei. Dei suoi occhi neri e dei suoi capelli scuri e foltissimi, che le formavano intorno alla testa una specie di corona di ricci che lei gestiva incastrandoci dentro tutto ciò che gravitava sulla sua scrivania. «E tu perché non accosti?» mi chiese dopo un paio di chilometri. Gracchiai qualcosa di simile ad un sì, o almeno credo. O forse non dissi niente.
Quando fummo fermi sul ciglio della strada, la città ci sparò in faccia tutte le sue luci con cui sa essere bellissima e invadente. Io avrei preferito più buio e quella sera paragonai Firenze a Marta. Due signore gelose. Io e Hani iniziammo a guardarci. «Finalmente… » sussurrai. «Finalmente cosa?» «Finalmente mi vedi» le dissi. Non staccavo gli occhi dai suoi, né dalla sua bocca. Lei si avvicinò. Più che baciarci, fu un assaggiarci a vicenda. Pensai che in quel momento avrei potuto morire lì, sul ciglio di quella strada, e rimanere felice. Mi sento un rimanda-piaceri, ma non avrei mollato Hani, il suo corpo, la mia voglia di lei per niente al mondo. La cercai ancora, la volevo ancora. Lei resistette alle mie mani e io non seppi insistere. Riaccesi l’auto col dolore nell’anima e nei pantaloni e arrivammo in città alla velocità della luce, nell’imbarazzo delle cose non dette. «Io sono felice, Marco» disse guardando oltre il parabrezza dell’auto. Mi chiesi il perché, per sentirmi completamente scemo. C’è un motivo necessario alla felicità? Poi lo chiesi a lei. «Ho trovato buone persone da voi, e tu per primo, sei gentile e carino». Si voltò lentamente verso di me e il suo gesto consegnò al discorso una certa solennità. Io credo di essere diventato viola. «È bello sentirtelo dire». Feci passare qualche secondo. «Tu invece non sei carina affatto». Lei iniziò a spalancare gli occhi, dipingendosi sul volto un sorriso beffardo. «Sei bellissima». Ci baciammo ancora, a lungo. Sorseggiavo la vita dalle sue labbra. «Posso chiederti cosa hai fatto?» le chiesi dopo qualche minuto si silenzio. Il suo rabbuiarsi mi dette la certezza di aver sbagliato. Il timbro, la domanda. Il momento. Avevo sbagliato tutto. «Sicuro di volerlo sapere?» «Forse sì, forse no» dissi, tentando un sorriso senza ricadute. I suoi occhi furono umidi di lacrime. Quindi ruppe gli argini e io accolsi, o cercai di farlo, tutto quello che mi disse. Si fidava di me e questo aveva un valore immenso.
Hani era figlia di genitori che non aveva conosciuto. Erano morti in Somalia, quando lei neanche camminava. Non ricordava i loro volti, solo la sensazione di essere stata amata per poco tempo. Poi un colpo di bazooka li spazzò via dalla Terra, con un’efficacia spietata, risparmiando la vita solo a lei. Per anni aveva vissuto dentro una specie di cella, come in una scatola di mattoni costruita dentro il convento delle suore che la accolsero in fasce, già in Italia. Quando fu adottata dalla sua nuova famiglia aveva sei anni e aveva conosciuto solo altre tre bambine. Aveva vissuto di preghiere, di silenzi e di lunghe e spossanti contemplazioni verso il niente di una campagna brulla e solitaria. Era la regola e lei ne faceva parte. Iniziare la scuola e immergersi nella sua nuova vita fu complicato. Dovette imparare tutto daccapo. Dovette imparare che la gente parla e gioca, che le persone amano con la tenerezza, che il palato si può soddisfare. Che avere una vagina non è una malattia e che una volta che ti sei lavato non sei più sporco. Dovette imparare che i peccati che le dicevano di essere portatrice fin dalla nascita non permangono al passaggio di un sapone sulla pelle. La pubertà fu la parte più difficile. Fu come provare a conoscere il proprio corpo ma non prevederlo, mentre si trasforma in quello di un adulto. Il suo divenne bellissimo e a poco valevano gli incoraggiamenti della madre adottiva a lasciarsi andare ad abbigliamenti meno sobri e castigati. Ma sua madre fu una donna saggia. Rispettò i suoi tempi e l’aiutò nella fatica di vedersi trasformata. Accolse lo stupore per le forme che comparivano, tentò di spiegarle il perché degli sguardi dei compagni di classe, che come lei, adolescenti, iniziavano a maturare delle voglie. Ma lei aveva in dote il terrore di essere una persona con dei desideri che comparivano nonostante tentasse di scappare dal suo stesso corpo. Fu uno strazio sentirsi sbagliata.
Verso i diciassette iniziarono a pioverle addosso gli sguardi degli adulti. I più insistenti provenivano da suo nonno, che l’ironia della vita lo chiamò Innocenzo. Era un uomo dedito alla bottiglia, rozzo e poco avvezzo ai rifiuti. Si faceva sempre più invadente con Hani, chiedendole ogni giorno aiuto per togliersi le scarpe quando rientrava dalle sue bevute al bar. E mentre lei lo faceva lui le accarezzava la schiena. La volta dopo i capelli. Quella dopo ancora si spingeva sul davanti per sentirle i seni, ma lei si ritraeva con la scusa di aver già assolto al suo dovere. E scappava in camera sua, oppure fuori, a cercare l’aria. Si chiedeva se se fosse giusto quello che le accadeva, ma senza dirlo a nessuno. Passò il giorno del suo diciottesimo in casa, da sola. C’era qualcosa di cui aver paura, ma non sapeva bene di cosa. Iniziava a lavarsi sempre di più e tutto passò sotto la luce dell’attenzione e della cura per se stessi che caratterizza gli adolescenti. Sua madre intanto ne era orgogliosa, la vedeva diventare una donna. Un giorno il nonno tentò di spogliarla. «Fammi vedere come sei diventata, bambina» le disse. «Non mi va». Hani fu lapidaria. Il nonno era robusto, così la trattenne per una mano mentre con l’altra le strappava i bottoni della camicetta che aveva addosso o mentre tentava di abbassarle i pantaloni. Poi le prese la mano e gliela spinse sulla patta, gonfia della sua erezione, mentre lei gridava. Mentre piangeva e mentre raccoglieva dal pavimento, su cui erano seminati oggetti sparsi alla rinfusa, la bottiglia di vetro che il nonno teneva vicino al letto, per bere quando di notte si svegliava. Sentire la sua erezione le spense la ragione e lo colpì, con quello che trovò. Quando incontrò l’arcata sopracciliare del nonno la bottiglia andò in mille pezzi, che si mischiarono al sangue e al resto delle cianfrusaglie che lui teneva in camera. Il nonno fu a un passo dalla morte. Hani singhiozzava, il suo raccontò era finito. Il resto lo posso solo intuire. La abbracciai e tentai di rassicurarla. Provai a parlarle, ma era così difficile.
I giorni seguenti Hani si fece sempre più diffidente, anche con me, mentre mi straziavo per darmene una ragione. Mi interrogavo e mi torturavo nel vederla così indifferente al mio terrore di perderla. Provavo a contattarla, la guardavo, aspettavo le pause alla BTP per incontrarla. Lei mi sfuggiva. Poi un giorno mi fermò all’uscita per il pranzo. «Io devo chiederti scusa» mi disse. «Per cosa?» Mi guardò con l’espressione di chi l’ha combinata grossa e non sa dove nascondersi. «Credo di sapere cosa stai vivendo, ma io non riesco ad innamorarmi». La cosa mi irritò. Sembrava una scusa stupida, che Hani non avrebbe mai fabbricato. «A me manca una parte, credo» continuò, mentre si toccava la tempia col dito. «Penso che il mio cervello abbia ricevuto uno shock, o che gli manchi la parte dell’innamoramento» mi disse quasi tremando «Mi dispiace ma non ci riesco». Seppi che la sua messa alla prova fu attivata per il tentato omicidio verso suo nonno, e so che per tutto il tempo della sua durata cercai di starle accanto. La fiamma del suo tentativo di farsi avvicinare si era tristemente spenta 172 con la stessa facilità con cui si era accesa la sera della cena, sul ciglio di quella strada benedetta. Una volta Hani mi disse che la gente la disprezzava e che sentiva di avere in fronte un’etichetta indelebile, che non la rendeva uguale agli altri. Io, povero ingenuo che non sono altro, credevo che Hani portasse addosso i frutti della miopia di un gruppo di suore fanatiche e la cattiveria di un uomo violento e senza cervello. Ancora sono convinto che erano queste le gabbie di cui non si liberava. Sono passati degli anni da questi fatti. Oggi mi volto indietro e vedo il mio goffo tentativo di legare con una persona che non poteva starmi accanto, forse neanche la amavo ma amavo l’idea di salvarla, di toglierle di dosso quel velo di tristezza. Alla fine del suo periodo in azienda smise di essere distaccata e divenne ostile, ma solo con me. Un giorno mi farfugliò addosso parole completamente slegate dalla realtà o che niente avevano a che fare con la mia voglia di volerle bene. «Tu mi usi per qualcosa, Marco» mi disse. Rimasi in silenzio per un tempo durante il quale lei non alzò mai lo sguardo sul mio. «Per cosa ti userei?» «Non saprei, forse per farti vedere bravo o gentile con qualcuno».
Non capivo allora, oggi sì. Hani fraintendeva tutto. Era così poco avvezza alla felicità o alla gentilezza che la mia, palese e certa, le creò un corto circuito. Non sapeva usare l’amore perché non ne conosceva i codici. La sua infanzia, fatta di cattive intenzioni da parte degli altri eccetto che da sua madre, ma con un babbo quasi inesistente, l’aveva passata a fuggire dalle grinfie di un nonno che se la sarebbe pure scopata. La sua vita non riusciva ad accettare un corso contrario alla voglia di volarsene via, in qualsiasi posto pur di non soffrire. Hani non era padrona delle sue emozioni. Non lo era in maniera pericolosa. Un giorno, erano passati già due anni dall’uscita di Hani dalla BTP, Marta si avvicinò alla scrivania di Chiara Margheri. Bisbigliavano e mi guardavano. Chiara scuoteva la testa e spalancava gli occhi. Poi mi guardava, fugace. Marta se ne andò nella sua stanza e io mi alzai per mettermi di fronte alla scrivania della mia collega, in un’atmosfera che sapeva di sospeso. Chiara iniziò a parlarmi con la delicatezza che si concede ai fragili. «Marco, ricordi Hani, la ragazza somala che fece la prova?» «Stai scherzando Chiara?» le risposi incredulo «Mi stai chiedendo se mi ricordo di Hani?» «Si è impiccata». Quello che accadde potrebbe essere definito solo da una pagina bianca stracciata, o zeppa di graffi di inchiostro. Non dissi niente, non risposi. Tornai al mio tavolo a guardare il monitor ancora spento del PC. Non volevo pensare, ma ero costretto a farlo. «Marco, mi dispiace, so che tu e Hani…». «Lascia stare, è passato un po’ di tempo, tranquilla». Margheri si ricompose e si rimise al lavoro.
Passai un po’ di giorni nel rimuginio di pensieri sterili. Nessuno avrebbe più visto i suoi occhi neri, i suoi capelli ricci da africana. Nessuno l’avrebbe più baciata, nessuno avrebbe goduto più della sua compagnia fatta di cose strane, come i suoi silenzi che pesavano come macigni per liquefarsi dopo cinque minuti e diventare ricordi strambi e lontani, su cui ridere come matti. Non si sarebbe infilata più matite e penne tra i capelli per tenerli raccolti e non l’avrei più spiata per vederla guardarsi intorno e raccogliere da un tavolo uno stelo di legno che una volta faceva parte di una decorazione da parete. Se si accorgeva che la guardavi mentre si raccoglieva i capelli, rideva e lo faceva da quella bocca così sensuale, da quelle labbra che io desideravo continuamente baciare. Lo avrei fatto a costo di non respirare. Hani non avrebbe consegnato più a nessuno i suoi enigmatici sguardi di curiosità. Non avrebbe attratto più nessuno come aveva fatto con me, per poi costringermi a masticare il rifiuto. Nessuno si sarebbe più illuso del suo amore. La verità, forse, è che Hani soffriva di qualcosa di innominabile, senza che nessuno se ne sia accorto. Poi trovò una corda e l’appese a una trave. Furono la sua penna e la sua carta; l’unico modo che ha trovato per dirlo.
Pier Paolo Giusti, quarantenne, psicoterapeuta è affetto da qualcosa contrario al blocco dello
scrittore. Per lui scrivere è sempre stato più bisogno che svago. Più esigenza che divertimento. Racconta che alle volte è faticoso come un’arrampicata in salita, altre è spontaneo come un’emorragia nasale, succede e quasi non se ne accorge.
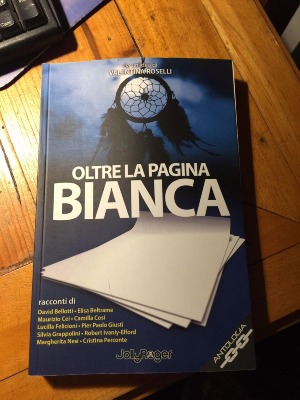

Devi fare login per commentare
Accedi