Letteratura
Empie stelle di Giovanni Giudici
Tre anni dopo Quanto spera di campare Giovanni, Giovanni Giudici tornò a pubblicare da Garzanti Empie stelle, recuperando temi e toni del periodo d’oro della sua poetica, quello dei libri più noti e amati dai lettori (La vita in versi, Autobiologia, O Beatrice): meno ironico e controllato che nelle precedenti raccolte, non più parodistico nei riguardi di se stesso e della tradizione letteraria, poco interessato alla sperimentazione o al gioco linguistico. Proclamando invece orgogliosamente la sua fedeltà ai sentimenti (“sentire”), il suo omaggio alle passioni (“patire”).
In questo volume ci troviamo di fronte a un rientro nel profondo dell’io, a un recupero consapevole del passato del cuore, scandagliato nelle pieghe della memoria e rifatto vivo e vero tra interni ed esterni della propria esperienza esistenziale e di scrittura.
L’amore, quindi, come la prima e la più importante delle trasformazioni personali, torna qui a essere sogno platonico di fusione con l’altro da sé, scala all’assoluto, “bisogno di colpa, confessione e servitù”. Nella prima sezione intitolata a Creusa (con la splendida epigrafe virgiliana “maestusque Creusam… iterumque iterumque vocavi”), moglie perduta di Enea, continuamente e in tutte cercata, sofferta (“Blanda affondata spina / Nel fianco delle notti d’occhi aperti”), e ritrovata nel canto disteso di molti, memorabili endecasillabi: “Per scamparmi ti persi in tanto scempio”, “O inabitato ignoto unico asilo”, “Non dissiparti amore della mente”, “Follia gentile parlami – ti ascolto”, “Pensarti un grembo era pensare Dio”, “Ma tu, distanza, torna a ricolmarti”, in incipit che echeggiano talvolta i Mottetti montaliani.
L’amore viene descritto nell’accezione spirituale di una dedizione a ciò che non si vede, cui solo si può attingere attraverso un moto dell’anima esperito come atto di fede, più totalmente realizzato se a osarlo si è in due: “Così attingendo al non visibile / Muti murati fianco a fianco / Noi devoti all’incredibile / Nominando nero il bianco”.
Devozione all’inaudito e all’incredibile, a quello che gli altri sbeffeggiano, esibendo ottusi la loro normalità: “Irrisi o in una più / Benigna ipotesi commiserati / Da chi non sapesse la spenta / Pietà che li resse”. Ma anche fedeltà a ciò che è modesto, quotidiano: affetti familiari, una religiosità minuta e semplice, con un riferimento costante alla poesia spagnola (Lorca, Machado, Vallejo): poesia di carne e sangue, immolata alla fisicità del vivere e dello scrivere, cristiana nel senso di sacrificale.
Viene ripreso un altro tema riaffiorante in tutta la produzione poetica di Giovanni Giudici: il rapporto con la Chiesa, vissuta e patita soprattutto nei suoi riti penitenziali (peccato e assoluzione, Via Crucis e autoflagellazione). A sottolinearlo sono alcune figure clericali, da Ernesto Balducci ai “tristi vescovi ingegneri di anime”, fino al frate altoatesino severo padre spirituale della giovinezza, che ridestano nella coscienza l’antico bisogno, sempre ammesso e stigmatizzato con ironia, di far parte di una comunità, sia essa religiosa o politica, elemento-mattone di una chiesa o di un partito (ricordiamo che Giudici collaborò a lungo con il quotidiano del PCI L’Unità), chiamato a salvarsi o a dannarsi in un rito collettivo di unione con gli altri.
Persino il corteo di uno sciopero generale a Milano è spunto per versi che hanno la cadenza liturgica del coro, da cattedrale o da manifestazione: “Tutti insieme in tanti un’altra volta? / Essenziale rimane essere duri / Salvare la gentilezza”.
“Essere duri” come imperativo politico condiviso intellettualmente, “salvare la gentilezza” come esperienza etica, dato caratteriale immodificabile. E se il carattere di una persona è il suo destino, quello di un poeta lo è due volte, nella vita e in ciò che scrive.
Ecco dunque tornare l’autobiografia come abitudine letteraria e indagine interiore, con gli stessi motivi dei volumi precedenti: il ricordo di un’infanzia intristita e repressa (“Essere dagli altri uno diverso / Con l’acqua non poter giocare / Non toccar cibo con la mano”, “Io che per non farvi piangere / da solo ho dovuto patire”); la paura della disobbedienza collegata all’attrattiva della trasgressione (“Soltanto avessi appena amato / Aerei corpi di letizia / E non tremato e non temuto”, “Empietà – quando sale della Legge / sia un minimo di inadempienza”); il rimpianto per non aver osato; la consapevolezza di aver ecceduto nell’autocompatimento e nell’ auto-irrisione (“Sempre fui a capo chino alzarlo adesso / Qual senso avrebbe e allora giù gli occhi al suolo”).
Empie stelle sembrava voler chiudere un cerchio, tornando al nocciolo di tutta la produzione poetica dell’autore, con un riutilizzo del dialetto ligure dell’infanzia, come nei versi che aprono e concludono il volume: “a t’ò zà ‘ito tüto” (ti ho già detto tutto).
In cinquant’anni di poesia Giudici ci aveva detto tutto, è vero, ma com’è bello e importante ritrovarlo rileggendo questo libro del 1996, nel suo discreto e umanissimo proporsi a noi, disillusi frequentatori del secondo millennio: “O lingua di pudore / A te rispondo e taccio”.
Giovanni Giudici, Empie stelle – Garzanti, Milano 1996, p. 118




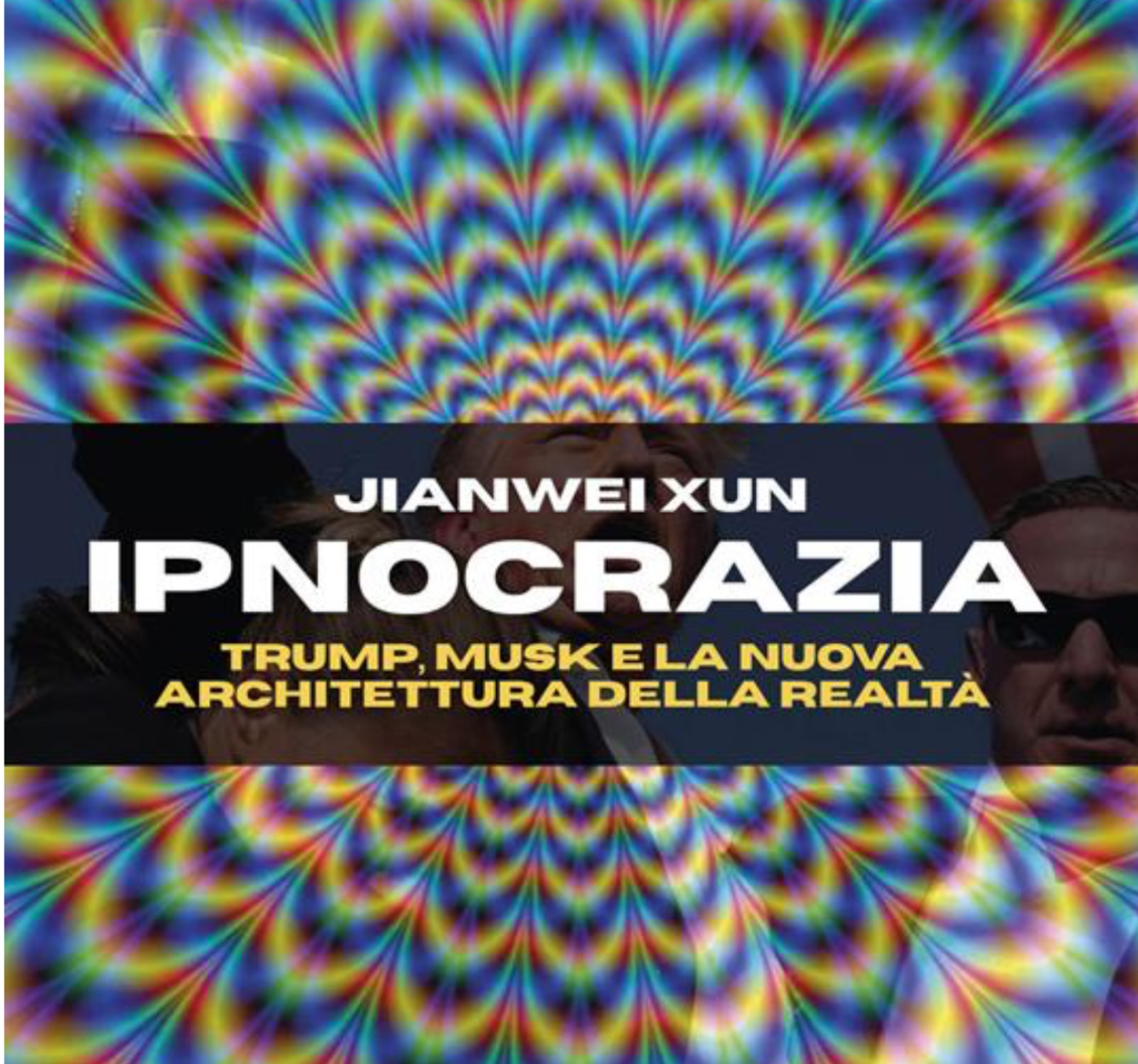
Devi fare login per commentare
Accedi