Letteratura
Diventare ciò che non siamo
Appoggiata al balcone che si affaccia sul lago, osservo a pochi metri da me la palma che spinge le sue foglie fin quasi a toccarmi: o sono io che le sfioro e mi pungo le dita al tatto con le loro punte aguzze. Riuscire a registrare ogni impressione, visiva, uditiva o tattile: riuscire a rendere colori e profumi, e quello che ai sensi sta dietro, o dentro: questo si vorrebbe raggiungere quando si scrive. Diventare ciò che non siamo, l’altro da noi: prestare la nostra voce a chi non parla, farsi imbuto ed espressione di qualcosa che ci supera, e ci sconfina.
Ero ragazzina, sdraiata su un prato in pendio, lasciavo che l’erba mi solleticasse le mani e i polpacci nudi, premendomi contro il terreno, di cui individuavo le asperità sotto la schiena. La terra sotto di me, il cielo sopra, un cielo pomeridiano di quasi estate: lo guardavo con l’intenzione decisa di farlo mio, di impossessarmene in ogni sfumatura, in ogni accenno di nuvola. E piano piano questo cielo scendeva, mi veniva addosso, pesava sul mio corpo dodicenne, lo assorbiva in sé. Mi promisi: «Ricorderò questo momento per sempre», e ancora: «Lo racconterò, tutto», pensando all’erba tra le dita, alle zolle sotto la schiena, all’azzurro in cui ero fusa. Più tardi cominciai a interessarmi alle persone, a quelle che mi stavano intorno e alle sconosciute. Arrivavo a seguire i passanti per strada, sperando di vivere così qualche momento, per quanto inessenziale, marginale, della loro vita.
Se scrivo, oggi, mi accorgo di scrivere soprattutto d’altro e non di me: di essere portata addirittura a farmi altro. Rincorro un’empatia con chi non sono, cambio età, sesso e natura: divento due extracomunitari alla ricerca di un sabato sera diverso, o Hans Castorp alle prese col suo amore, oppure un curato di periferia che preferisce la compagnia di Dio a quella dei suoi parrocchiani. Divento anche Gemma Donati, e gli oggetti del mio appartamento, o il lago che adesso mi sta di fronte, senza nemmeno supporre che esisto, e lo sto guardando.
Questo credo debba essere la poesia; un occhio partecipe e distaccato insieme su ciò che non siamo, con una preferenza per «la pietra scartata dai costruttori», perché «diventi testata d’angolo». Non sopporto il pastiche linguistico, la poesia che scrive di se stessa e che si fa il verso, il gioco da salotto: mi sembra addirittura amorale, nella mia severità calvinista. Penso che scrivere sia un grosso privilegio, in qualche modo da scontare ponendosi al servizio di ciò che deve essere scritto. E che il compito di un poeta sia quello di scrivere bene, affinando quindi la sua abilità artigianale, i suoi strumenti: per diventare lui stesso strumento d’altro. Chi sia che parla attraverso un poeta non lo so, e forse non mi interessa saperlo: se l’inconscio collettivo, o l’angelo rilkiano, o la ruah ebraica. So che mi capita di essere scritta, di essere usata da un’intenzione più forte di me, che si serve della mia sensibilità, del mio sguardo particolare sulle cose (e non è uno sguardo migliore o peggiore di altri, però è il mio): e ciò che mi circonda e di cui parlo patisce e utilizza la mia inquadratura, il mio modo di usare la metrica e le rime, travalicandomi. Sono un puro pretesto, e un pretesto addirittura spaventato, inadeguato, per un’incombenza che sento come una responsabilità.
La prima poesia de La Trilogia Spagnola di Rilke, che in realtà è una preghiera, lo dice mille volte meglio di quanto sto tentando di fare adesso.
LA TRILOGIA SPAGNOLA – I
Di questa nube che copre improvvisa
la stella poco fa ancora visibile – (e di me),
di questi monti, in fondo, che ora avranno
notte, venti notturni per qualche ora – (e di me),
di questo fiume a valle che riflette il chiarore
di lacerate radure celesti – (e di me);
di me e di tutto questo fare un’unica cosa,
di me, Signore, e di ciò che sente
il gregge quando chiuso a riposare
nel suo stabbio sopporta il grande oscuro
annullarsi del mondo – di me e d’ogni luce
nella folla e nel fosco delle case, Signore:
fare una cosa sola, degli estranei, perché
non uno io conosco, e di me, di me, Signore,
fare una cosa sola; dei dormienti,
dei vecchi estranei nell’ospizio
che nei letti tossiscono gravi, di bambini
ebbri di sonno stretti a un petto estraneo,
di molte incerte forme e di me sempre,
di me solo e di ciò che non conosco
fare la cosa, Signore, la cosa
di terra e mondo che come meteora
nel suo peso non è più che la somma
del volo: e altro non pesa che l’arrivo.
Come raccontare la carezza su un volto molto amato, e le dita che tremano; come parlare della risata della mia figlia più piccola, e della maggiore che balla da sola davanti allo stereo; cosa dire di nuovo e necessario sul lago increspato che mi sta di fronte. Ciò che vorrei è diventare «una cosa sola», volo e peso, terra e cielo, fino a ridurre tutto a un unico approdo, all’essenziale «arrivo».
In Il Rosso e il Nero n. 16, 1999 e in Qualcosa del genere, Italic Pequod, Ancona 2018



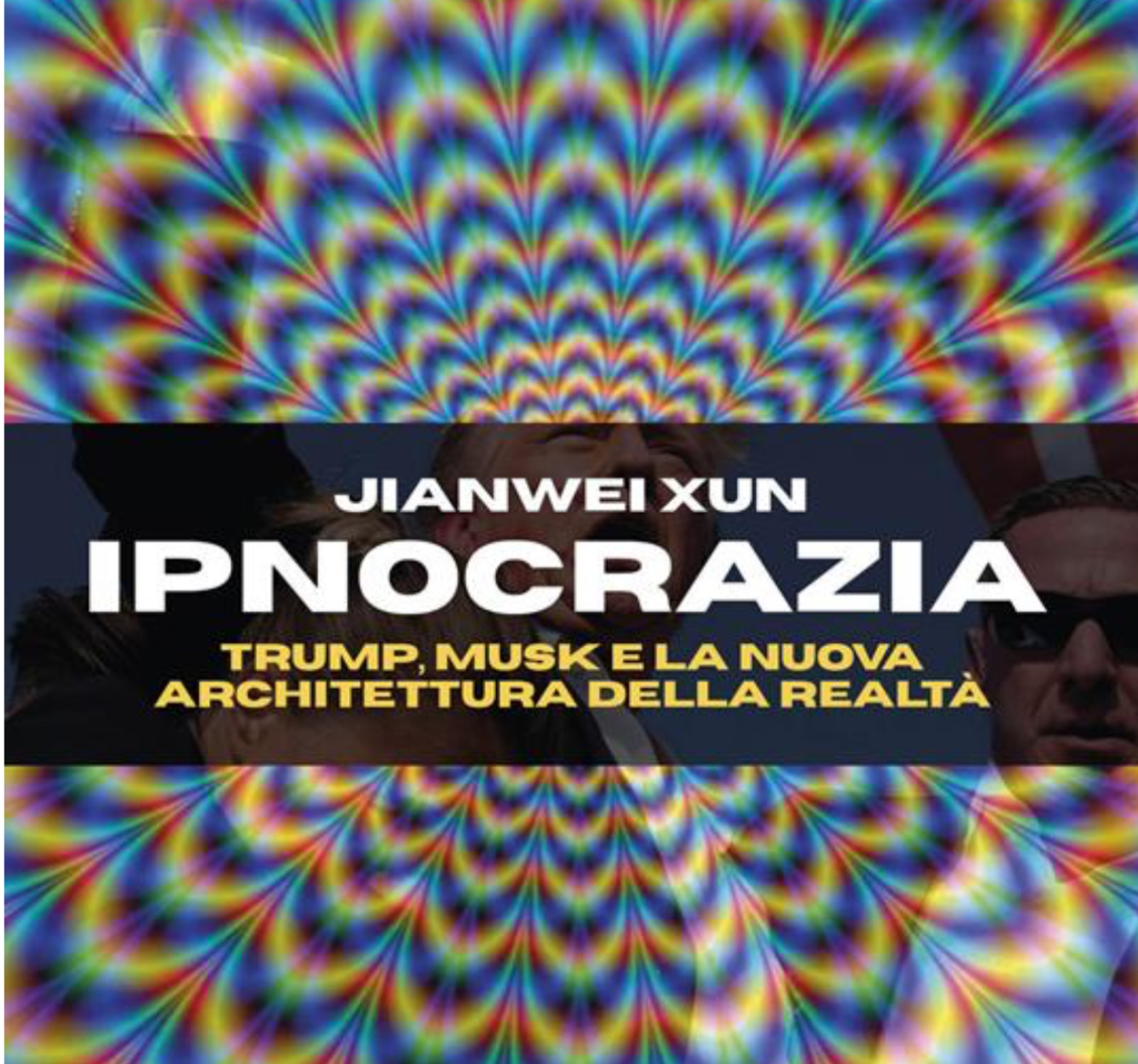
Devi fare login per commentare
Accedi