Letteratura
Delitto a Venezia. O forse no!
Psicodramma in Commissariato a Venezia: Il Comm. Mangili sulle orme di Montalbano
Erano le due del mattino quando dall’Audi Q5 blu si disperse per il garage del Traghetto Ancona-Knossos un trillo infernale, garrulo, un richiamo urlante che spezzò lo sciabordio leggero delle acque mosse dalle eliche. Il rumore incessante svegliò il Commissario di bordo che accorse nel garage e rilevò la targa. “Il proprietario dell’auto targata etc etc” risuonò nel silenzio della notte e della nave che continuava solcare il mare. Dopo vari richiami, il Commissario desistette e anche l’auto che gocciolava lacrime di olio smise. Al mattino quando le auto lasciarono la stiva, quell’auto restò sola ad aspettare un proprietario svanito nel nulla, sola nel garage vuoto di una nave bloccata dalla Guardia Civile greca per accertamenti. Un monumento di ferro che, se parlante, avrebbe raccontato tutta la storia che leggeremo adesso. Un monumento di solitudine accesa dalla vicenda più sconcertante che udirete. Nulla si seppe nelle giornate successive di quel proprietario che lasciò orfana non solo la sua vettura ma la sua piccola comunità che lo diede per disperso come in realtà era, lasciandosi andare dal parapetto della nave alle 1:45 esatte.
Tre mesi prima
“Questa è la storia più incredibile che abbia mai udito. O lei è un pazzo o davvero è un delinquente.” Il Commissario Mangili andava su e giù per la sua stanza strappandosi i pochi capelli rimasti, ultimi epigoni di una chioma che lo aveva reso desiderabile presso le donne di Venezia. Non solo le veneziane ma anche quelle che erano di passaggio e che lo adoravano per il suo aspetto trasandato ma dotato di una certa eleganza fascinosa che attraeva il gentil sesso che veniva a contatto con lui per svariati motivi. Adesso il colletto della camicia era tormentato da una mano che descriveva con un moto circolare sul collo tutta l’incertezza che gli derivava da quel caso strano, alla Montalbano per intenderci. Nella sua stanza, al centro, una sedia di legno che aveva visto tempi migliori, ospitava un signore di mezza età, dalla calvizie ormai cronicizzata e che aveva lasciato pochi fili grigi, composti, asciutti, privi di quel madido sudore che cosparge di solito i colpevoli. Ben vestito, cravatta Bancarella, perfetta riga del calzone, Ettore non lasciava trasparire alcuna emozione. Lucido, aveva raccontato la sua storia alcune ore prima mostrando un panno lercio, intriso di sangue che faceva la sua bella mostra sul tavolo delle prove, di presunto reato, disposto all’occorrenza.
“Ma come, lei mi dice di averlo assassinato ma non c’è nessun corpo, non c’è stato delitto negli ultimi due mesi a Venezia. Solo una prostituta uccisa nel suo letto dal compagno emiliano, che, acciuffato alla Stazione di S. Lucia in palese atto di fuga, aveva confessato poche ore dopo l’arresto, mostrando il coltello insanguinato e lasciato in un cassonetto della Chiesa di S. Moisè.”
“Nulla e nessuno, non abbiamo trovato nessun corpo, eppure lei si autoaccusa di un omicidio mai commesso.”
“Vede Commissario, disse Ettore, io l’ho ucciso, lo dimostra quel panno di ciniglia intriso del suo sangue. Io lo uccido ogni notte, è lui il colpevole della mia vita infelice. E ogni notte il panno si ricopre di sangue. Io lo lavo ma poi la notte me ne servo per pulire le tracce delle pugnalate.”
“No guardi, non posso credere finchè non trovo il corpo, poi lei dice che lo uccide ogni notte ma nella sua fantasia. Lei è matto, sa, non ci faccia perdere tempo”.
“Insisto, Commissario, tanto per me non cambia nulla, lei troverà il corpo prima o poi e si convincerà. Mi creda sono io l’assassino”.
“Ma allora mi dica chi è la vittima, perché lo ha ucciso e magari poi ogni notte ne rievoca la morte. Questa potrebbe essere la spiegazione, visto che lei reca delle ferite da taglio al braccio sinistro, chiaramente autoinferte. Lo ha ucciso, ma una sola volta, e ogni giorno ne ricostruisce il momento della morte, con autolesioni che hanno il senso del riscatto, della pena da espiare. Se lo ha ucciso, deve almeno sapere chi ha ucciso e perché”.
“No Commissario, questo non posso dirglielo, lo deve scoprire da solo”.
Andavano avanti per ore, il Commissario Mangili aveva davanti a sé una bella alternativa: non poteva rilasciare un reo-confesso ma non poteva chiamare il Magistrato in assenza di un corpo assassinato, di un movente e di una prova certa.
“ Mettetelo in guardina-ordinò- e domani si vedrà”.
Un omicidio con reo-confesso ma orfano di tutto, corpo ucciso, corpo del reato, tranne il coltello affilato che recava tracce di sangue verosimilmente del confesso, nessuna notizia di omicidio in provincia nelle ultime settimane. Un rebus, ma quello che tratteneva il Commissario era la seraficità del confesso, professore di fisica all’Università di Milano e noto climatologo.
Si mise al pc e cercò di Ettore Nicchiara. Azz…, si disse, noto climatologo, difensore acceso del clima, autore di libri, pubblicazioni, conferenze, plurilaureato. E questo si mette a raccontare storie inverosimili, mette a repentaglio la sua reputazione per una follia. No, qui c’è qualcosa che non quadra. E mentre si masturbava i pochi fili rimasti sul cranio, decise di andare a letto e rinviare il tutto al domani. Che è già oggi, si disse, essendo le 4 del mattino.
Quattro anni prima
Vagavo a ridosso di Brera a Milano nel quadrilatero della moda, un po’ senza costrutto e un po’ per curiosità quando mi imbatto in una bancarella di libri dismessi. Faceva capolino nella piazzetta Gabbi e manifestava tutto il vecchiume che gli anni conferivano al suo padrone, un uomo anziano, sdrucito nei modi come i suoi abiti, che stava seduto su una vecchia sedia di paglia. Ma non fu questo che mi colpì. Fu il contrasto evidente con lo splendore che lo circondava: auto fiammanti, donne eleganti che andavano su e giù da via Borgonuovo, a ridosso di Montenapo. Un contesto arricchito più che ricco, e la vecchia postazione di libri sotto casa di Don Lisander urlava tutto il disdoro per i nuovi arricchimenti e il rimpianto dei tempi andati di nobiltà intellettuale.
Curiosando tra i libri, forse alla ricerca di vecchie edizioni manzoniane, vidi qualcosa che mi attrasse. Una vecchia edizione, ormai carta pecora e in via di disfacimento. Ma mi è sembrata inestimabile per il fatto stesso di essere testimone editoriale di metà-fine XIX. Il libro, “Ode per Mirta” edito da una sconosciuta tipografia pavese, è scritto da Dodo Raineri, medico di Pavia, allievo di Carlo Forlanini, che venne a Caprera non già a curare Garibaldi ma a intervistarlo, giacché nutriva passioni politiche e rivoluzionarie, avendo partecipato alla Repubblica Romana del 1849. Arrivato alla Maddalena (sic) si innamora di una benestante locale e scrive per lei il volume. La prosa è demodé, tardo-romantica, potrà anche non piacere ma scrivevano “di tal fatta”: “Che strana congiuntura, Signora, il tempo con Lei perde ogni costanza conosciuta. I secondi trascorsi insieme diventano secoli fuggitivi e quando io La penso ogni attimo assume l’immutabilità di un amore eterno. Non posso e non voglio dimenticarla, avrei dovuto penetrarla io, invece sono stato penetrato e trafitto, avrei dovuto e più e più abbracciarla, invece il Suo ricordo mi avvolge in un manto di dolore antico e impenetrabile. Non è manco cicatrice, ma squarcio che segna il passo della mia vita e la rende diversa da quella che i miei natali vollero per me”. Ed ancora “...Lei non sa ma io venni incognito non già per cercarla ma per baciare la terra che le diede la vita, ne presi una manciata, la tengo con me fonte generatrice di siffatto amore”. Per quanto io sia cinico o ritenuto tale, non sono rimasto insensibile a questo grido di dolore.
Sembrava proprio il prologo di una storia dei nostri tempi aggiornata ove il vero protagonista è il tempo con la sua immutabilità che pur rende dinamiche e si ripete nelle storie umane. Un Inno all’Amore, quello vero, fatto di donazione e non di passione egoistica e banale.
Perché viene riproposta una passione perduta? Perché forse oggi abbiamo dimenticato valori come l’attesa, la pazienza, la costanza, nel mentre che tutto si consuma e lascia solo, disperse nell’aria, nanomolecole di pseudo-sentimenti. In quel pamphlet tutto è scolpito nel tempo immemore di una vita dedicata.
Mi accasciai attonito, leggendo seduto per terra o quasi, doveva essere il gradino di una scalinata di chiesa, quella di Via Pasquirolo, dove arrivai leggendo per strada senza ritegno il libro. Lo trovai affascinante ma in specie come se lo avessi scritto io, era la mia storia, della mia famiglia, di un vecchio bisavolo.
Dodo Ranieri aveva conosciuto Mirta, se ne era innamorato e l’aveva corteggiato a lungo. Lei cedette alla lusinga, lui scriveva lettere appassionate, quelle che diedero vita al libro, una silloge di tutte le lettere, scritte minuziosamente a pennino e inviate con una cameriera fedele. Il tutto clandestinamente giacchè Mirta era sposata con un piccolo e calvo possidente della zona. Finalmente Mirta gli scrive e gli fissa un appuntamento. Ma non lì, gli comunica che sarebbe andata a Venezia e fissa ora e sede dell’incontro clandestino. Il Calle era quello di San Moisè davanti alla Chiesa della Salute, l’incontro tra due settimane.
Dodo raggiunge Venezia qualche giorno prima, per i dettagli. Prende in affitto un appartamento, lo sistema per dovere, e si mimetizza tra i residenti locali per evitare che qualcuno possa sospettare. Il giorno convenuto lei bellissima apparve da dietro un Calle, capelli corvini fluenti, seno florido e acceso, si intravedevano tra le trine e i pizzi i capezzoli turgidi, chissà forse vogliosi. In breve dopo un thè al cioccolato, le mani si spinsero oltre, si toccarono e si amarono toccandosi. Lui ne prese una, la destra e la condusse al terzo piano di quel calle. Fu amore pieno e caldo, lei urlò tutta la sua gioia dimenticata da anni. Poi all’improvviso si destò dal letto, si vestì precipitosamente e corse fuori lasciandolo sbigottito. Rimase solo, sconcertato. Urlò di rabbia, poi capì. La donna aveva avuto una resipiscenza, un senso di colpa che le aveva fatto scattare la molla della fuga. Lui attese tre giorni, poi quattro, poi cinque. Una settimana dopo, lei ricomparve alla porta. Si amarono tra passione, urla orgasmiche e trine bagnate di liquidi la cui provenienza di sicuro dipendeva da entrambi. E così per un mese bellissimo e intenso. Ma l’ombra gravava. Ogni volta, dopo, lei scappava in preda al senso di colpa.
Il romanzo va avanti nella descrizione minuziosa di un rapporto ambivalente, amore e psiche si direbbe, vanità e piacere, intrigo e seduzione. Ma, c’è un ma… Mirta sembrava indecisa a tutto, ma decisissima a tenere entrambi gli uomini, l’amore sacro del talamo che non esclude quello profano anzi profanissimo del letto bagnato. E così l’ombra restava. Una sera di nebbia, Dodo passeggia per le calli e la vede, al braccio dell’uomo calvo e pasciuto che evidentemente era il coniuge. Li segue mentre si dirigono verso una di quelle pasticcerie, tipo Florian ma meno appariscenti. Dodo sbircia dalle vetrate, prendono il thè, sono affettuosi, sembrano complici, ridacchiano, finchè la mano dell’uomo calvo non prende quella di Mirta e la bacia come di richiesta o profferta amorosa. Quel gesto, così semplice tra sposi, nella mente di Dodo fu il preludio di un incontro carnale. Lui che l’aveva avuto tra le braccia, lei che gli aveva inondato il letto e sepolto la casa di urla orgasmiche, nelle mani del marito voglioso, questo mai.
In preda alla collera, Dodo apre con violenza la porta della pasticceria, si dirige in un balzo verso il vassoio delle posate, afferra un coltello affilato e si lancia verso l’uomo calvo prendendolo di sorpresa e inferendo pugnalate alla schiena e al volto e soprattutto alle mani, quelle mani assassine e ree di un tradimento.
Il sangue schizzò sul vestito bianco di Mirta, che urlava più per paura che per dolore. Dodo fu arrestato, processato e condannato all’ergastolo secondo le leggi del Regno d’Italia che avevano sostituito quelle austriache del Lombardo-veneto che prevedevano la morte per impiccagione.
“Ecco vede Commissario- disse il Prof. Nicchiara- io mi sono trasfigurato in Dodo e uccido ogni notte l’Uomo Calvo reo solo di essere il marito di questa donna che Dodo, non io, ha amato fino alla dissoluzione di sé stesso con l’omicidio del marito. Anche io ho avuto la stessa identica storia e non ho sopportato che lei passasse indifferentemente dal mio letto al talamo. No, non l’ho potuto tollerare”.
“Ma lei non ha ucciso nessuno, Professore, si è solo inferto delle ferite. Autolesionismo, un caso psichiatrico non giudiziario”.
“Che differenza fa, Commissario? E oltretutto io non posso e non voglio desiderare la morte di nessuno, specie di una persona vittima delle circostanze. Io non ho ucciso nessuno ma a me è stato ucciso un sogno. Sa cosa le dico, sono io che devo sparire tra i flutti, io responsabile di averla amata e poi perduta. Nessuno uccida nessuno, nessuno ha colpe, solo io quella di averla amata”.




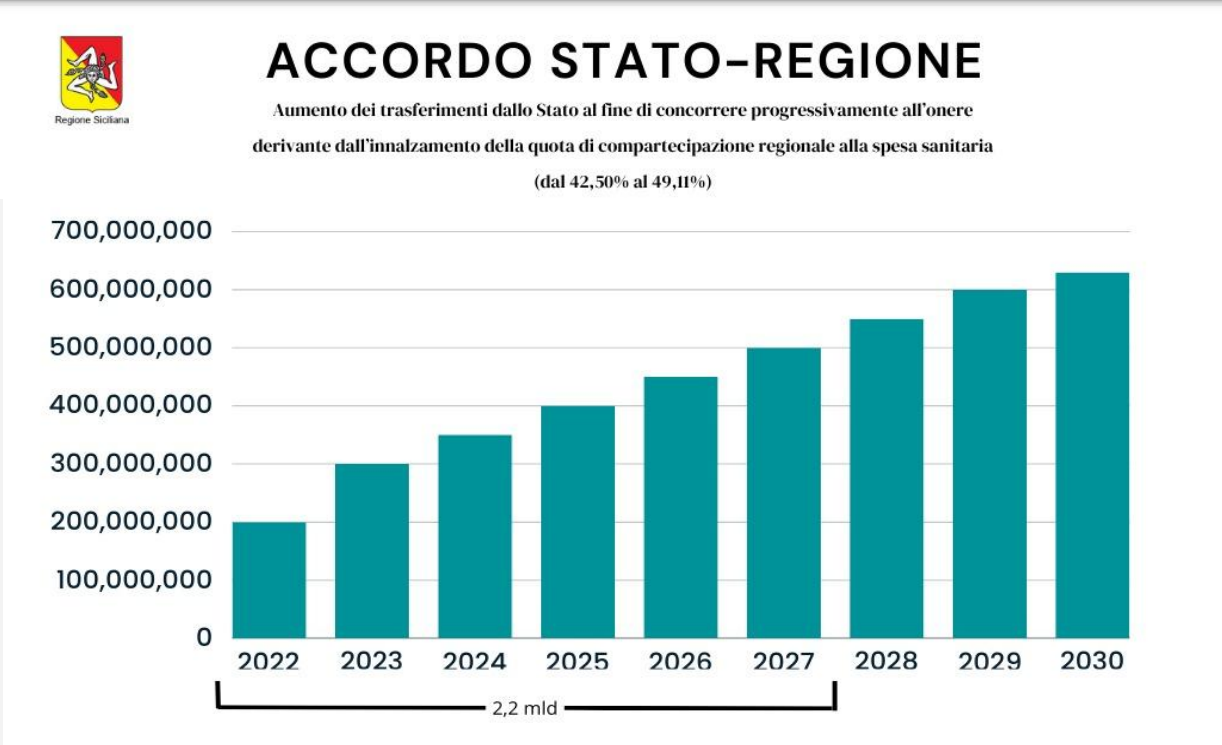
Devi fare login per commentare
Accedi