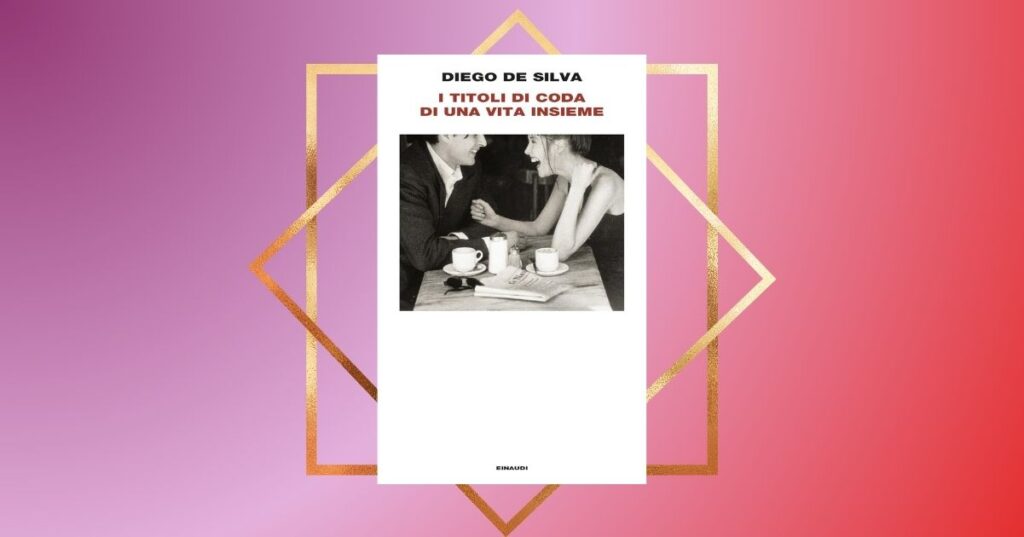
Letteratura
I titoli di coda di una vita insieme
“I titoli di coda di una vita insieme” (Einaudi, 2024) è un libro sulla fine di un amore. Il punto è: COME ci si lascia? De Silva conduce la narrazione secondo due prospettive, una maschile (Fosco) e una femminile (Alice), perché “l’amore non è una storia, ma due”.
I titoli di coda di una vita insieme (Einaudi, 2024) è un libro sulla fine di un amore.
Si tratta di un tema universale, che ha attraversato la letteratura, la musica, è un tema epico: anche i grandi eroi hanno sperimentato il dolore della fine di un amore. Quello tra Calipso e Ulisse fu un amore travolgente, fatto di promesse straordinarie (felicità indistruttibile, immortalità, eterna giovinezza), eppure è finito in un abbandono come tanti, anche se i protagonisti erano un eroe eccellente e una ninfa, una dea: si sono lasciati come due persone ordinarie.
È andata così anche tra Enea e Didone: giorni felici, promesse, passione. Eppure un litigio ordinario li ha divisi: lei che piange, si sente sedotta e abbandonata lo chiama perfidus (“traditore” della parola data) e lui che la lascia, stufo dei suoi lamenti: desine meque tuis incendere teque querellis (“smetti di inasprire te e me con i tuoi lamenti”).
Insomma, Fosco e Alice, i protagonisti del romanzo di Diego De Silva sono gli ultimi di una lunga serie di amanti che mettono fine al loro amore: una storia antica e sempre attuale.
Ci si innamora, si vive, ci si lascia. E ci si lascia evidentemente perché qualcosa si è interrotto
Ma forse il punto è: COME ci si lascia?
De Silva conduce la narrazione secondo due prospettive, una maschile (Fosco) e una femminile (Alice). L’amore non è una storia, ma due: Alice è un’oncologa, ed è interessata ai protocolli specifici cui le separazioni – come le terapie mediche – devono attenersi. E i copioni consueti delle separazioni prevedono discussioni, litigi, scontri con gli avvocati, giornate in tribunale, atti giudiziari. Fosco invece è uno scrittore: delle liti, degli atti giudiziari a lui non interessa nulla.
Perciò quel senso d’impoverimento che ti assale quando ti trovi davanti alle macerie che hai prodotto – così Fosco commenta la fine del suo matrimonio con Alice – genera reazioni diverse nei due coniugi, che per la prima volta sperimentano la povertà del lessico giudiziario rispetto alla complessità del mondo sentimentale e delle relazioni umane.
I titoli di coda di una vita insieme è perciò anche un libro sulle parole. Fosco chiede al suo avvocato di accettare tutte le condizioni di Alice e di scrivere perciò un atto stringatissimo perché una cosa in particolare di questa separazione davvero non tollera: le parole che parlano di noi, le parole nostre, quelle che ci raccontano, non possono entrare in un atto giudiziario. Tutte quelle di cui hai bisogno, amore te le ho scritte. Una vita insieme può essere riassunta nel burocratese, nell’antilingua, la definirebbe Italo Calvino, di una memoria depositata in tribunale che un giudice annoiato dalla routine di contese coniugali sempre uguali, forse leggerà distrattamente, perso tra brocardi e frasi stereotipate.
Diego De Silva, avvocato che ha scelto di diventare narratore, con questo romanzo in particolare, dimostra che le parole sono la vita. Alice lo sa bene, le parole che ricordiamo quelle che ci hanno fatto male soprattutto, sono la nostra letteratura individuale. Isolano i momenti in cui abbiamo perso qualcosa per sempre. Forse, a ben guardare, la degenerazione del linguaggio è il riflesso di una involuzione storica, epocale, sovraindividuale: quando Fosco ritorna nella sua casa dell’infanzia che ritrova trasformata in un B&B, nota che dove un tempo c’erano un cassettone sovrastato da un grande specchi liberty, un letto matrimoniale e due comodini con gli sportelli e i ripiani di marmo, ora ci sono mobili dell’Ikea dai nomi bellissimi e impronunciabili. Stiamo assistendo alla fuga della bellezza dal nostro mondo, dal nostro linguaggio, dalle nostre vite e relazioni. Viviamo in un mondo brutto (guerre, orrori, competizioni): anche la lingua ne risente.
Fosco – come De Silva e probabilmente suo alter ego – è uno scrittore. Quindi I titoli di coda di una vita insieme forse è anche un libro sulla letteratura, argomento sul quale sono disseminate osservazioni interessanti nel romanzo.
- Alice nota a proposito del marito che, in quanto scrittore, è un sabotatore di convinzioni, che poi è il lavoro della letteratura: Fosco/Diego è un maestro del sospetto, un disvelatore di quello che si cela dietro le apparenze?
- La contraddizione è il lievito madre della scrittura.
- Scrivere è fare un uso sincero delle parole: Fosco parte dall’esempio di Àgotha Kristòf, che a dispetto della realtà assurda e allucinata che descrive nei suoi romanzi, tuttavia ha uno stile limpido, chiarissimo, asciutto. Lei, ungherese, usa un francese essenziale, compresso; il francese che le serve per fare la spesa. E nella sua povertà di linguaggio c’è una sincerità addirittura violenta. Fosco ammette di avere un’insofferenza per le frasi sciatte, ma forse ciò che detesta di più è l’antilingua, quella che non dice, che impedisce la comunicazione, e dunque le relazioni. Aveva ragione Nanni Moretti: chi scrive male, pensa male e vive male.
C’è inoltre nel romanzo di De Silva un’analisi dettagliata dell’estraneità che spesso nel matrimonio genera solitudine e che deriva dall’incapacità di inventarsi.
Fosco avverte profondamente l’amarezza che gli rimane per essere piombati nella peggiore estraneità: quella fra due persone che non si spiegano come abbiano fatto a vivere per tanti anni con qualcuno con cui non hanno più niente da dirsi.
E aggiunge, ricordando i giorni della sua relazione con Alice: la pratica dello stillicidio da cui ogni volta rinasceva l’amore si era sciolta nella quotidianità della convivenza. Trascinare una lite e non guardarci in faccia per ore finché un dei due non si stancava e bastava una carezza per ritrovarci era una manutenzione sentimentale a cui avevamo smesso di ricorrere. Forse a questo servono i matrimoni. A disimparare. A non inventarsi più niente.
Finita la fase del rapimento passionale, il matrimonio appare come il luogo in cui l’invenzione viene meno, prevale l’incapacità di trovare ancora qualcosa per cui valga la pena lottare (invenio significa “trovare qualcosa dentro”). La relazione coniugale può diventare solitudine. Lo notava anche Roland Barthes: il discorso amoroso è oggi d’una estrema solitudine. E riportando una frase di Nietzsche, Barthes scriveva a proposito del rapporto tra due persone che si sono amate: eravamo amici e ci siamo diventati estranei. Noi siamo come due navi, ognuna delle quali ha la sua meta e la sua strada; possiamo benissimo incrociarci, forse potrà anche darsi che ci si veda, ma senza riconoscerci: i diversi mari e i soli ci hanno mutati.
Non riconoscersi, non saper trovare nell’altro qualcosa di familiare, non riuscire ad avere l’intimità necessaria: è quello che Magritte rappresenta nel suo noto quadro Gli amanti.
Dobbiamo dunque rassegnarci alla fine del sogno, al crollo dell’utopia del non lasciarsi mai? Oppure c’è un modo per tornare capaci di inventare, di trovare dentro l’altro qualcosa che ci appartiene e che siamo in grado di riconoscere come affine a noi?
Spesso si dice che in un matrimonio occorre tolleranza. Ma Fosco non sarebbe d’accordo: durante un’intervista, infatti, spiega che a lui la parola tolleranza proprio non piace e che persino nella Costituzione non esiste: la Costituzione non tollera, riconosce.
Forse la chiave sta tutta qui: riconoscere l’altro, lasciare che sia. Meno Ego e più Noi. Inventarsi e riconoscersi.
A dire il vero, che cosa sia l’amore è un problema enorme, è una questione ampiamente dibattuta e forse non ha trovato ancore risposta, anche se quelli che parlano d’amore sono convinti di sapere tutto sull’amore, come De Silva scrive nell’incipit di Sono felice, dove ho sbagliato?
Carver nel suo racconto Di cosa parliamo quando parliamo d’amore nota che tutte le conversazioni sull’amore, tutto questo amore di cui parliamo è solo rumore umano. Nessuno sa che cosa sia l’amore e definirlo è quasi impossibile. Eppure in questo romanzo scritto per parlare delle macerie di un amore, Fosco arriva a sentire profondamente che cosa sia l’amore, anche quando finisce.
Se le parole sono importanti per raccontare la fine di una relazione, non sono invece i discorsi a dare sostanza all’amore. Anzi. La tradizione ci insegna che spesso le parole e i bei discorsi nascondono le peggiori intenzioni: è quello che Medea rinfaccia a Giasone nella tragedia euripidea: ora non venire con quella maschera di rispetto rivolta a me e l’aria di uno abile nel parlare (v.586). La parola spesso è una maschera, non è affatto espressione di sincerità: εὐσχήμων (euschémon) è l’aggettivo che indica l’atteggiamento ipocrita di chi si finge buono nell’aspetto (eu, avverbio che traduce il concetto di “buono” + schema, aspetto) attraverso un uso ambiguo e manipolatorio delle parole.
Giuseppe Pontiggia – intellettuale che De Silva stima e cita nel suo romanzo – scriveva in Nati due volte: “Parliamoci chiaro”. Ho sempre temuto questa frase, che non è mai un invito alla trasparenza, ma l’apertura delle ostilità.
Per amarsi non servono tante parole, ma forse una sola, come dice Elsa Morante citata in esergo dall’autore: la frase d’amore, l’unica, è: “hai mangiato?”.
Ci sono episodi nel romanzo di De Silva, a questo proposito, molto indicativi. Uno, in particolare, riguarda due personaggi minori del romanzo, Innocenzo e Cristina, due amici che Fosco ritrova nel suo paese d’origine. Mentre sono seduti in silenzio, Cristina offre a Innocenzo uno spicchio d’arancia: piccole cose, gesti, sguardi più autentici di tante parole. Dice Fosco: ho sempre pensato che fosse quello il modo di amarsi. Sono queste le cose che fanno la punteggiatura della convivenza.
I titoli di coda di una vita insieme è anche un romanzo sul senso della perdita. A un certo punto Fosco ha una conversazione con la sorella sulla vendita della loro casa estiva, vendita di cui Fosco è pentito. E la sorella gli dice una frase che lo fa riflettere: hai perso una casa, e allora? Tu ci campi di questo. Non si scrive forse per raccontare quello che si è perso? Fosco avvia allora una seria analisi interiore: uno scrittore non colleziona cimeli. Tiene le cose che ha perduto in una stanza interiore dove nessuno può entrare.
Spesso si associa la perdita a una condizione luttuosa, di definitiva irrecuperabilità. Invece non è proprio così. C’è un verso di Montale, che in Piccolo testamento (da La bufera e altro) scrive:
una storia non dura che nella cenere
e persistenza è solo l’estinzione
Ciò che siamo oggi deriva anche da quello che abbiamo perso.
Persistenza è solo l’estinzione
Nulla finisce mai davvero. Le cose esistono. Sono affetti. Rimorsi. Oppure promesse, il più delle volte non mantenute, osserva Fosco.
Alcune cose poi, sono simboli, ci dicono: ho avuto un posto nel cuore di un altro. Perché una sola cosa vogliamo, arrivati alle sette di sera della vita: sapere che qualcuno ci ha amati.
In questo romanzo che è molto ancorato alla realtà c’è tuttavia un profondo tratto simbolico che vale la pena sottolineare.
Dopo due anni dalla separazione Alice, lontana per un convegno, chiede a Fosco di andare a casa sua per controllare la chiave di arresto dell’acqua. Fosco vede un libro di Alice, lasciato sul divano, e lo chiude dopo aver fatto un’orecchietta per conservare il segno della pagina.
I libri si chiudono, come le nostre storie, le nostre relazioni.
Ma alla fine ciò che conta è conservare il segno tra le pagine di una vita scritta insieme, perché lasciarsi non vuol dire perdersi, cancellarsi, annullarsi.

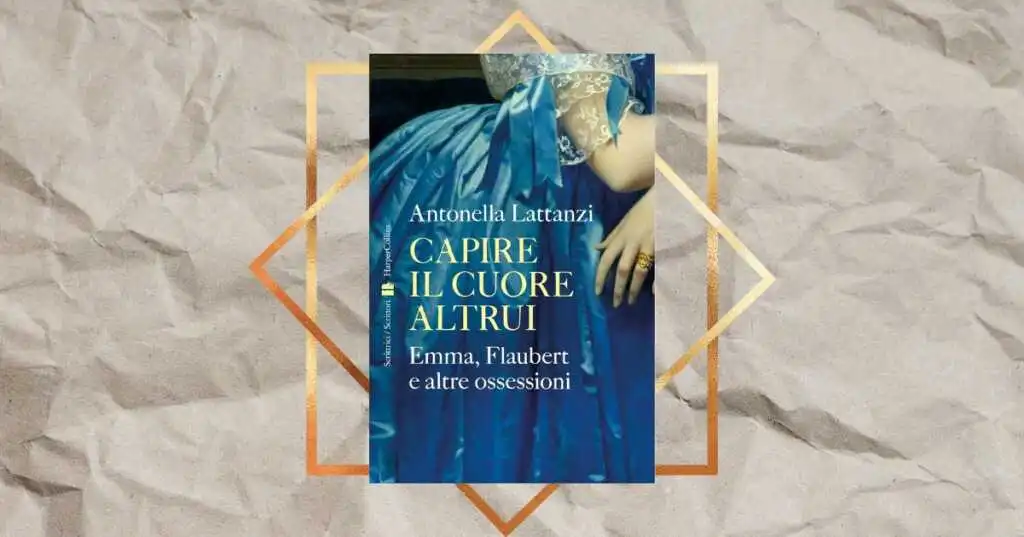
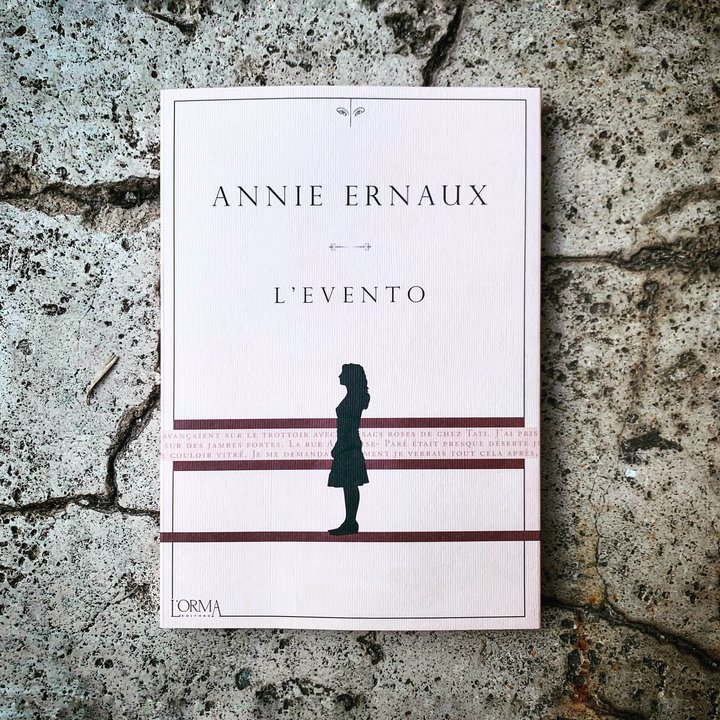

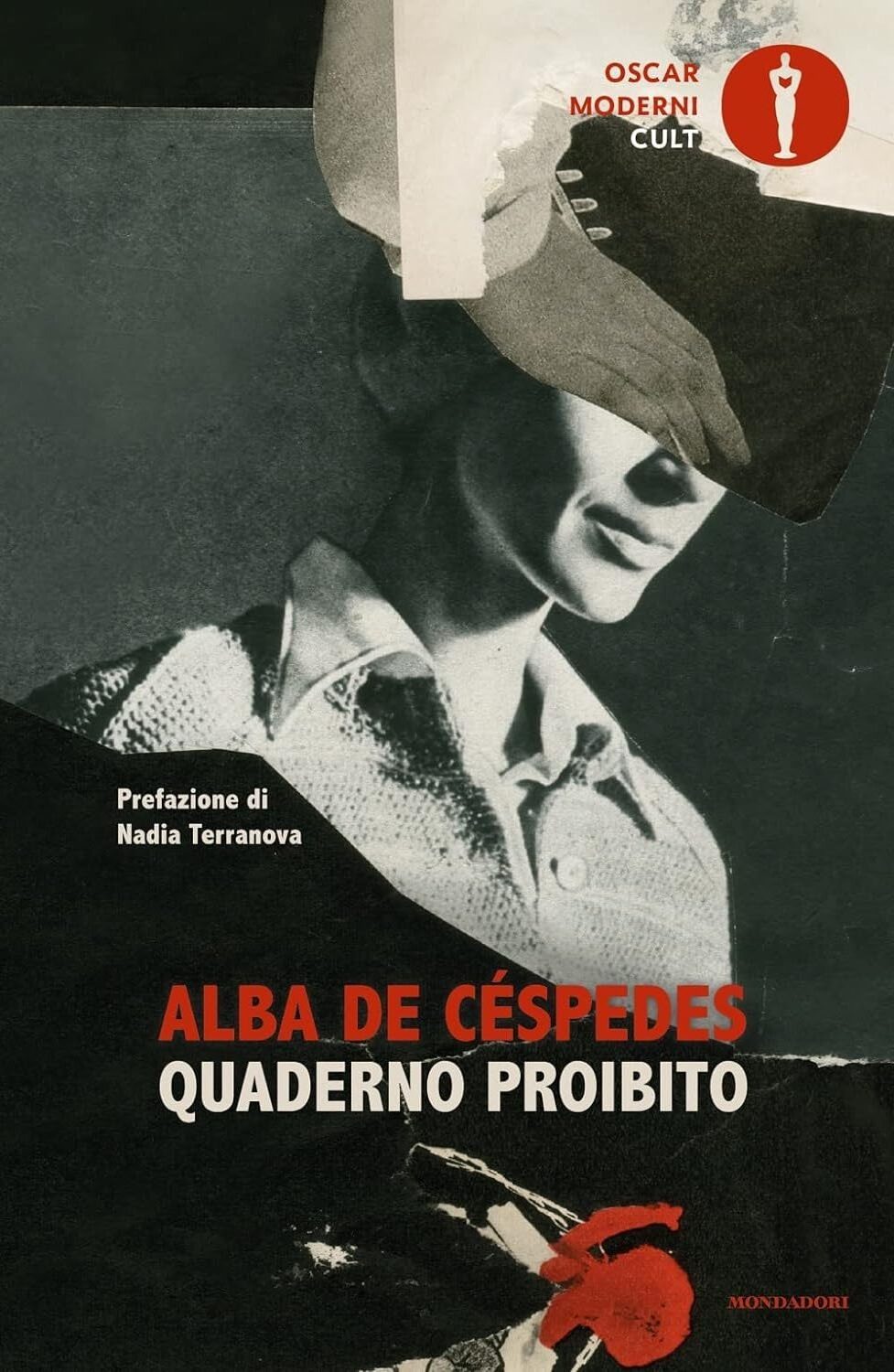
Devi fare login per commentare
Accedi