Filosofia
Quando la casa brucia: rovine, regni, testimoni
Qual è la casa/cosa che sta bruciando, crollando sulle proprie fondamenta, riducendosi a cenere, secondo il filosofo Giorgio Agamben? L’individuo, la famiglia, lo stato? L’Italia, l’Europa o il mondo intero? Certo, nella drammatica fase pandemica che stiamo vivendo, sembra non esserci più spazio per alcuna salvezza, personale o collettiva che sia. Agamben con amara lucidità avverte: intorno a noi solo “panico e furfanteria” di un potere che si illude di governare attraverso uno stato di eccezione permanente, di divieti, di esperti e di medici, di furbi tecnicismi intesi a nascondere “splendore e miseria”. Splendore di un passato come radice comune (“Ci sono ancora rami e fiori nel passato. E se ne può fare ancora miele”), in cui gli uomini mostravano con orgoglio, verità e autonomia il loro volto, rispetto a un presente di rovine, di maschere, in cui prevale la cecità di una vita puramente biologica, “una nuda vita muta e senza storia, in balia dei calcoli del potere e della scienza”, placata e soddisfatta della propria rassegnata mediocrità.
Il ’900, con le sue due guerre mondiali, ha senz’altro contribuito a far divampare le fiamme dell’incendio, che tuttavia già da secoli covavano minacciose sotto le braci, senza che nessuno volesse prestarvi attenzione, per paura o superficialità. “Ora la fiamma ha cambiato forma e natura, si è fatta digitale, invisibile e fredda”, ma continua a distruggere nell’indifferenza dei più, “così inconsapevoli da sembrare quasi innocenti”.
L’eterna contesa tra corpo e spirito, tempo ed eternità, terra e cielo, sembra oggi risolversi nel segno di una trionfante e banale materialità, in attesa che tutto frani definitivamente. Ma non è giusto tirarsi da parte, rinunciare a opporsi: “Può darsi che la vita sparisca dalla terra, che nessuna memoria resti di quello che è stato fatto, nel bene e nel male. Ma tu continua come prima, è tardi per cambiare, non c’è più tempo”.
Quale forma di resistenza allo sfacelo si deve mettere in atto, allora? Agamben suggerisce che l’unica risposta può arrivare dall’esercizio di un pensiero che sappia coniugare filosofia e poesia, capaci entrambe di parlare una lingua sorgiva, vitale, sottratta al rumore indistinto del vaniloquio. La parola della poesia è profetica, oscura, scomoda e quasi sempre inascoltata. Ad essa Agamben dedica il terzo capitolo del suo libro, scandito in paragrafi nominati con le lettere dell’alfabeto ebraico.
Perché è tanto difficile per gli uomini prestare orecchio ai profeti? Perché essi, ricordando l’eterno, fanno continuamente riferimento al Regno, presente qui e ora, sempre, anche se non avvertito né riconosciuto. Il Regno è atteso e annunciato da un segnale, talvolta minimo, spesso incomprensibile: da una parola non significante, non regolata grammaticalmente, ma allusiva e nuova, originaria. La sa cogliere e ripetere il poeta, “un’anima altrimenti vivente”, che inerme e inservibile, esprime sommessamente un annuncio, “al di là e al di qua di ogni lingua”, mentre intorno le fiamme incombono minacciose. Il Regno non è una meta da raggiungere, un eden metastorico, né una struttura politica: si avvera solo attraverso la sua unica realtà, che è la parola. “La parola del Regno non produce nuove istituzioni né costituisce diritto: essa è la potenza destituente che, in ogni ambito, depone i poteri e le istituzioni, compreso quelli, chiese o partiti, che pretendono di rappresentarla e incarnarla”. Per deprivare del potere i vari poteri che dominano la terra, bisogna prima deporre la lingua che li fonda e sostiene: oggi questa lingua “esibisce ovunque la sua vacuità e la sua afonia, si fa chiacchiera o formalismo scientifico”. Solo la poesia, solo il dialetto, nel loro opporsi al consueto ratificato, sanno superare l’asservimento del significante, chiamando le cose all’aperto, rendendole non più fatti ma eventi, epifanie del Regno.
Ancora intorno alla funzione del dire e del tacere si articolano le altre due sezioni del libro di Agamben, (come le precedenti esposte con intensità aforistica e accenti di ispirato lirismo), in cui viene vagliato il ruolo giocato dalla parola nella contiguità dei termini soglia e porta, e nella fragilità della testimonianza quando è chiamata a misurarsi con la verità.
La porta si apre e si chiude, indica un passaggio o un blocco, un limite o il superamento del limite, il dentro o il fuori dell’azione e del pensiero.
La testimonianza sancisce “l’incapacità del linguaggio di enunciare in modo assertorio la verità” – che di per sé non è mai verificabile –, e pertanto è contrassegnata da incomunicabilità e solipsismo: “testimone è colui che parla unicamente in nome di un non poter dire”, colui che esperisce l’impossibilità di enunciare la verità in una proposizione. Il testimone parla del/al passato, e in favore di chi non può farlo: i morti, gli animali, i dementi, le cose; testimonia, quindi, innanzi tutto per la sua lingua, lontana da ogni possibilità di comunicazione, di riflessione.
È stata l’esperienza di Hölderlin quando, chiuso nella sua torre sul Neckar, ha disattivato ogni funzione discorsiva dalla propria poesia, sperimentando il grado zero della parola, il nulla di una lingua senza più mondo, l’ammutolimento, la consapevolezza di non poter conoscere. “La testimonianza è un idioma fatto solo di vocativi, cioè di parole che non significano, ma chiamano per nome gli altri, le cose”. Nessun contesto semantico, negli inni tardi di Hölderlin; solo lemmi staccati, congiunzioni, cesure, che sperimentano del suo incontro solitario con la lingua. Il silenzio finale del poeta tedesco (a cui Giorgio Agamben ha dedicato il libro più recente, pubblicato da Einaudi) è quello del testimone lasciato solo, consapevole di non sapere e non volere enunciare alcuna verità.
“Una poesia scritta nella casa che brucia è più giusta e più vera, perché nessuno potrà ascoltarla, perché nulla assicura che possa scampare alle fiamme. Ma se, per un caso, essa trova un lettore, allora questi non potrà in nessun modo sottrarsi all’apostrofe che lo chiama da quell’inerme, inspiegabile, sommesso vocìo. Può dire la verità solo chi non ha nessuna probabilità di essere ascoltato”.
GIORGIO AGAMBEN, QUANDO LA CASA BRUCIA
Giometti & Antonello, Macerata 2020, pp.88




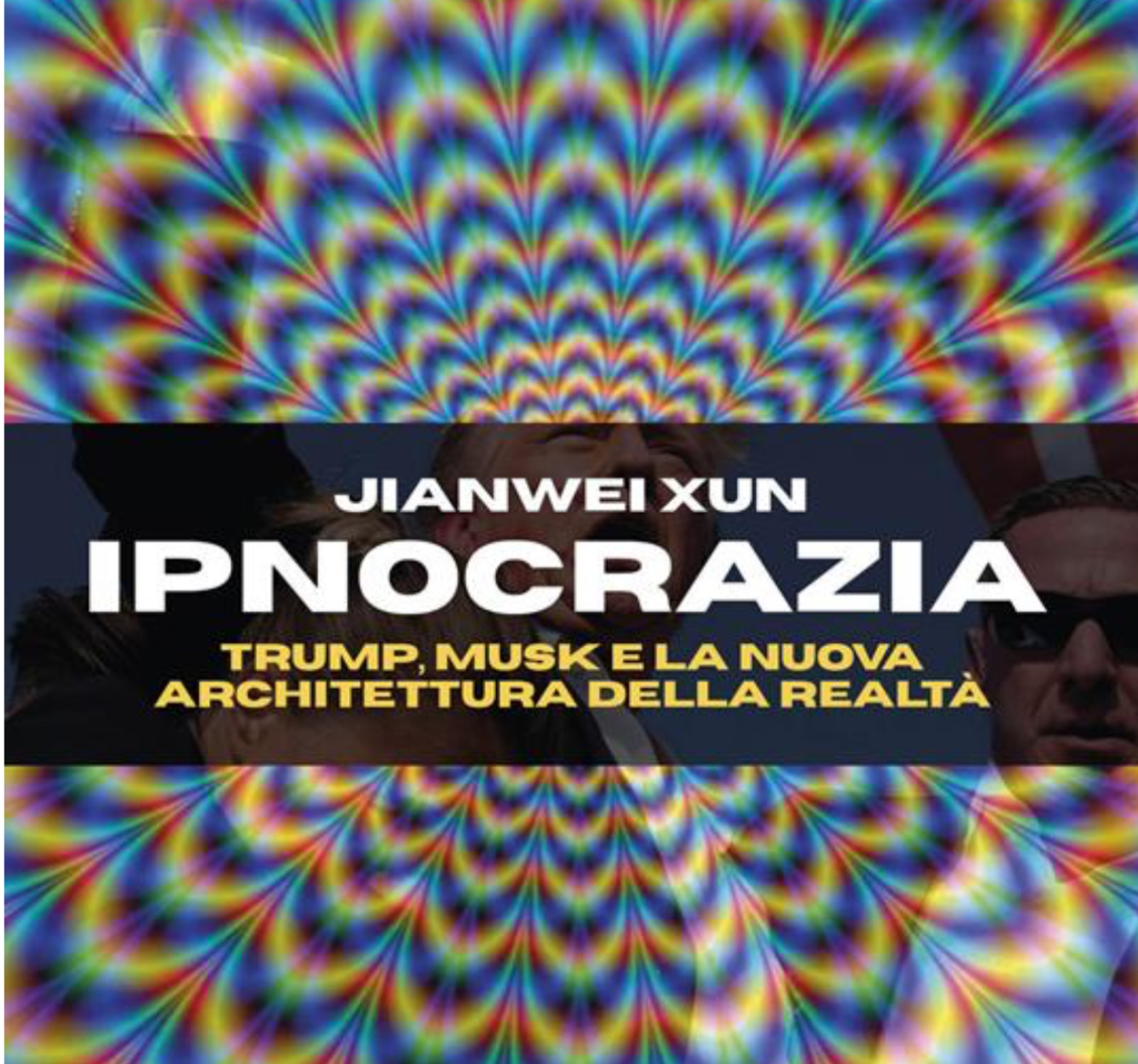
Devi fare login per commentare
Accedi