Cinema
LIBRI La commedia all’italiana in 160 film
Intervista ad Andrea Pergolari, coautore di La commedia all’italiana in 160 film. 1948-1980 (Edizioni Sabinae, 2022)
In un libro sul cinema l’Italia del dopoguerra e l’avvicendarsi sullo schermo di diverse figure sociali: proletari e contadini dei film degli anni ’50 e ’60 spinti ai margini per fare posto agli yuppies e a un “ceto medio” autoreferenziale e privo di slanci. Uno specchio di quanto è successo nella società italiana.
È uscito a fine aprile La commedia all’italiana in 160 film 1948-1980 di Alberto Pallotta e Andrea Pergolari, edito da Edizioni Sabinae, attualmente al quinto posto nella classifica dei libri sul cinema italiano di Amazon. Sono 160 film in altrettante ampie schede complete dei principali dati: anno, durata, regia, soggetto e sceneggiatura, cast, produzione e maestranze meticolosamente annotati e seguiti da un’ampia sezione “sinossi e critica”. Un libro, ci spiega Andrea Pergolari, che vuol essere la testimonianza di un approccio diverso a questo genere cinematografico, una ricostruzione meno normativa e basata sulle “grandi personalità” e più attenta, invece, a cogliervi il lavoro corale di un folto gruppo di artisti e intellettuali più o meno grandi, alcuni “scandalosamente sottovalutati” – osserva – che si incontrano, prevalentemente a Roma, e si scambiano idee, collaborano e si avvicendano tra loro, spesso revisionando l’uno il lavoro dell’altro. Con Pergolari proviamo a scandagliare anche il significato sociale e politico della commedia all’italiana, perché il cinema può essere utilizzato anche come una lente per analizzare la società, cogliendone in controluce alcuni aspetti che spesso le scienze sociali sottovalutano.
In Italia ad alcuni generi cinematografici si è guardato con una certa superiorità. Nel suo documentario dedicato a Moricone Tornatore ci ha raccontato dell’imbarazzo del musicista a firmare le colonne sonore dei western di Sergio Leone. Anche la commedia all’italiana è stato oggetto di questo snobismo intellettuale. Ma nell’Introduzione al vostro volume Guido Vitiello scrive che la commedia all’italiana è il vero film politico. A cosa è dovuto quell’atteggiamento?
Questa è un po’ la domanda centrale su cui è imperniata l’intera storiografia su questo genere cinematografico. E riflette un atteggiamento che tutti quelli che hanno fatto la commedia all’italiana hanno sperimentato sulla propria pelle. Un atteggiamento che in realtà risale alla notte dei tempi. Già Aristotele faceva della commedia un genere minore. Umberto Eco su questo tema ha scritto Il nome della rosa. La commedia, insomma, sin dall’antichità è considerata un’imitazione della realtà e dei suoi aspetti più bassi e materiali, mentre dramma e tragedia vengono visti, al contrario, come una sublimazione dei sentimenti e degli aspetti più elevati dell’esistenza umana. Una seconda considerazione a questo proposito è che i critici, che sono stati tra i maggiori fautori di questo snobismo intellettuale, sono fondamentalmente tristi e seriosi nei loro giudizi. Terzo aspetto: spesso si fa confusione tra commedia e film comico. Il film comico è quello in cui per far ridere si usano gli espedienti più banali: si ride perché un personaggio inciampa e cade a terra oppure perché si fa la pernacchia. La commedia è un’altra cosa e la commedia “all’italiana”, definizione in origine anch’essa dispregiativa, ha un’ulteriore peculiarità: è un modo di raccontare fatti spesso drammatici ma con uno sguardo cinico e disincantato, un incrocio di dinamiche diverse tra il fatto e ciò che l’occhio dell’autore vede in quel fatto. Uno dei massimi esponenti della commedia all’italiana, Monicelli, è un vero e proprio cantore delle gesta dei disperati, di chi, qualunque impresa inizi, è destinato al fallimento. E da lì alla politica il passo è breve.
A proposito di Monicelli, nel libro voi citate la sua celebre frase per cui la commedia all’italiana è finita quando i registi hanno smesso di salire sugli autobus. E in effetti nel cinema italiano sembra essere accaduto qualcosa di simile a quello che è successo nella società e nella politica: i proletari sono stati messi da parte e molti di loro, almeno fino a un certo punto, hanno sognato di essere diventati – e in qualche misura si sono sentiti – ceto medio, questa non-classe sociale che tutti citano ma non si capisce bene cos’è.
Non c’è dubbio. Oggi tutti i personaggi che vediamo al cinema, anche il disoccupato, vivono in una casa che ricorda le abitazioni borghesi dei “telefoni bianchi”. Come se si fosse completamente persa la capacità di adeguare ambiente e personaggi. I proletari sono una classe che per chi fa questo cinema non ha più significato. È un cinema fatto da borghesi che si rivolgono ad altri borghesi come loro.
Di recente, però, in Europa i sondaggi hanno registrato una rinnovata percezione di sé come proletari e in alcuni paesi il cinema si è adeguato. Penso al cinema britannico, non solo Loach, ma anche film come “Grazie Signora Thatcher” e “Pride” oppure, in Francia, a registi come Cantet e Guédiguian. In Italia invece no. Perché secondo te?
Non saprei dirtelo con precisione. Un primo aspetto può essere che dal punto di vista produttivo da noi è molto difficile mettere in cantiere film come quelli che hai citato, perché la produzione è in mano ai distributori, che a loro volta sono in mano alle tv, che vuol dire Rai e Mediaset. E ovviamente è molto difficile che Rai e Mediaset accettino quel tipo di opera, per cui, se non c’è un produttore che rischia, il film non si fa. Poi può essere che ci sia un problema anche sul versante degli autori, perché forse siamo una società più consumata dal consumismo di altre. Ma credo che il problema sia essenzialmente produttivo.
Suddividiamo schematicamente il dopoguerra in tre fasi: la ricostruzione fino agli anni ‘50, il boom economico e il periodo delle grandi mobilitazioni degli anni ’60-’70 e il riflusso degli anni ’80 e ’90. Quali sono secondo te le tre commedie italiane più rappresentative di questi tre periodi? E perché?
Non è facile rispondere. Intanto posso dirti che mentre il primo periodo, gli anni ’50, è abbastanza omogeneo, gli anni ’60 sono diversi dagli anni ’70. Negli anni ’50 lo sfondo della commedia all’italiana, ma anche dei film comici come quelli di Totò – pensa a “Totò, Peppino e la malafemmina” del 1956 – è l’Italia della ricostruzione, con una società ancora largamente legata alla campagna e talvolta il tema è proprio l’inurbamento. Un film rappresentativo degli anni ‘50 potrebbe essere “Guardie e ladri” di Steno e Monicelli, con Totò e Aldo Fabrizi, in cui poliziotto e ladro, pur rispecchiando figure e ceti sociali diversi, alla fine appaiono tutti e due vittime della società. Oppure “Due soldi di speranza”, di Renato Castellani, palma d’oro a Cannes nel 1952, che racconta l’Italia contadina della campagna napoletana ed è considerato il primo esempio di neorealismo rosa, cioè di un genere che descrive l’italia di quegli anni e i suoi problemi in maniera realistica, ma utilizzando i toni della commedia. Gli anni ’60 rappresentano il boom della commedia italiana. Potrei citarti “Il sorpasso” di Dino Risi oppure un altro film di Risi, “In nome del popolo italiano”, che esce nel 1971 e anticipa già il riflusso. Ma a partire dagli anni ’80 lo sguardo degli autori non si concentra più sull’italia contemporanea e in ogni caso c’è sempre un’ambiguità di fondo. Pensa a un film come “Yuppies”, di Carlo Vanzina, che descrive con ironia una generazione di professionisti che cerca esclusivamente i soldi e il successo, ma alla fine non si capisce se l’autore li critichi o piuttosto ne sia affascinato.
Quanto ha contato il PCI negli anni d’oro della commedia all’italiana?
Parecchio. In fondo tutti i grandi protagonisi di quegli anni erano comunisti o socialisti. Scola e Loy, ad esempio, erano del PCI, mentre Monicelli nasce socialista e alla fine approda a Rifondazione, insomma, invece di imborghesirsi fa il percorso opposto. Magni era anche lui comunista ed era solito accusare i critici di apprezzare il cinema borghese, cioè il cinema del “nemico di classe”. Scola fu anche ministro della cultura del “governo ombra”. Quando oggi si dice il cinema era in mano alla sinistra, quindi, si dice una cosa abbastanza vera: l’80% di chi praticava la commedia all’italiana era di sinistra. Poi però c’era anche il rovescio della medaglia. In quegli anni i critici di sinistra sono quelli che criticano maggiormente la commedia all’italiana perché pensano che sia il cinema del disimpegno. E Moravia, uno dei pontefici della cultura laica di sinistra, esercita un ruolo determinante nell’affossare quel genere, che lui non amava e non capiva, considerandolo un modo di fare cinema stereotipato, lontano dalla realtà.
Col riflusso i proletari scompaiono non solo davanti alla camera, ma anche dietro. Il settore del cinema, che a Roma dà ancora lavoro a decine di migliaia di persone, vive un processo di deindustrializzazione che per certi versi ricorda le fabbriche: non solo vengono distrutti posti di lavoro, ma ci sono professionalità che rischiano di scomparire – si pensi a Cinecittà – e diminuiscono diritti e salari.
Il cinema italiano muore a metà degli anni ’70. Lo spartiacque è il 1976, quando nascono le televisioni commerciali e i produttori cinematografici svendono tutti i diritti dei loro film al mercato televisivo che sta nascendo. All’epoca l’industria del cinema italiano produceva centinaia di film l’anno e i film di genere, come la commedia all’italiana, ma anche le commedie scollacciate, i poliziotteschi, i film horror e quelli erotici, costituivano la base del mercato. E figure professionali come scenografi e stuntmen vivevano grazie a questa produzione di massa. Con l’avvento della televisione commerciale finisce un’epoca. I film, una volta proiettati in sala, vanno subito in tv e poi, esauriti i titoli del cinema, le emittenti televisive cominciano anche a produrre. Le commedie scollacciate si trasformano in show televisivi. Pensa a Drive in, dove trovi gli stessi attori protagonisti di quel genere, come D’Angelo e Boldi. I film polizieschi invece danno origine ai telefilm, ma quando poi in Italia si è cominciato a importare l’Ispettore Derrick o i telefilm americani a qual punto si è smesso di produrre. Per una decina d’anni del cinema di genere sopravvive solo la commedia all’italiana e alla fine poi sparisce anche quella fino a che negli anni ’90 i registi cadono nella completa autoreferenzialità.
Oggi la pandemia, che ha fatto entrare le piattaforme come Netflix nelle case di milioni di famiglie, sta facendo il resto. Qual è secondo te la prospettiva?
Mi pare difficile che se ne esca. Ormai tutto viene spinto verso una individualizzazione della visione. Il cinema è un fenomeno collettivo, come il teatro. Fino a un certo punto era anche una pratica condivisa, portata avanti da un gruppo di intellettuali più o meno grandi che si incontravano e si scambiavano idee. Roma, da questo punto di vista, è sempre stata un luogo di circolazione delle idee. Oggi mi pare invece che si vada verso una società che si chiude in se stessa, dove si preferisce vedere i film a casa, magari sul telefonino. E questo da una parte ti dà l’ebbrezza di arrivare ovunque, ma dall’altra ti spinge verso una forma di autismo. Che questo sia frutto o meno di un disegno generale il dato di fatto è che si marcia verso la scomparsa della condivisione e questo a me sembra un processo terribile e irreversibile. Per certi versi mi pare più probabile che riesca a uscirne in teatro, perché è un’esperienza aperta, di contatto diretto col pubblico.
Intervista tratta dalla newsletter di PuntoCritico.info del 10 giugno.


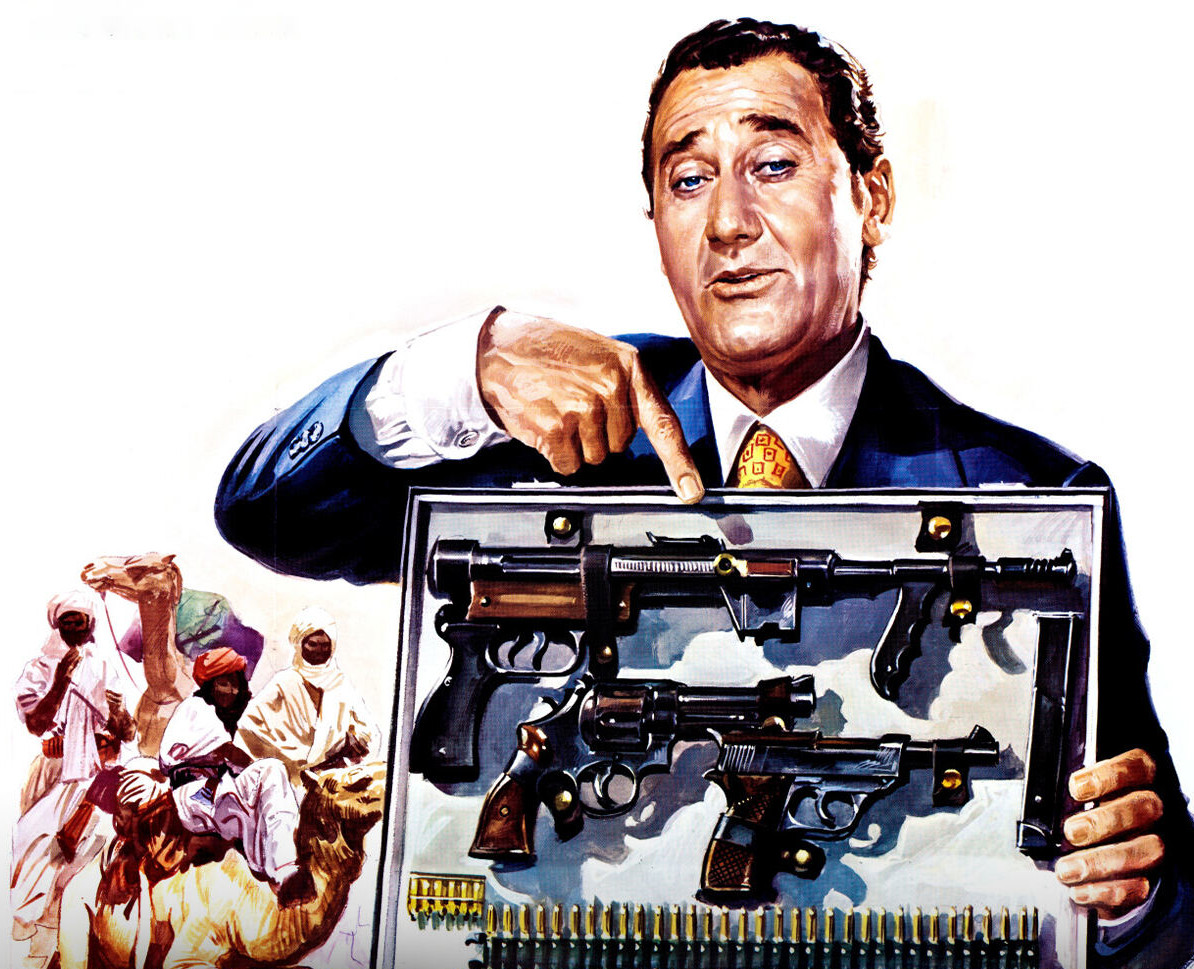
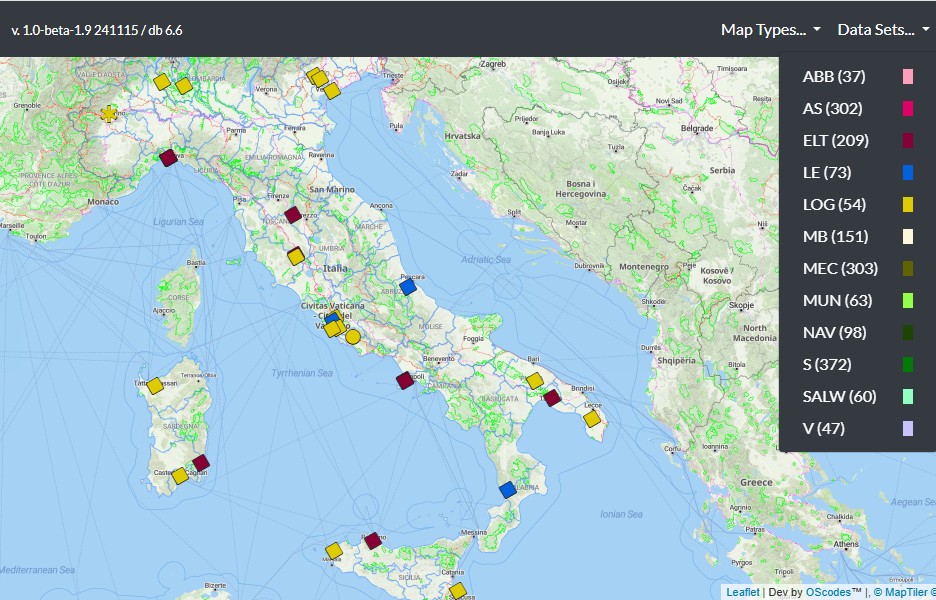

Devi fare login per commentare
Accedi