Immigrazione
Una storia (vera) per raccontare lo Ius Soli
Tanti anni fa, insieme a una collega, aprimmo un ufficio nel centro di Roma, in via del Viminale, proprio di fronte al Teatro dell’Opera. Eravamo due giovani forse un po’ incoscienti che avevano deciso di far nascere una società di comunicazione proprio nel bel mezzo della crisi economica, in anni in cui di startup ancora non si parlava e senza il portafoglio di mamma e papà alle spalle: pochi soldi a disposizione e intere giornate di lavoro per lanciare l’attività, cercare clienti e accontentare quelli che già avevamo. Una delle nostre prime esigenze fu quella di trovare un ristorante della zona con cui fare una sorta di convenzione per pranzare decentemente a cifre ragionevoli, cosa non facile nel centro della Capitale. La scelta cadde su un piccolo ristorante cinese a conduzione familiare a pochi passi dal portone del palazzo dove avevamo lo studio. Era gestito da una simpatica signora di nome Shu (non credo si scriva così), dal marito e dalla figlia poco più che maggiorenne nata e cresciuta in Italia.
Il locale di Shu non era uno dei tanti ristoranti cinesi che si trovano in tutte le città: arredamento da bettola, pochissimi tavoli, cucina espressa e tante varianti sul tema, come l’italianissima pasta condita con verdure di stagione che la stessa proprietaria andava a comprare nel supermercato poco distante, aiutandosi con il carrello che prendeva in prestito per trasportare le tante buste, proprio come le signore di una volta. Piatti che oggi qualche giovane chef definirebbe “cucina fusion”, ma che in quel contesto altro non erano che riusciti esperimenti di una coppia di migranti fantasiosi che per non farsi schiacciare dal locale dei connazionali da trecento coperti e arredamento brandizzato a poche centinaia di metri, avevano pensato un’offerta alternativa.
Ormai lì da tanti anni, “Shu” (così veniva chiamato il ristorante senza insegna all’esterno, ma solo una lanterna cinese mezza rotta) era luogo di ritrovo della variegata umanità che frequentava il quartiere, dai dipendenti dei tanti uffici della zona ai tipici inquietanti avventori della stazione Termini, dai turisti attratti da una buona recensione della Routard agli agenti della Digos in borghese, volti ormai così noti agli spacciatori di Piazza della Repubblica che tanto valeva girassero con la divisa da cerimonia e lo spadino. Ritrovavi le stesse persone anche la sera, magari con le loro famiglie. Una piccola comunità che ormai si riconosceva nel calore di quelle quattro mura spoglie.
Andare a mangiare da Shu era sempre un’esperienza unica. La proprietaria e sua figlia si fermavano volentieri a parlare con i clienti, mentre il marito – schiavizzato in cucina – preparava le portate. A differenza della madre che faticava non poco con l’italiano, la giovane non parlava bene il cinese e si esprimeva in perfetto dialetto romanesco, rendendosi protagonista di scene talvolta esilaranti. Difficile dimenticare le sue comande urlate: «A ma’! Me segni du ravioli de carne e du ‘nvortini!?» con la povera madre che a pochi metri ripeteva segnando sul taccuino: «Tue laviolo calne, Tue involtino». Fidanzata con un “truzzissimo” ragazzo di periferia innamorato alla follia, la ragazza di cinese aveva solo le fattezze e questo rendeva comico ogni dialogo. Perché sì, era uno spasso parlare con una cinese che si esprimeva come la Sora Lella in un film di Verdone, ma bellissimo, perché era una piccola testimonianza di una società in evoluzione, un’evoluzione inarrestabile malgrado chi – ieri come oggi – tenta di porsi come zavorra, agitando paure e fantasmi. La figlia di Shu amava sedersi ai tavoli e parlare del più e del meno, rallentando l’assai precaria organizzazione messa in piedi dalla madre, che spesso la riprendeva. Ti raccontava la sua vita e quella della sua famiglia, dalle troppe tasse da pagare ai corsi che seguiva all’università, dalle lezioni di pianoforte della madre a quei signori con l’accento del sud che periodicamente andavano a chiedere soldi ai genitori, venendo cacciati in malo modo. Il ristorante di Shu non era nei circuiti organizzati più o meno legali dell’enorme comunità cinese in Italia; non godeva quindi di alcuna “protezione” e il suo destino era segnato, un po’ come quello della nostra società di comunicazione, che di lì a poco dovemmo chiudere.
Oggi, dove un tempo c’era “Shu”, c’è uno dei tanti “ristorante caffetteria” identico ad altri mille che si trovano nel centro. Lampadine a filamento all’ultima moda, finto mattoncino alle pareti, foto in bianco e nero della Roma di un tempo: un locale tra i tanti, probabilmente arredato da qualche giovane aspirante architetto che sbanca il lunario copiando altri giovani aspiranti architetti. D’altronde, siamo un paese in cui non ci sono più artigiani e pescatori, ma solo l’anno scorso sono stati abilitati più architetti di quanti ce ne sono in tutta la Francia.
In questi mesi in cui l’Italia (tanto per cambiare) si divide tra #noiussoli e #siiussoli, mi è tornato spesso alla mente quel piccolo ristorante e quella simpatica ragazza. Fosse ancora lì, avrei volentieri consigliato ai tanti che parlano a sproposito dei migranti e dei loro figli nati in Italia di andarci a cenare una sera e di chiedere alla figlia di Shu cosa vuol dire nascere, crescere, studiare e lavorare in un paese dove sei considerato a vita uno straniero, se non addirittura un “invasore”. Dopo mezz’ora e diversi richiami della madre, la figlia di Shu si sarebbe congedata con quella sua solita frase: «Mo’ ve saluto che me tocca annà a fa ‘a cinese sinnò mi madre se stranisce»…


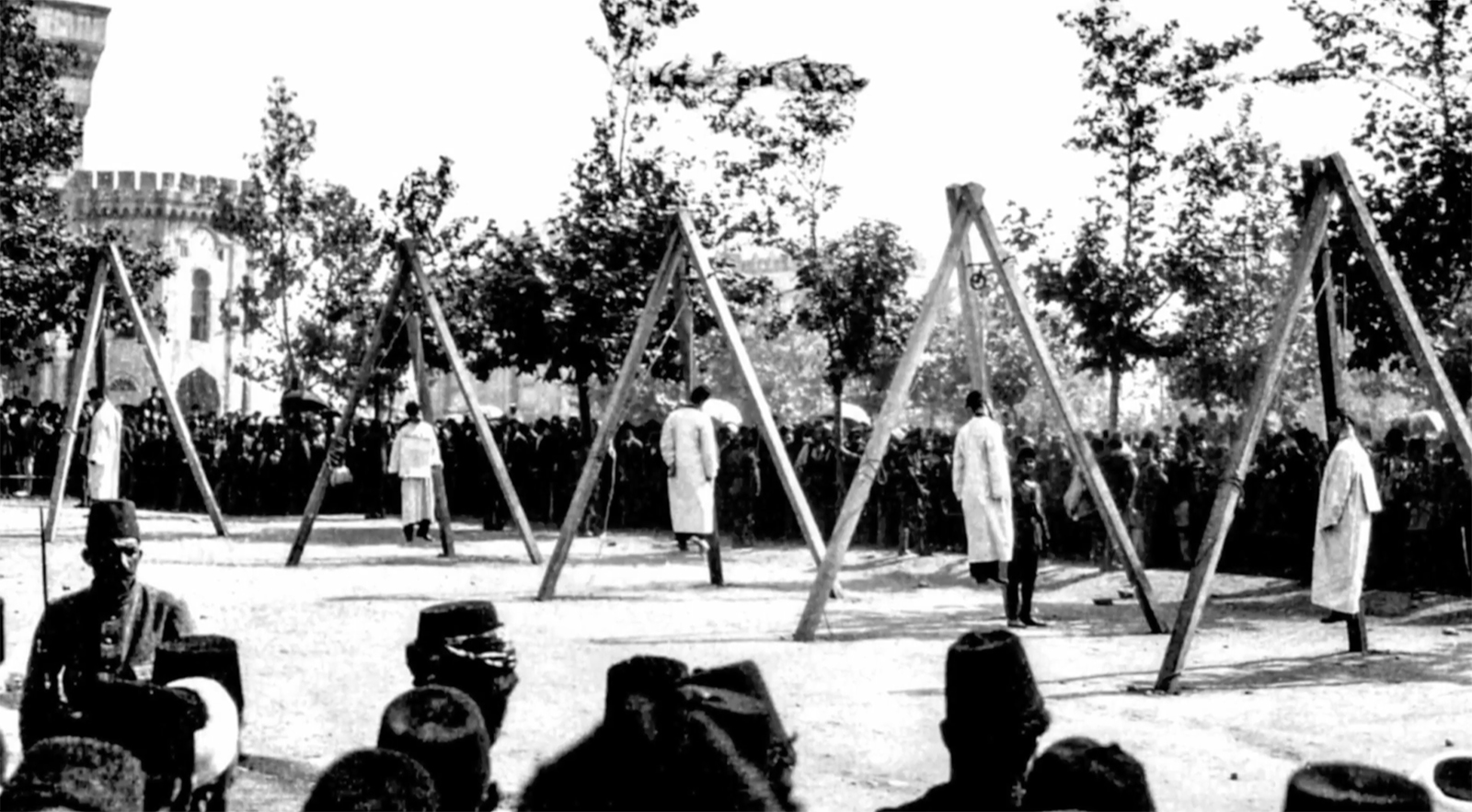


Devi fare login per commentare
Accedi