Immigrazione
Gli unici davvero vivi
Le proteste mondiali dopo l’uccisione di George Floyd da parte di un poliziotto di Minneapolis dimostrano che anche da una tragedia può venir fuori qualcosa di buono. È urgente che gli Stati Uniti riflettano sui limiti di una democrazia che mostra un volto feroce verso una parte consistente dei suoi cittadini, così come è urgente che in tutto il mondo si rifletta – in modo non retorico – sul persistere del razzismo e della discriminazione.
Se la morte di Floyd ha avuto questo effetto, è stato perché di quell’omicidio c’è stata una testimonianza fotografica. La foto del poliziotto bianco con il piede sul collo dell’uomo nero, con un’espressione sicura, quasi trionfale, incarna in realtà un archetipo dell’inconscio collettivo occidentale e cristiano: il bene, bianco, che prevale sul male, nero; l’arcangelo Gabriele che schiaccia la testa al Diavolo. Se in quella che con ogni probabilità è la sua prima rappresentazione artistica – i mosaici di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna – il Diavolo è un angelo che si differenzia dagli altri solo per il colore blu della tunica, ben presto, man mano che si consolida l’iconografia cristiana, tingendo la pelle di Cristo e della Madonna di un improbabile colore pallido e i capelli perfino di biondo, Satana diventerà nero. E il nero diventerà satanico. Ma il dispositivo funziona solo se c’è un contesto narrativo, una demonizzazione retorica della vittima. In questo caso c’era solo un uomo che invocava pietà, ucciso da un uomo senza pietà.
Quella della scena di Minneapolis è una violenza diretta, che però non ci sarebbe stata senza altre forme di violenza. Violenza diretta è la violenza di un pugno, di un colpo di pistola, di una coltellata. Meno visibile è la violenza culturale. Quella violenza, ad esempio, che in alcuni contesti fa sì che le donne siano considerate meno importanti degli uomini, e quindi costrette alla sottomissione; e quando quella sottomissione non c’è, può accadere la violenza diretta. No, non parlo di Islam. Non solo, almeno. Parlo del nostro Paese. E c’è poi una violenza ancora più sottile. Quella che Johan Galtung chiama violenza strutturale. È la violenza che viene agita non da un singolo o da un gruppo, ma da un intero sistema sociale. C’è qualcuno che soffre, c’è qualcuno che muore, ma ecco, la colpa non è di nessuno. Come nella Dogville di Lars von Trier, la collettività può considerarsi buona ed accogliente; e tuttavia qualcuno muore.
Questa mattina una persona è morta nell’incendio della baraccopoli di Borgo Mezzanone, a Foggia. Dico persona perché al momento non si sa se è un uomo o una donna. Può essere che non lo si sappia mai. Molti dei migranti morti nelle campagne foggiane restano senza nome. Molti anni fa pubblicavo, a Foggia, un foglio libertario che si chiamava Tophet. Nel primo numero buttai giù un elenco dei migranti morti negli ultimi mesi nelle campagne foggiane. Una ventina di persone, per lo più rimaste senza nome. Molti investiti mentre cercavano di raggiungere i terreni nei quali lavoravano, molti morti in circostanze mai chiarite; qualcuno morto di freddo. Il contesto è noto. E per dire le cose come sono, bisogna usare una parola terribile: schiavitù. La usò Fabrizio Gatti, in un reportage sull’Espresso del 2006. Gatti si finse immigrato e fu ingaggiato come bracciante nelle campagne foggiane. Poi raccontò tutto; e il titolo del suo racconto era: “Io schiavo in Puglia”.
Sì, a Foggia c’è la schiavitù. Vera, non metaforica. A Foggia ci sono persone che lavorano in condizioni terribili, sfruttate a sangue, senza il minimo rispetto della loro dignità umana; persone che vivono in baracche di lamiera, in ghetti che, se fossimo meno distratti, sarebbero la vergogna di questo Paese, in ghetti che, se fossimo meno disumani, sarebbero tutti i santi giorni sulle prime pagine dei giornali. Persone che vivono in baracche di legno e lamiera che vanno a fuoco, e li uccidono. Chi li ha uccisi? Chi è stato?
A Foggia non c’è solo la schiavitù. C’è qualcosa di cui la schiavitù ha bisogno, senza cui la schiavitù non esisterebbe. Non mi riferisco solo all’indifferenza. A Foggia c’è un razzismo schifoso, un razzismo da Ku Klux Klan, che è qualcosa di diverso da una semplice espressione di ignoranza. È quella violenza culturale senza la quale la violenza strutturale non sarebbe possibile. Non puoi compiere ingiustizia verso qualcuno e al tempo stesso sentirti a posto. Stai facendo il male, e lo sai. Per cavartela con te stesso hai bisogno di disumanizzare l’altro, di scorgere in lui, contro ogni evidenza, non una vittima, ma una minaccia. Hai bisogno di rovesciare la realtà e di vedere in te – in te sfruttatore economico degli uomini e sfruttatore sessuale delle donne – una povera vittima, minacciata dall’invasione di esseri minacciosi e pericolosi.
Gli schiavi delle campagne foggiane hanno cominciato da qualche tempo la loro lotta. In una solitudine quasi assoluta, scendono in piazza per rivendicare i loro diritti, la loro umanità. Accolti dallo scherno, dal disprezzo e dall’odio generale a livello locale; dalla semplice indifferenza a livello nazionale. Loro continueranno a morire, noi a sentirci minacciati da loro. Ma gli unici davvero vivi, in questo Paese in rovina, sono loro.
Foto: Il Mattino di Foggia.

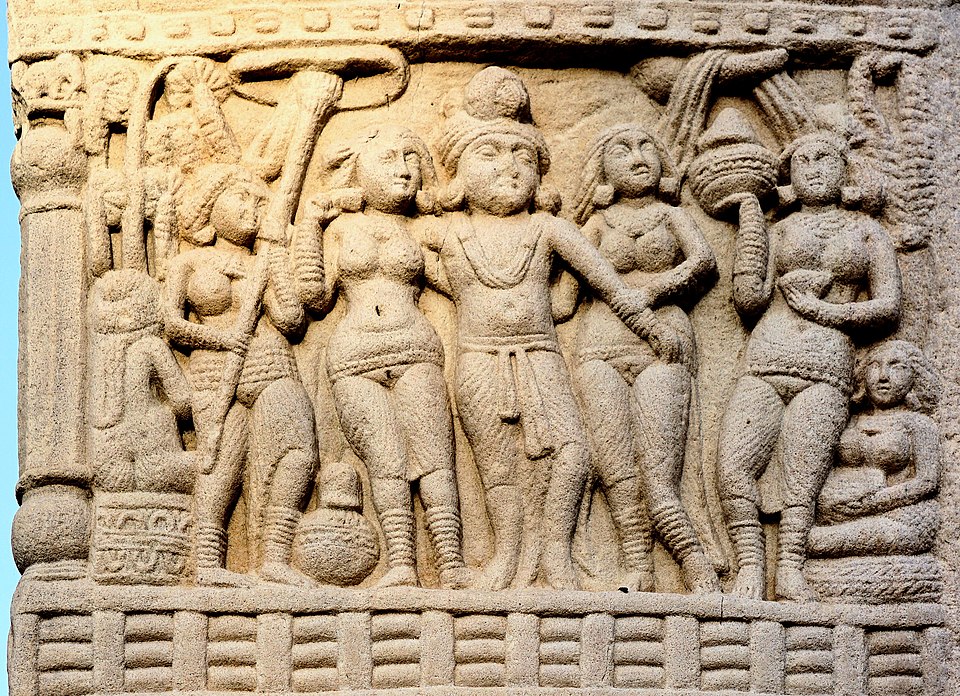


Devi fare login per commentare
Accedi