Roma
Passeggiata romana
Oggi un mio amico posta su facebook la sigla iniziale de Il segno del comando, uno sceneggiato televisivo di Daniele D’Anza del 1971. Mi balza il cuore in gola per l’emozione. Vidi lo sceneggiato poco più che adolescente, era il 1971, e mi piacque tantissimo. Avrei voluto linkare all’amico un mio pezzo su Linkiesta dove ricordavo quella Roma barocca favolosa che faceva da sfondo allo sceneggiato televisivo. Purtroppo Linkiesta lo ha eliminato dai suoi archivi. Lo ripropongo qui.
^^^
Tre ore inaspettatamente libere da impegni, prima che parta il treno per Milano, sono un’occasione troppo ghiotta per farsi una stendhaliana passeggiata romana. Ne ho fatte sempre e ne farò ancora tutte le volte che mi capiterà (una mi stava costando anche carissima in termini di prospettive di carriera. Sì, la carriera: una ossessione tragica e comica ad un tempo nella vita di tutti. Diamole allora qui il giusto saluto gaddiano: Peperepè!).
Questa volta inizio da Piazza del Popolo. E punto subito sulla chiesa di Santa Maria del Popolo in compagnia mentale dell’Ingegnere. Qui, nella chiesa che tanto amava, Gadda ha ricevuto l’ultimo saluto. Tripudio di Pinturicchio e Bernini all’interno. Nella cappella di sinistra c’è il suo Caravaggio, l’altro Gran Lombardo, «fuggitivo, blasfemo e violento», oggetto di una intensa predilezione. Gadda ha scritto su questi dipinti, La conversione di san Paolo e la Crocefissione di san Pietro più volte in scritture pubbliche e in quelle private poi pubblicate. Nel Pasticciaccio scrive di « Paolo atterrato dalla folgore: raccorciato, nanificato a terra dalle leggi inesorabili della prospettiva. Tutto il quadro occupato dalla Bestia!» Mentre si legge in una nota di Meditazione milanese : «La contemplazione delle tele dei miei autori preferiti (p.e.Caravaggio) desta in me una vera ebbrezza mista a gratitudine». In un altro passo, che non riesco a trovare, scrive degli allucioni dei piedi di San Pietro. Ma dove? Accidenti a quando non si ha avuto l’ardire di sottolineare il testo con la matita.
Cos’era la scrittura per Gadda, mi domando cercando di ricordare un passo letto chissà quando. Parla di risentimento, di vendetta. Quando torno a casa devo riprenderne il passo, penso. Eccolo.
Nella mia vita di « umiliato e offeso » la narrazione mi è apparsa, talvolta, lo strumento che mi avrebbe consentito di ristabilire la «mia» verità, il «mio» modo di vedere, cioè: lo strumento della rivendicazione contro gli oltraggi del destino e de’ suoi umani proietti: lo strumento, in assoluto, del riscatto e della vendetta. Sicché il mio narrare palesa, molte volte, il tono risentito di chi dice rattenendo l’ira, lo sdegno. Di ciò domanderei perdono a Dio, e magari alle creature, se Dio e le creature potessero garentirmi di non ripetere, in avvenire, gli scherzucci del passato. Domanderei e domando comunque perdono, poiché se gravi sono state le offese immeritamente patite, gravi sono stati anche gli errori dipoi commessi. Molti errori ho commesso: dopo e in conseguenza dei turbamenti che le offese avevano generato in me: tanto da rendere accettabile a mio vantaggio quella sublime osservazione del Manzoni, quando giudica di Don Rodrigo, e di Renzo in furie: «chi fa il male è responsabile non soltanto del male che ha fatto, ma dei turbamenti nei quali induce l’animo degli offesi». (I viaggi la morte).
Ecco uscendo – l’ombra secentesca della Chiesa ancora negli occhi – lo sfavillio della luce della grande e bellissima piazza. Un novembre che sa ancora di ottobre romano. È normale andare verso Rosati. Quanto cinema e quanta letteratura su questi tavoli. Rammento solo i miei Vitaliano Brancati ed Ercole Patti, habitués, e Alberto Arbasino che li ricorda con rispetto e affetto entrambi nell ‘Anonimo lombardo. Via dell’Oca è dietro Rosati. Non più di cinquanta metri di strada, e lì c’è tutto lo spirito di Moravia aleggiante nell’aria. Mi chiedo: aveva poi ragione Moravia quando diceva (Intervista sullo scrittore scomodo , a cura di Nello Ajello) che la prosa di Gadda gli ricordava il dolce romano dei pignoccati, cioè molto dolce, da prendere a piccole dosi, e che il genio linguistico di Gadda era la sua forza e il suo limite? Forse sì. Gadda non si può leggere che a spizzichi. Ma se ne ha voglia spesso. Rubandogli magari anche qualche battuta memorabile, come fece la creativa Annamaria Testa che riprese dal Pasticciaccio quello “sfrizzola il velopendulo, titilla la papilla” che adottò come claim per la pasticca Golia. Ma Moravia è stato colpevolmente dimenticato. Italiano standard il suo, prosa referenziale e priva di spasmi dialettali e attorcigliamenti linguistici, lingua da annunciatore televisivo, ferroviario, ma pulitissima, e alla fine espressiva. Una balla che sia uno scrittore tradizionalista, da contrapporre agli sperimentalismi linguistici e stilistici dell’Avanguardia. Uno che si inventa un esperimento formale arditissimo, quello di portare il teatro (unità di tempo, di luogo, di azione) nel romanzo: questo è Gli indifferenti. Che scrive sotto voce femminile, che si inventa una seconda persona rispetto alla classica prima e terza tradizionali. Cos’è infatti quella strana intelaiatura della Vita interiore, una intervista dove a parlare è non un io né un egli, ma un tu. E anche fuorviante dopotutto quella contrapposizione di Gian Carlo Roscioni (Capitolo “Cos’è un generale” nella Disarmonia prestabilita ) tra un Moravia bidimensionale, convenzionale, fenomenico e un Gadda a tre dimensioni, prismatico, picassiano, noumenico. Moravia ha scritto in una lingua pulitissima e ha avuto il merito di aprire la camera da letto e i traffici che vi si compiono a quei furboni degli italiani, controriformistici, sporcaccioni, e ipocriti, che lo hanno cercato da vivo ( ne hanno cercato lo scandalo soprattutto da La noia in avanti) e l’hanno dimenticato da morto. Vigliacchi. Moravia contro Gadda? Scherziamo. Li voglio tutti e due.
Imbocco via Ripetta. C’era un porto a due passi da qui nel fiume. In un palazzo davanti a me la lapide che ricorda Eleonora Fonseca Pimentel, morta nel MDCCIC. Da riprendere quel grande romanzo che è Il resto di niente di Enzo Striano le cui prime battute prendono avvio proprio da questo palazzo. Ma sì, tornano vecchie suggestioni. lo spazio, come il tempo, non è momento secondario nell’universo del romanzo. La Parigi cui Rastignac lancia la sfida «E adesso a noi due!», il Mediterraneo per Odisseo o la città di Dublino per Leopold Bloom non sono elementi esornativi, una semplice quinta per l’azione. Si vorrebbe dire che talora non le storie, non i personaggi, sono essenziali al romanzo, bensì i luoghi, le atmosfere morali, intellettuali e sociali da esse emanate, e che nel romanzo moderno sia la più grande preoccupazione per un artista rendere proprio la Berlinenluft o l’esprit de Paris, che insomma siano proprio Berlino, Parigi o Vienna le vere protagoniste nei romanzi di Döblin, Balzac, Musil. Niente di più della cattura dello spirito di un luogo (non solo paesaggistico, ma sociale, morale) ci fornisce informazioni precise sul “senso del reale”di un artista. In quanto carne ed ossa un romanziere è ciò che ha visto, vissuto, mangiato: una ragione e un sentimento imbevuti di sangue. Non si può essere siciliani (parigini, colombiani, russi)… e far finta di niente. L’io è un avverbio di luogo, diceva Pessoa.
Più avanti, sono già in via della Scrofa, palazzo Scipione Gonzaga, al civico 117 lapidi che ricordano i soggiorni di san Luigi Gonzaga e Torquato Tasso. Del Santo ricordo una lettura infantile della sua vita. Pura agiografia, cattolicissima. Colonizzazione del tempo e dell’immaginario infantile. Dopo la fatica della dottrina, la “lettura amena”: le vite dei santi. San Luigi si festeggia il giorno della mia nascita, il prete mi fece dono di quel libro. Sconfortanti e lugubri le vite dei santi barocchi. Ci sono giovinetti che muoiono a ventitré anni per morbi che oggi verrebbero curati da un semplice antibiotico. Santo ricordato col giglio: famiglia bene, eh, tanto forte da esulcerare il dolore privato, intensissimo, in commemorazione pubblica e usucapione di data nel calendario. A San Luigi de’ Francesi non è possibile vedere l’altro Caravaggio. È sabato e la chiesa è chiusa. Non la libreria francese a fianco. Uno sguardo ai libri: un cofanetto di Dominique Fernandez, Dictionnaire amoureux de l’Italie (ill. Alain Bouldouyre), Plon, 2 voll.). Non resisto accidenti: finirò con il rovinarmi coi libri. Non in senso economico: ne leggo di più di quelli necessari per vivere. Sono sciccherie da sardanapali, da sibariti dello spirito queste, che io non mi posso assolutamente permettere. Il mio filisteismo esonderebbe in un estetismo che mi repelle.
Decido di flanellare per il centro barocco senza meta col peso sottobraccio. Mi fischiano nelle orecchie le note di “Cento campane” cantata da Nico dei Gabbiani (ma pezzo forte di Lando Fiorini), colonna sonora dello “scemeggiato” come lo chiamavo io, “Il segno del comando” di Daniele D’Anza, interpretato da Ugo Pagliai e Carla Gravina. Io poco più che adolescente, con gli occhi sbarrati nel mistero e nelle ombre di questa Roma barocca (produzione RAI 1971, bellissimo, notturno e misterioso sceneggiato tutto girato per queste strade). (vedi su Youtube i luoghi dello sceneggiato)
Nun me lo di’ stanotte
a chi hai stregato er core
la verità fa male
lasciame ‘sta visione pe’ spera’
din don din don amore
cento campane stanno a di’ de no
ma tu ma tu amore mio
se m’hai lasciato ancora nun lo di’
no nun lo di’ nun parla’
sei una donna o una strega chissà?
Me resta ‘na speranza, la speranza di quer sì…
Campo de’ Fiori, Palazzo Farnese (l’ambasciata francese dove ai tempi di Berlusconi e dei Berluscloni m’è venuta voglia di chiederne la cittadinanza), Via de’ Giubbonari, andirivieni, stradine sghembe, altre smarrite o imboccate a caso e poi, non so come, sbocco in pieno drammatico Novecento, via Caetani: uno sguardo alla lapide di Moro, con quei capelli in fiamme che dovrebbero ricordarne la frezza bianca, ed
esco da via delle Botteghe oscure. Ricordi di passate stagioni, di giovanili impegni politici, di attese di risultati elettorali da quei balconi romani (c’è anche quello, ben più fatale, di Piazza Venezia). Ricordi che non piacciono ai due terzi degli italiani che amano raccontarsi la storia che siamo stati sotto il giogo, immaginario, del comunismo, dimenticando il ventennio, reale, fascista.
I piedi gonfi, tre ore di marcia, il cervello in fiamme, il cuore colmo di gioia.
E una considerazione finale.
Questo è il centro storico di una capitale europea meglio conservato in assoluto. Praticamente intatto: bellissimo. Se andate in giro con La cugina Bette di Balzac in mano in quei quartieri descritti nelle prime pagine del romanzo attorno a Place du Carrousel, ebbene, non c’è più nulla. Il centro a tela di ragno del vieux Paris, già cantato da Baudelaire ne Il cigno, è stato raso al suolo, molto più della Roma medievale
sventrata tra piazza Venezia e il Colosseo per metterci quella macchina per scrivere che è il Vittoriano e quella carrozzabile per mezzi cingolati che è via dei Fori Imperiali. Parigi è stata spianata dal barone Haussmann per ragioni strettamente politico- militari. Dopo quasi un secolo di rivolte e di quelle barricate facili da erigere con materassi e masserizie da quelle teste calde delle masses ouvrières e dopo l’ennesimo émeute del 1870, le Pouvoir la pensa giusta: buttiamo giù tutto. E al posto del reticolo di viuzze, grandi esplanades e boulevard, di modo che ti piazzo un cannone qui e uno dal lato opposto, e adesso provate a fare una barricata, canailles!



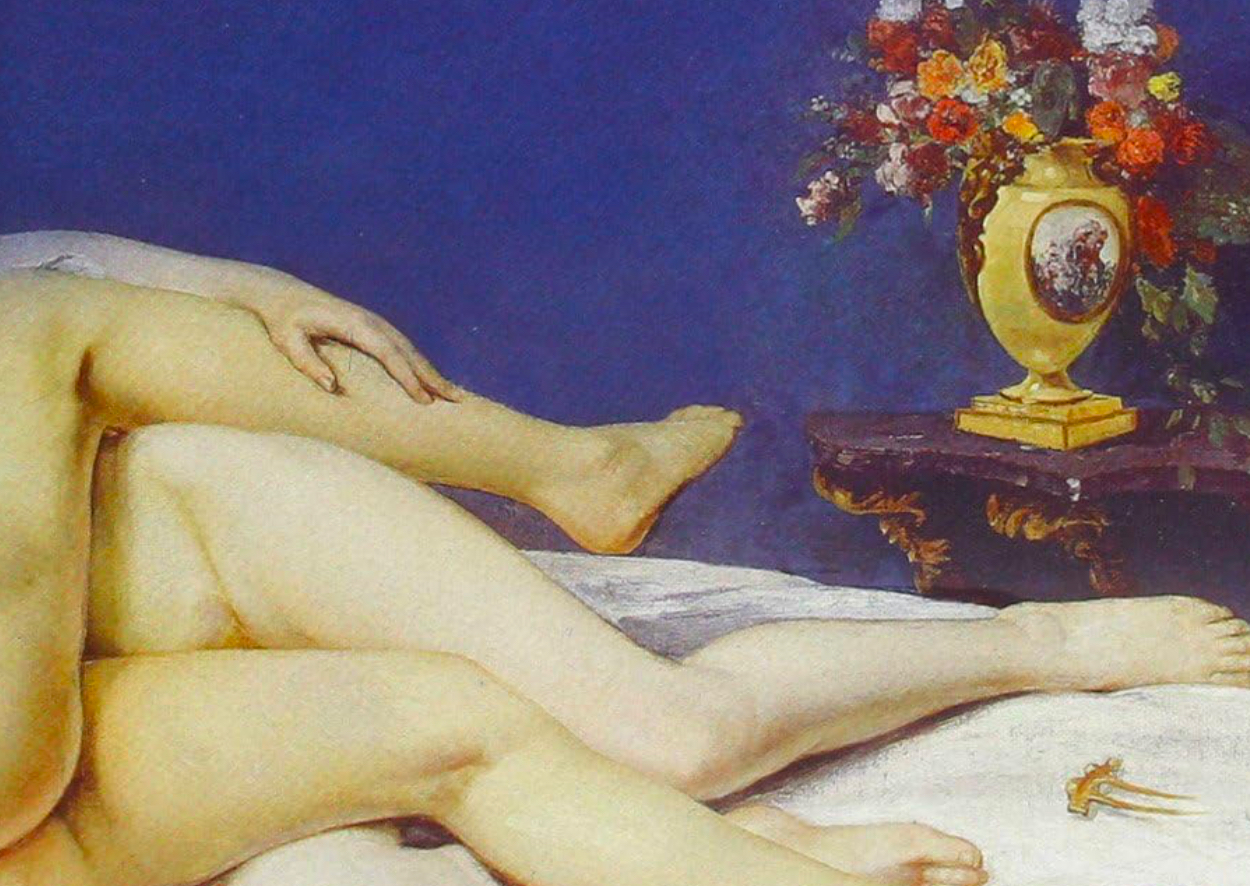


Devi fare login per commentare
Accedi