Roma
Perché a Roma lo sfidante di Virginia Raggi ha perso così male
La capitale d’Italia ha eletto il primo sindaco donna della sua storia. La grillina Virginia Raggi, già ampiamente in vantaggio al primo turno, ha letteralmente surclassato il suo sfidante. Il gergo oggi in uso vorrebbe l’utilizzo del termine “asfaltato”, ma forse anche noi commentatori più o meno schierati dovremmo iniziare a non assecondare questo abuso scellerato e un po’ volgare di certe metafore, dato che si era partiti con la rottamazione e si è arrivati troppo velocemente al lanciafiamme (quindi per gli ordigni al napalm il passo potrebbe essere breve). I numeri della disfatta sono stati impietosi: la candidata grillina, giovane avvocato romano, ha staccato il suo competitor di ben 393.628 voti, l’equivalente di 34,3% punti di vantaggio. Un dato inequivocabile che se approfondito confrontando i risultati nei quindici municipi, disegna una città dove il Pd e il centrosinistra resistono nel centro storico e nei quartieri dove abitano i ricchi (gli unici municipi dove vince a fatica sono il primo e il secondo), ma viene doppiato nelle periferie dell’extra GRA, nelle borgate, nei quartieri popolari.
I motivi di questa debacle sono tanti. Alcuni hanno radici antiche, altri sono assai più recenti. Ho provato a metterli in fila, portando il mio personale punto di vista e ordinando gli appunti presi nel corso di questi mesi di campagna elettorale iniziata con le primarie e finita nella sede del Comitato dello sfidante nei locali dell’Ex Dogana, in via dello Scalo di San Lorenzo, dove i numeri drammatici degli exit poll erano accompagnati dal cacofonico concerto di tale Noyz Narcos, che alle 23 in punto iniziava a urlare nello spazio esterno mentre centinaia di giovanissimi fan facevano uso massiccio di marijuana, appesantendo un’aria già pesante e insalubre. Qualcuno, chiudendo le finestre con fare proibizionista, ha detto: «quello è il paese reale». Io spero francamente che in giro ci sia anche di meglio… Ma iniziamo il racconto.
PREMESSA. C’ERA UNA VOLTA IL PARTITO DEMOCRATICO, AMMESSO CHE SIA MAI STATO UN PARTITO
“C’è un dato nazionale”. Una frase che in queste ore avrò sentito ormai centinaia di volte. È vero: se una sconfitta a Roma era quasi scontata, seppur non con questo scarto, quello che è accaduto in altre grandi città ci dice che la velocità con cui Renzi si è imposto sulla scena politica italiana è la stessa velocità con cui potrebbe iniziare il suo declino. L’analisi sarebbe lunga e articolata, ma il punto centrale è l’impostazione di un partito politico totalmente plasmato sul suo leader, sulle sue fortune e sulle sue sfortune. Un partito dove sono sempre meno chiare tanto la forma, quanto la sostanza. È evidente che il PD non sia più una forza politica in cui alcune categorie di persone, di lavoratori, di pensatori si riconoscono. Lo dimostrano una serie di sconfitte simboliche nei comuni e nei quartieri delle grandi città che un tempo erano roccaforti della sinistra e oggi vedono nel Movimento 5 Stelle e nella Lega Nord i nuovi “partiti del popolo”. Lo dimostra la sconfitta di Torino, una città amministrata ottimamente da Piero Fassino, travolto non per suoi demeriti ma perché percepito come “uomo di Renzi”.
Ad onor del vero, il processo di personalizzazione della politica non inizia certo con Matteo Renzi e non è un fenomeno solo italiano. Ma Renzi è oggi uno degli interpreti più spregiudicati di questo modello. Il problema è che i leader passano. Possono durare anche vent’anni ma se dietro di essi non c’è qualcosa di duraturo e di chiaramente identificabile, il cartello elettorale che utilizzano per promuoversi finisce con loro. E oggi il Pd è più un cartello elettorale che un partito, una sommatoria di personale politico misto che con il passare del tempo perde sempre più il contatto con la società, chiudendosi in un autoreferenziale dibattito interno incomprensibile e urticante per chi dall’esterno prova a seguirlo.
Tra i suoi fedelissimi e acritici sostenitori, c’è già chi afferma che “Renzi a Roma non è mai arrivato”, che ora dovrà scendere col famigerato “lanciafiamme” e azzerare tutto. Il racconto però non è intellettualmente onesto e sotto sotto lo sanno anche i renziani della primissima ora. Renzi a Roma è arrivato così come è arrivato a Napoli e in tanti altri luoghi d’Italia, ma ha fatto male. La verità è che il vincitore delle primarie dell’8 dicembre 2013 non ha mai davvero svolto il ruolo di segretario del Partito Democratico, ha solo gestito i territori affiliando a Leopolda s.p.a. i gruppi di consenso preesistenti. Il resto è “cerchio magico” e poco altro.
Renzi non si è occupato del PD, se non quando le “conte interne” lo hanno imposto. Ha cercato di controllare le nomenclature locali assicurandosi che le posizioni apicali fossero ricoperte da persone a lui fedeli o al limite a lui affiliate. Non sempre gli è riuscito. A volte è stato costretto a cedere il campo per evidente impraticabilità come in Puglia, feudo di Emiliano, altre volte – vedi il caso di Napoli, ma in parte anche quello di Roma – il forzare la mano lo ha portato a sonore sconfitte.
Il Partito Democratico e Matteo Renzi sono dunque a un bivio. Se non capiranno in fretta che non sono l’uno proprietà dell’altro, prima o poi spariranno entrambi. Nello stesso giorno.
IL PARTITO DEMOCRATICO E ROMA. MAFIA CAPITALE, MARINO, ORFINI, LE PRIMARIE…
Come è innegabile che ci sia il “dato nazionale”, è altrettanto chiaro che quel dato nella capitale sia stato fortemente accentuato da una situazione già compromessa ancor prima del fischio d’inizio.
Il Partito democratico di Roma, figlio dei partiti che si fusero al suo interno, soffre il fascino indiscreto dei palazzi del potere; è sempre stato così. Ricordo gli anni in cui, poco più che adolescente, iniziavo a frequentare le sezioni del PDS e la Sinistra Giovanile. Ricordo le assemblee nelle scuole e nelle facoltà universitarie, i direttivi a Botteghe Oscure e la naturalezza con cui alcuni miei coetanei si definivano “dirigenti politici”, un termine che mi ha sempre fatto un po’ sorridere, soprattutto quando entrato nel mondo del lavoro mi sono confrontato con la realtà di chi deve davvero svolgere un ruolo dirigenziale: personale, budget, spazi, tempi, obiettivi. Ed è ovviamente retribuito per farlo.
Il potere tocca alcune delle corde più scoperte dell’animo umano. Chi non è abituato a conviverci ne diventa dipendente. È il caso di molte persone che lo hanno vissuto e lo vivono come un riscatto, un modo per congedarsi dai margini della società i cui sono cresciute. Io penso che esista un solo modo per essere immuni al potere ed è quello di essere abituati al bello. Perché del potere affascina intimamente l’estetica degli affreschi nei suoi palazzi, le condizioni economiche che possono derivare dall’occupare posizioni di prestigio, nei casi più gravi il “lusso” di avere una scrivania e una segretaria nei locali di un municipio in periferia. In un paese e in una città dove ciò che è bello viene dimenticato, sia esso un monumento, un quadro, un’opera teatrale, una fotografia o un film, il potere pervade le menti, accieca, logora.
Nella capitale, centro indiscusso del potere politico, esso ha generato un’impostazione arrivista degli ambienti della politica. Non che questo non avvenga anche in altri luoghi, ma a Roma il fenomeno è cronico e irreversibile. Nei partiti si sono consumate – e si consumano anche mentre scrivo – guerre fratricide, agevolate da quella follia che è il voto di preferenza, grande cancro della politica italiana e fonte costante di corruzione.
Di queste guerre si è sfamato quel sottobosco che è emerso nell’inchiesta di Mafia Capitale. Una rete clientelare fondata sul voto personale, dove la corsa alla sottoscrizione (nel migliore dei casi) finalizzata a una contesa interna senza idee e obiettivi ha totalmente inaridito il tessuto associativo dei partiti, ridotti a sommatorie di comitati elettorali, filiere di consenso e poco più. E non è un caso che il collasso di quel sistema, ben rappresentato dai numeri schiaccianti di Roma, sia coinciso col crollo dei voti di preferenza dei candidati, come ha fatto notare Marco Carta all’indomani del risultato già indicativo del primo turno.
Da quel sistema e in quel sistema è nata la candidatura di Ignazio Marino e la sua breve e tormentata esperienza da sindaco. Chi oggi torna a parlare del “sindaco mandato via con le firme dal notaio”, dovrebbe forse confrontarsi con chi vive a Tor Sapienza, fare una passeggiata nei pressi del campo rom di via Salone, un viaggio sulla Roma-Lido. E se proprio non se la sentisse di scomodarsi troppo, allontanandosi così tanto, gli basterebbe arrivare a Torpignattara, al Pigneto, a Don Bosco. Chi oggi torna a parlare di quei giorni, chieda ai romani di Ignazio Marino e del suo operato.
Marino è stato un pessimo sindaco e malgrado nella sua giunta ci siano state persone molto valide e propositive come Marta Leonori, Estella Marino e lo stesso Daniele Ozzimo (che prima di essere coinvolto nelle inchieste aveva avviato un lavoro enorme sull’emergenza abitativa), la sua incapacità e il suo approccio sbagliato con la città sono stati tra i principali motivi della disfatta elettorale del centrosinistra. Negarlo significa non aver capito cosa è accaduto a Roma negli ultimi anni. A questo proposito, consiglio vivamente la lettura dell’instant book “Roma fa schifo” di Enrico Pazzi.
Tra l’inchiesta di Giuseppe Pignatone e la cacciata di Marino a mezzo notaio, è arrivato il commissariamento del Partito Democratico di Roma affidato al presidente del Partito, Matteo Orfini. L’ex pesciolino rosso di Massimo D’Alema – come lo definii scherzosamente qualche mese fa – ha commesso più di un errore nella gestione del caso Marino. Il principale di questi è stato forse quello di lasciarsi coinvolgere nello scontro violentissimo tra l’ex sindaco e il Presidente del Consiglio. Alcune scelte volte a “normalizzare” la situazione si sono poi rivelate dei veri e propri boomerang, una fra tutte la nomina del senatore Stefano Esposito come assessore ai trasporti. E poi la gestione della crisi politica: c’era la possibilità di concluderla in aula Giulio Cesare senza dover ricorrere al notaio? Su questa domanda ancora oggi ci sono risposte contrastanti.
Infine il partito, passato al setaccio da Fabrizio Barca e dal suo staff. Che si condivida o meno il risultato di quel lavoro, la fotografia che emerse suggeriva un’operazione assai più coraggiosa di quella fatta dal commissario. In una sola parola, azzeramento. Azzeramento dei gruppi dirigenti dei circoli, anche di quelli “buoni”, perché figli anch’essi di congressi giocati su tesseramenti inquinati e accordi tra gruppi, ma anche azzeramento delle liste. Sarebbe stato un segnale forte dire ai romani: «non ricandideremo nessuno degli attuali eletti, sia in consiglio comunale che nei consigli municipali. Abbiamo chiesto a tante persone per bene di fare un passo indietro per mandare un messaggio chiaro alla città». Orfini non ha affondato il colpo, in parte perché è anche lui esponente di punta di una delle aree del partito, in parte perché le filiere di potere del partito romano, anche se molto indebolite, avevano ancora – proprio in quegli eletti – un radicamento sul territorio.
Le primarie per il sindaco, svolte in un contesto quasi invariato rispetto a quello precedente il commissariamento, erano probabilmente da evitare. Sono state uno strumento utile solo alle filiere per riorganizzarsi in vista della conta delle preferenze alle amministrative e non hanno neanche svolto la funzione secondaria di anticipare mediaticamente il voto comunale, anche per l’ingerenza di Renzi e di alcuni membri del governo, da Delrio a Gentiloni, che hanno provocato, forse senza volerlo, lo schieramento di tutte le suddette filiere sul vincitore designato.
Ad aggiungere al danno la beffa, l’aver permesso a un tizio con a seguito un orso di peluche di apparire su giornali e talk show. Un messaggio offensivo verso una città sofferente, dove se si abita nell’estrema periferia spesso non si hanno servizi basilari e bisogna tenere le finestre chiuse a causa dei fumi tossici che arrivano dai campi rom. Questo errore, pur in modo assai meno evidente, è stato ripetuto anche durante la campagna elettorale dello sfidante di Virginia Raggi.
Anche le primarie, così fatte, hanno quindi contribuito a una disaffezione dell’elettorato e di un numero consistente di militanti PD. A parte la scarsissima affluenza, le modalità con cui si sono svolte – dalle solite truppe cammellate al vergognoso sfruttamento del fine vita con le mobilitazioni dei centri anziani – hanno avuto un effetto negativo e respingente.
LA CAMPAGNA ELETTORALE. C’ERA UNA VOLTA LA COMUNICAZIONE POLITICA
Come era prevedibile, il vincitore designato è diventato quindi il candidato sindaco. A quel punto si sarebbe dovuto aprire il suo comitato elettorale ed estenderlo a tutta la comunità politica del centrosinistra. Questo non è stato fatto, se non in minima parte e con risultati non sempre soddisfacenti. Da una parte c’era dunque il PD (azionista di maggioranza della coalizione), dall’altra il comitato del candidato, due corpi troppo indipendenti che non hanno agito in sintonia.
La prima parte della campagna elettorale si è svolta esattamente come le precedenti, ma con mezzi economici nettamente limitati rispetto al passato (per ovvii motivi). Abbiamo così assistito alla solita corsa alle preferenze dei tanti candidati comunali e munucipali, arricchita solo in parte da iniziative “centrali” a sostegno del candidato sindaco organizzate con ciò che rimaneva dei militanti sul territorio. E poi c’era lui, il suo staff, l’immancabile agenzia di comunicazione Proforma di Bari, il grande guru di Obama, Jim Messina (…) e gli “esperti” di marketing politico dell’ormai calante new age renziana. Fin da subito le scelte fatte su qualche spiaggia di Polignano a Mare sono apparse chiare: la campagna di comunicazione dello sfidante di Virginia Raggi sarebbe stata incentrata sugli attacchi alla pentastellata (da qui il proliferare di hashtag su di lei, da #VirginiaScappa a #Raggiri), da una enfatica “narrazione” della grande opportunità rappresentata dalla candidatura di Roma alle Olimpiadi (del 2024) e, in seconda battuta, sullo Stadio della Roma. I punti programmatici del programma (buche, trasporti, scuola…) sono così passati in secondo, terzo e quarto piano, fino a diventare invisibili. Gli altri principali candidati (Fassina, Meloni, Marchini) sono stati invece trattati quasi con sufficienza e dati già per spacciati. E pensare che per poco più di 56 mila voti la candidata di Fratelli d’Italia non ha giocato un brutto scherzo a tutti. Postilla: la campagna di Giorgia Meloni è stata perfetta: le parole d’ordine gradite al suo elettorato erano chiare e accentuate in dei bellissimi video che avevano un retrogusto come dire… fascista.
A corredare il tutto, c’era un “simpatico” generatore di slogan sul sito del candidato per potersene fare uno personalizzato (grasse risate a Borgata Finocchio) e il cliccatissimo spot “Madechestamoapparlà!”, dove “un sindaco vero” recitava la parte di quello allergico agli spot elettorali. E qui ritorniamo al discorso già fatto in precedenza per il tizio con l’orso alle primarie: in una città in ginocchio il gioco non paga, anzi può essere visto come una mancanza di rispetto. Ma in quei giorni a Polignano a mare era già estate inoltrata, i bambini giocavano felici sulla spiaggia, c’era voglia di comunicare leggerezza. Il problema è che a Roma c’era gente che come ogni giorno passava ore in fila su via Boccea.
Fino al 5 giugno il copione è stato quindi il seguente: Virginia Raggi propone e dichiara, lo sfidante critica, irride, chiede confronti pubblici per dimostrarne l’inconsistenza, la attacca perché è contraria alla candidatura alle Olimpiadi (del 2024) e per i suoi trascorsi professionali. La strategia è apparsa fin da subito poco efficace e oltretutto si è inciampati in errori grossolani. Un caso fra tutti, la famosa funivia di Casalotti. Dopo che per giorni si è passati a “perculare” Virginia Raggi, organizzando persino un gruppo di persone vestite con tute da neve, scarponi e sci (in un giorno feriale, pessimo messaggio), si è scoperto che la proposta di quel comitato di quartiere era stata giudicata positivamente da (udite, udite) Walter Veltroni. C’erano poi gli attacchi costanti mossi alla grillina sul suo praticantato in uno studio della galassia Previti, insomma la si attaccava per aver lavorato, magari anche sottopagata come tutti i praticanti. Qualcuno, tra cui il sottoscritto, in quelle ore faceva sommessamente notare che forse si sarebbe dovuto centrare di più la campagna sul candidato e sulle sue proposte. Parole al vento. Sulla pagina facebook dello sfidante di Virginia Raggi, il nome della candidata grillina è ripetuto centinaia di volte, lui ne sembrava quasi ossessionato e questo, di lì a poco, avrebbe ispirato il geniale fotoromanzo “Virginia e Roberto”.
Si è arrivati così al primo turno, con dieci punti di distacco da recuperare in due settimane e confidando sugli elettori di Marchini, Fassina e Meloni. Cose che avvengono ormai solo in Francia, insomma. Prima di ripartire, ci si è confrontati nelle sedi politiche e anche il quel caso il sottosciritto – questa volta in compagnia di altri noiosi “rompiballe” tra i quali il Presidente della Regione Lazio – faceva notare che la campagna all’inseguimento di Virginia Raggi non avrebbe pagato. Altre parole al vento: tra Denver a Polignano a Mare si era già deciso di concentrare gli sforzi delle ultime due settimane nelle zone dove si era raccolto di più, abbandonando le periferie come un Ignazio Marino qualsiasi. Nel contempo, sarebbe partita una martellante campagna social al grido di “siamo solo io e lei, i romani scelgano” con cartoline web comparative sui tanti “no” della grillina e un drammatico volantino con un test alla Vanity Fair dove il nome “Raggi” compariva ben sei volte e in un caso si invitava persino a votarla. L’ho conservato, se avrò mai dei nipoti glielo mostrerò come un cimelio dei tempi difficili, come le cartoline di guerra dei nostri nonni. Ciliegina sulla torta, il call center improvvisato in diretta facebook con il Ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, per convincere gli indecisi. Non lo commenterò. Postilla: nel frattempo, ovviamente, la candidata del Movimento 5 Stelle azzeccava totalmente la campagna, postando contenuti di programma corredati da immagini rassicuranti.
Sul finale di partita, si attivava violentemente un altro tipo di campagna sulla stampa nazionale e locale. Non sapremo mai se e quanto ci sia stata una “manina” dietro il finto scoop di Repubblica sul voto alla Raggi di Massimo D’Alema. Palesemente inaccettabile è stato il presentare un retroscena che si reggeva su un chiacchiericcio, titolandolo come una dichiarazione. Poco dopo, a un giorno dal voto, la stessa testata ha enfatizzato (un intero giorno sulla homepage dell’edizione online) l’esposto fatto alla candidata grillina da un’associazione vicina al PD per la storia delle consulenze con la Asl di Civitavecchia (già uscita sul Fatto Quotidiano), con la procura che ha dovuto smentire l’apertura di un fascicolo a suo carico. Un capolavoro. Digressione: forse la direzione di Calabresi ha già bisogno di un tagliando? Ripeto: non so quanto si siano influenzate alcune scelte degli organi di stampa (in cuor mio spero per nulla), ma la campagna martellante contro Virginia Raggi da parte di alcuni giornali identificati dai suoi come megafoni dei “poteri forti”, ha avuto solo l’effetto di mobilitare l’elettorato grillino.
Ma la giornata di sabato 18 giugno ci ha regalato l’ennesimo “colpo da fuoriclasse”, con il “geniale” SMS arrivato casualmente a tutti gli elettori dell’indirizzario “Italia Bene Comune” (2013) dove si invitava a a non votare “il sindaco BUGIARDA” con tanto di video allegato già condiviso qualche ora prima dal vicesegretario del PD, Debora Serracchiani. Tempo poche ore e gli ultimi indecisi ex elettori dem decidevano definitivamente chi non andare a votare il giorno dopo. Oh yeah…
LO SCONTATO EPILOGO…
Mentre i titoli di coda di questo lungo racconto scorrevano impietosi domenica sera, lì all’ex dogana, il comitato elettorale più scomodo della storia dei comitati elettorali, riflettevo su questi lunghi mesi e iniziavo a riordinare questi appunti nella mia mente. Poche le cose che voglio salvare di questo periodo trascorso. Sicuramente resteranno i tour nelle zone più remote di questa immensa città (soprattutto durante le primarie, insieme a Roberto Morassut), l’esperienza pionieristica della web tv con le dirette facebook trasformate in veri e propri talk show (presto lo faranno tutti) e l’aver conosciuto alcune persone davvero valide, come la social media manager che diffondeva i contenuti, una vera forza della natura.
A circa un’ora dai primi devastanti exit poll, lo sfidante di Virginia Raggi e noi con lui, ha dovuto attraversare il concerto di Noyz Narcos per arrivare nel capannone dove ha ammesso la sonora sconfitta davanti ai pochi giornalisti rimasti per la pratica di rito. Trovarsi in mezzo a quel pezzo così violento di “paese reale” è stato come passare sotto le forche caudine. Perché la vera sconfitta, che si vincano o si perdano le elezioni, è quella di chi rinuncia a far evolvere le persone e le società, lasciandole in balia dei predicatori che si nutrono di rabbia, paure e istinti primordiali.
L’ultimo pensiero è andato a Roberto Giachetti, una persona per bene e forse non così empatica come qualcuno sperava. Una persona che forse, con tutto ciò che ho raccontato, c’entrava poco o nulla, anche se si è voluto accollare tutte le responsabilità della sconfitta dello sfidante di Virginia Raggi. In questi mesi ha perso un padre naturale e un padre politico, si è messo in gioco e ha dato quello che poteva dare. Un radicale, con tutti i pregi e i difetti dei radicali, messo a giocare una partita che probabilmente non avrebbe mai potuto vincere per l’impraticabilità del campo e per la debolezza della squadra costruita intorno a lui in quelle segrete stanze dove gli americani e i bagnanti di Polignano a mare hanno tirato la volata al primo sindaco donna della città eterna.





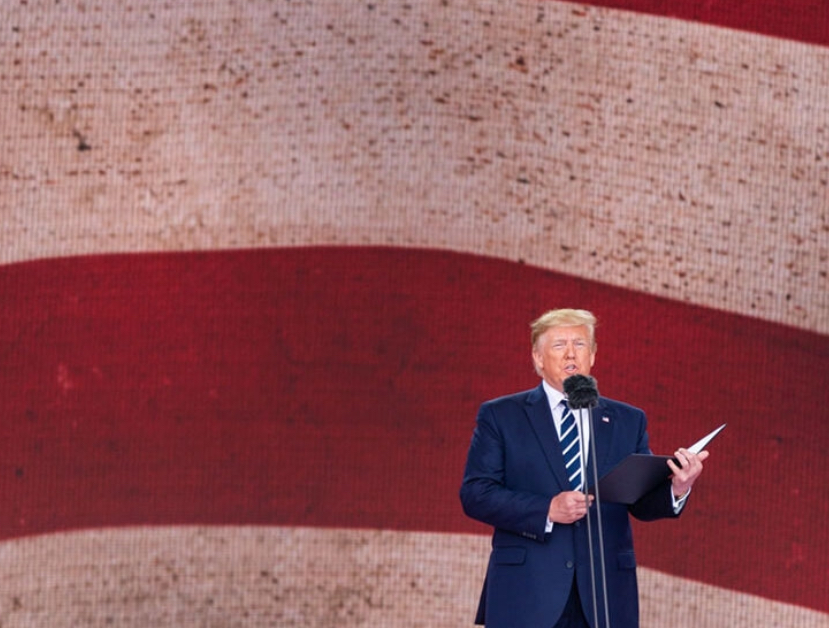
Devi fare login per commentare
Accedi